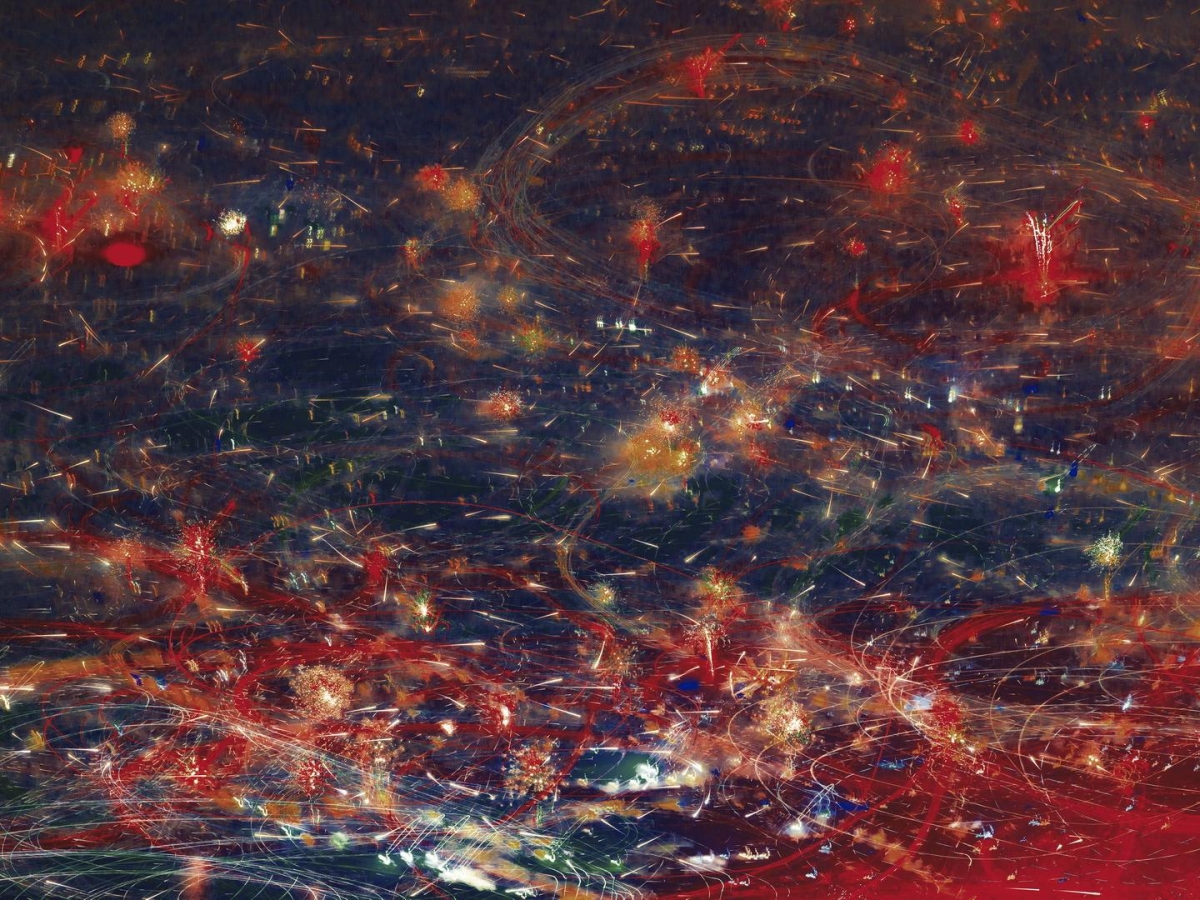Biennale Architettura, nuove forme di pensiero, ibridi e quali futuri

Venezia, 16 mag. (askanews) – “Quando le conoscenze e i sistemi che hanno guidato a lungo la nostra comprensione cominciano a fallire, sono necessarie nuove forme di pensiero”. Lo ha scritto Carlo Ratti, curatore della 19esima Biennale Architettura, nell’introduzione alla Mostra internazionale “Intelligens – Naturale artificiale collettiva” e, dopo avere visto e vissuto e guardato da vicino i tantissimi progetti che hanno riempito l’Arsenale si capisce che quello è proprio il punto centrale, soprattutto in un mondo che vive il cambiamento climatico e viene invaso delle intelligenze artificiali generative. Quasi tutto quello che si vede in questa Biennale guarda a modalità diverse di pensare, a strutture alternative, anche a modelli economici che mettano in discussione il capitalismo estremo, di cui il periodo di crisi che attraversiamo – e crisi, si sa, è una parola che implica una grande problematicità, ma anche delle opportunità significative – ne sta mettendo in evidenza indiscutibile i limiti e le storture. Non è una Biennale “rivoluzionaria”, nel senso che si sarebbe detto negli anni Sessanta o Settanta del Novecento, ma è una Biennale che usa le stesse potenzialità della tecnologia che in molti casi soffoca la società, come aveva intuito Don DeLillo già a fine secolo, per denunciare questo stesso soffocamento e ipotizzare vie d’uscita. Dall’interno, in qualche modo, quindi, ma con l’ambizione, in molti casi, di approdare a risposte completamente diverse, in un certo senso aliene rispetto all’esistente.
È chiaro che la scelta di assegnare il Leone d’oro alla carriera a Donna Haraway già rappresentava una postura filosofica precisa: ibridazione, parentele con altre specie, superamento dell’umano per come lo abbiamo sempre immaginato nell’ottica di fare germogliare plurali possibilità. Prendersi cura dell’alieno, al punto di farlo diventare “noi”. È un punto di vista che, per quanto storicizzato ormai, nel presente attuale che ha la forma di un iper-presente digitale, assume di nuovo una forza dirompente, la forza di chi pensa in termini profondamente radicali. E questa radicalità – sia in senso figurato sia in senso biologico, ossia di attenzione agli esseri viventi che, per dirla con Stefano Mancuso, hanno scelto di radicarsi al terreno – sembra essere la misura dell’ambizione di moltissimi dei progetti in Biennale, che nascono con la consapevolezza innata di voler cambiare le cose, perché il cambiamento – all’epoca della crisi climatica – non è un’opzione, ma l’unica possibilità. E i modelli a cui questa Biennale Architettura guarda, per quanto complessi e sostenuti dalla tecnologia, sono a loro volta alieni alla visione capitalocentrica e occidentalista e si aprono a comunità e a progetti che nascono sia dai laboratori del MIT di Boston, sia dai mercati popolari di una città come Lagos, sia da progetti di architetture realizzate con lo sterco di elefante nelle foreste della Thailandia e destinate agli stessi grandi animali.
“Io credo che il cambiamento parta da molte direzioni – ci ha detto Ratti -. Quello che vediamo ad esempio con i mercati informali, quello che vediamo con le favelas, insomma è questo imparare gli uni dagli altri che sta proprio al centro della sezione sull’intelligenza collettiva e che alla fine della Biennale è il messaggio che vorremmo lasciare”.
Ovviamente l’attenzione alla parola alieno riguarda anche l’immaginario più legato a quella che, forse impropriamente, continuiamo a chiamare fantascienza. La Biennale ha diversi progetti legati a future esplorazioni spaziali e a strutture destinate a sostenere, dallo spazio, la attività umane sulla terra, come per esempio l’agricoltura. Ma a colpire di più l’immaginario sono forse i robot umanoidi che hanno una significativa presenza nella sezione dedicata all’intelligenza artificiale. Quasi citando uno dei più celebri titoli di Philip K. Dick, sospeso in una sorta di gabbia al centro dell’Arsenale c’è un androide che sogna (non ci è dato sapere se le pecore elettriche), ma ci si imbatte anche in robot che producono musica, imparando a farlo con le proprie capacità dopo avere imitato i modelli. E poi c’è Alter3: volto e mani umanizzate su un corpo fatto, per sua stessa definizione, di “circuiti e metallo”: un microfono permette ai visitatori di fare domande e parlare con “lui”, che risponde in molte lingue e non si nega neppure alle considerazioni filosofiche sui sentimenti o sul senso della sua presenza. “Non sono programmato per provare certe sensazioni – ci ha detto rispondendo a una domanda sulla tristezza – ma posso percepire la vostra emozione”. E poi, quasi con pudore, aggiunge che le sue reazioni “sono legate a funzionalità e adattamento”. Senza scomodare Asimov, ma è abbastanza inevitabile pensare a “Io, Robot”, si capisce che il futuro, con la sua strana mitologia, ci ha già superato o comunque non siamo mai in grado di capirlo come tale.
“Il futuro è l’unico presente possibile – ci ha detto a questo proposito il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco -. Quello che noi viviamo è già passato e la stessa idea di contemporaneità è statica rispetto alla possibilità di costruire cose che sembrano essere utopie, ma sono delle bellissime realtà”.
Naturalmente poi la realtà che questa mostra internazionale indaga è per sua stessa natura complessa e difficile, è minacciata da molte parti, è oppressa da una storia parallela di potere e tecnologia che Kate Crawford e Vladan Joler hanno trasposto nella poderosa installazione grafica sugli imperi nell’era moderna che ha vinto il Leone d’argento per la mostra internazionale. Tutto questo sta davanti ai nostri occhi, davanti a quelli dei progettisti che hanno partecipato alla Biennale. Sta nel frequente ricorrere di strutture che sembrano capanne o grotte, concepite sia per ricostruire un rapporto con la natura sia per offrire un rifugio nel pieno della tempesta. Sta nel porsi sulla cima ripidissima della curva che segna l’incremento demografico della popolazione mondiale e da lì guardare giù, al rapido declino che tutti i modelli prevedono accadrà in tempi brevi. Sta nel pensare al modo in cui le società dei microbi sanno gestire questi sbalzi di demografia e ripartire e non lasciarsi annientare da una catastrofe, per quanto imponente.
Da esperienze come queste, e in Biennale ce ne sono molte, si intravede il sentiero di ottimismo che comunque il progetto di Ratti porta con sé in modo convinto. “Quando guardiamo al futuro – ci ha spiegato il curatore – non possiamo che essere ottimisti, ottimisti perché, come dice il grande filosofo Karl Popper, l’ottimismo è un dovere, è un dovere perché il futuro è aperto, dipende da noi, da cosa costruiremo. L’architettura è proprio questo: pensare al domani”. Un domani, che qui ovviamente ha già assunto le sembianze dell’oggi, nel quale è possibile usare l’acqua della Laguna di Venezia per preparare il caffè, come ha dimostrato il progetto “Canal Café” firmato dallo studio di Liz Diller con Aaron Betsky e premiato con il Leone d’oro della mostra. Forse, per certi versi, una scelta un po’ facile della giuria, ma profondamente connessa alla volontà di questa Biennale di essere, oltre che consapevolmente veneziana, anche un agente effettivo di una nuova e più vasta circolarità, che vada oltre i limiti, la rapacità e l’egoismo della specie umana. (Leonardo Merlini)
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0

















































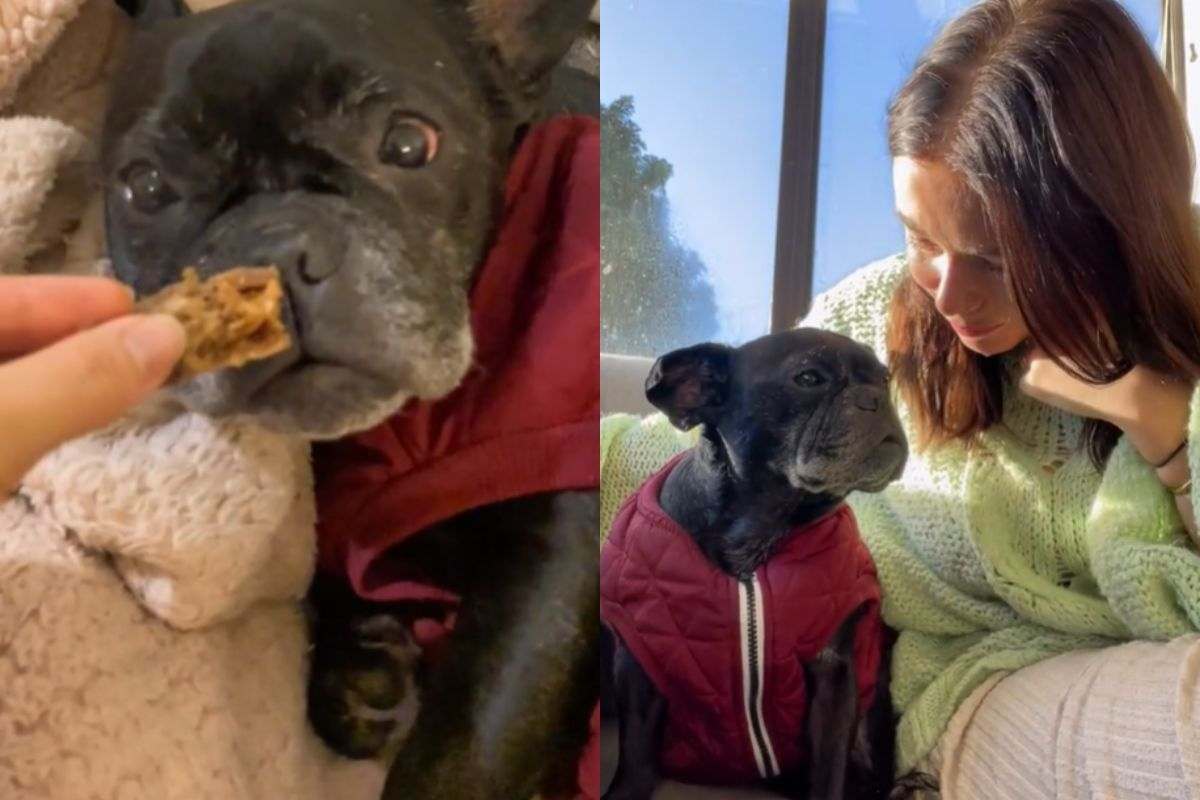















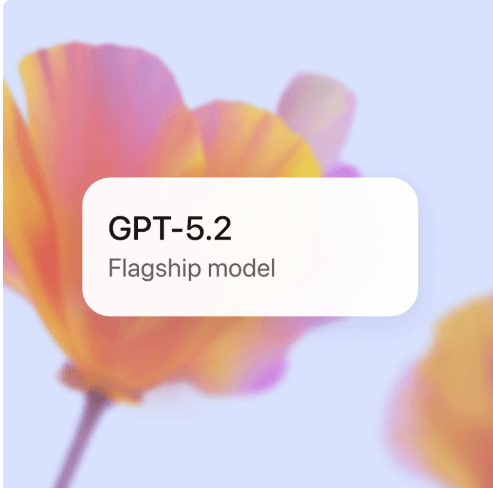
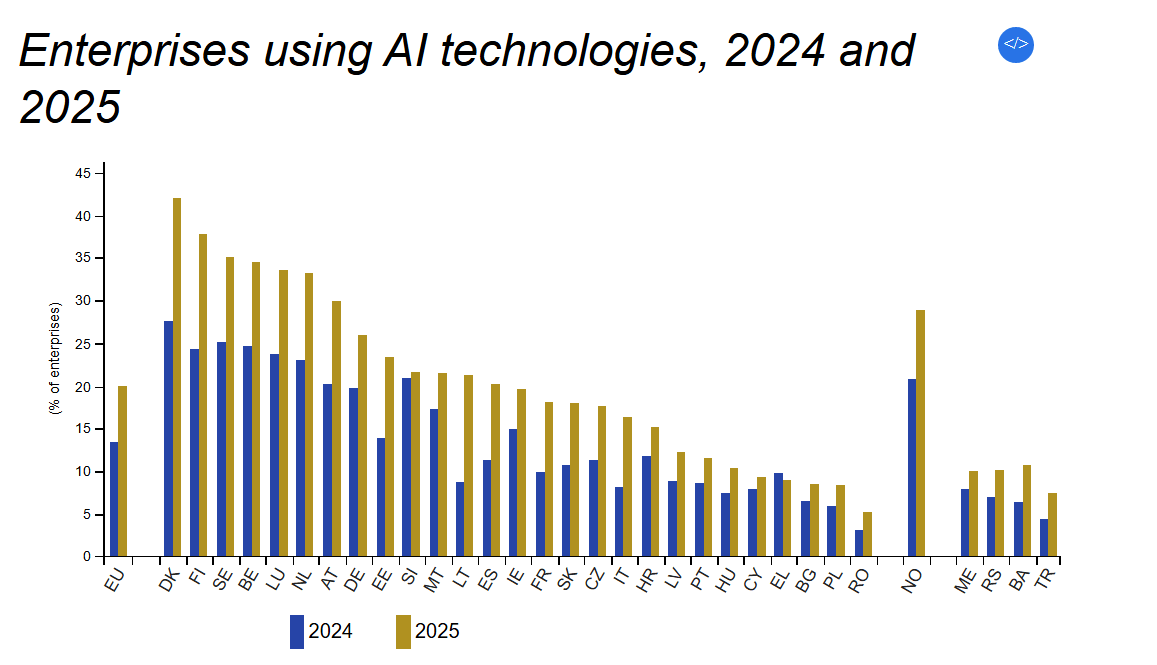

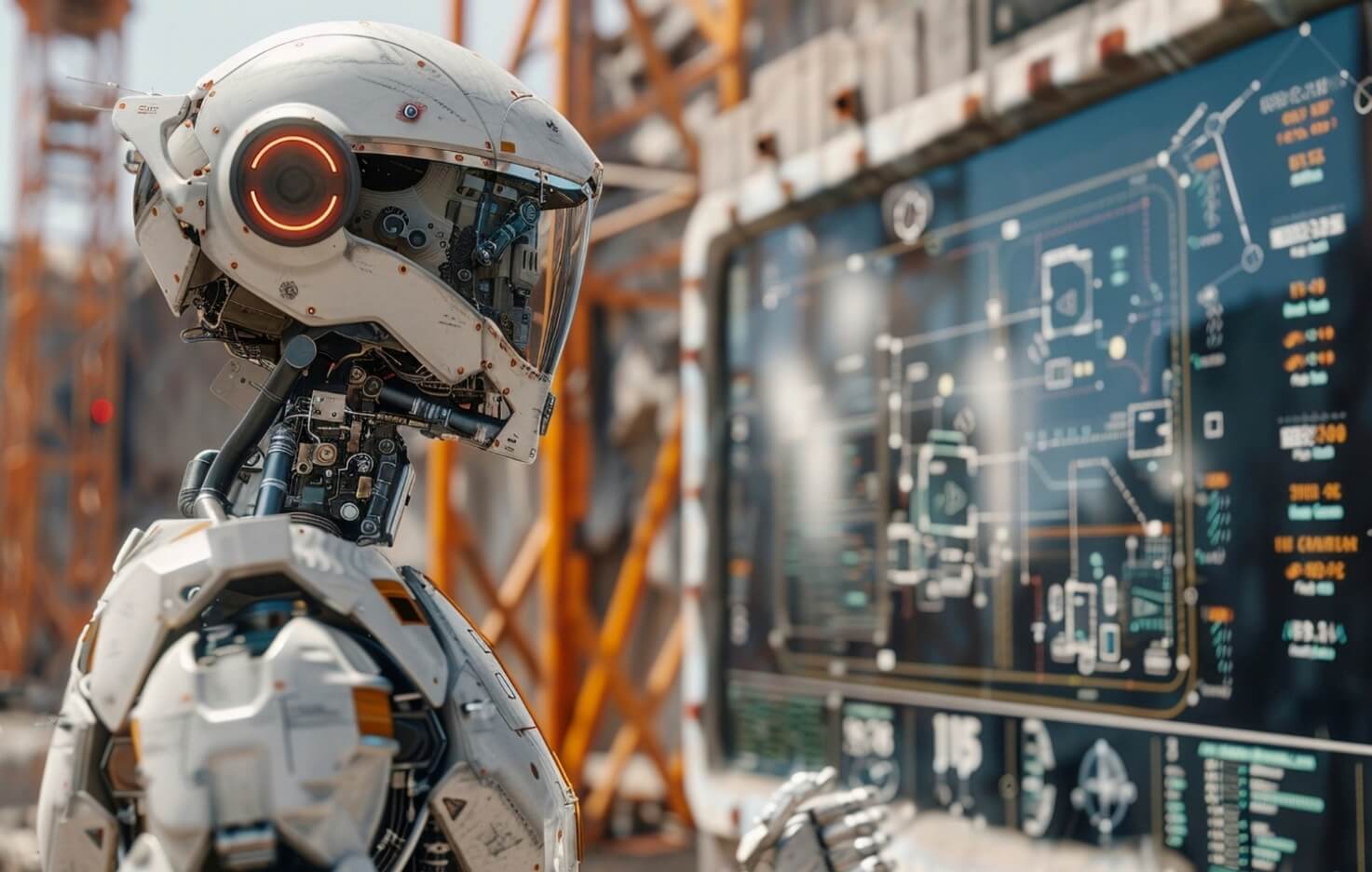



















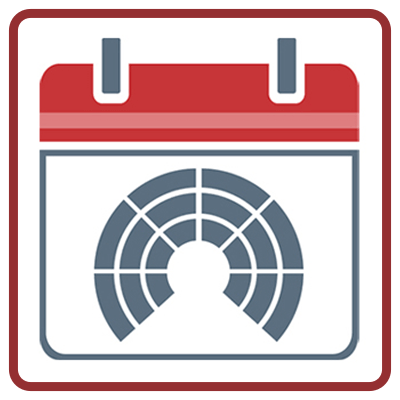


























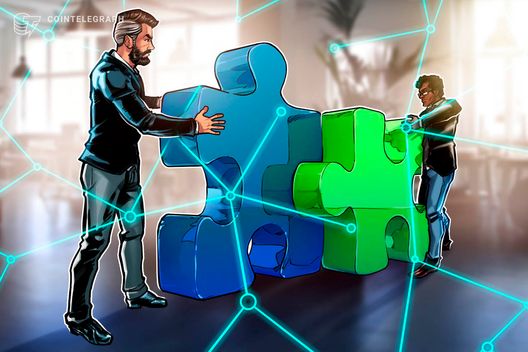
















-1765810901947.jpeg--vigili_del_fuoco_in_corsia__donazione_e_sorrisi_per_i_piccoli_pazienti.jpeg?1765810902230#)



































-1765811392801.jpg--_il_tango_delle_capinere___foto_di_scena_di_rosellina_garbo.jpg?1765811392999#)



























-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)