India. Kahsmir: tensioni con il Pakistan sull’orlo del baratro

di Riccardo Renzi –
Nel momento attuale il conflitto tra India e Pakistan non è formalmente iniziato, ma si è avvicinato pericolosamente a quella soglia ambigua che nella letteratura strategica viene definita “zona grigia”. Si tratta di una fase intermedia, in cui la guerra non è ufficialmente dichiarata, ma nemmeno del tutto evitata. È uno spazio incerto, segnato da scontri armati limitati, operazioni coperte, minacce esplicite e dichiarazioni bellicose che, nel loro insieme, generano un clima di instabilità e di pericolo costante. A rendere questo stato intermedio tanto rischioso non è soltanto la sua ambiguità, ma il fatto che qualsiasi errore tattico, provocazione locale o decisione affrettata potrebbe farlo precipitare in un conflitto su vasta scala.
La Linea di Controllo (LoC), che separa il Kashmir amministrato dall’India da quello sotto controllo pakistano, è da tempo un teatro di scontri. Negli ultimi giorni, gli scambi di artiglieria si sono intensificati, trasformando le montagne della regione in un fronte permanente di provocazioni militari. A rendere la situazione ancora più pericolosa è l’assenza di ogni meccanismo diplomatico funzionante. Le ambasciate sono ridotte a funzioni puramente simboliche, i canali di comunicazione militare sono intermittenti, e i vertici politici non si incontrano né direttamente né tramite terze parti.
In questo vuoto istituzionale, qualsiasi incidente, anche accidentale, rischia di degenerare in una crisi irreversibile. La sospensione del Trattato delle Acque dell’Indo da parte dell’India, subito dopo il gravissimo attentato terroristico del 22 aprile a Pahalgam, ha aggiunto un ulteriore elemento di frizione, toccando una delle questioni più delicate e vitali per il Pakistan: l’accesso alle risorse idriche.
L’escalation attuale, sebbene innescata dall’attacco terroristico nella valle di Baisaran, non può essere letta solo come una reazione difensiva. Piuttosto, è il risultato di dinamiche interne che premiano l’aggressività come mezzo per rinsaldare il consenso politico.
Da un lato, il governo indiano guidato da Narendra Modi si muove in un contesto di crescente tensione interna. Le proteste contro le politiche economiche e agricole, la polarizzazione sociale alimentata da una retorica identitaria e l’approssimarsi di elezioni cruciali spingono il BJP a rafforzare la propria immagine di “difensore della patria”. L’attacco terroristico ha fornito al governo centrale un’occasione per rilanciare una postura di forza: più che una risposta militare, un messaggio simbolico a tutta la nazione. La sospensione del Trattato dell’Indo, il rafforzamento militare nel Kashmir, l’espulsione di diplomatici pakistani e i test missilistici della marina sono segnali chiari di una strategia coerente con la narrativa dell’India “orgogliosa, coesa e sovrana”.
Dall’altro lato, il Pakistan attraversa una fase di collasso istituzionale. L’inflazione galoppante, la crisi del debito, la pressione del Fondo Monetario Internazionale e una leadership frammentata pongono il governo in una posizione precaria. L’esercito, vera colonna portante dello Stato, torna al centro della scena, sfruttando la crisi con l’India per riaffermare il proprio ruolo di garante della sicurezza nazionale. In questo contesto, anche il nazionalismo pakistano si rafforza: la difesa del Kashmir, concepita come parte integrante dell’identità islamica del Paese, serve da collante sociale e da valvola di sfogo contro il malcontento popolare.
Il rischio di una guerra nucleare, per quanto improbabile nel breve termine, non è affatto trascurabile. India e Pakistan possiedono arsenali nucleari simili per dimensioni, circa 170-175 testate ciascuno, e dotati di vettori terrestri, aerei e navali. A differenza dell’India, che storicamente ha aderito alla dottrina del “no first use” (mai colpire per primi), il Pakistan non ha mai assunto tale impegno, riservandosi il diritto di un uso preventivo in caso di minaccia esistenziale.
Recenti segnali provenienti da Nuova Delhi fanno però ipotizzare una possibile revisione di quella dottrina, alimentando i timori di un abbassamento della soglia nucleare. Se il messaggio è quello di una maggiore disponibilità all’uso dell’arma atomica, anche in risposta a un’aggressione convenzionale, il rischio è che si inneschi una spirale pericolosa di deterrenza incerta e percezioni errate.
Il vero pericolo, in questo caso, non risiede in una decisione lucida e premeditata di guerra, bensì in un’escalation non intenzionale. Il cosiddetto “equilibrio del terrore” si basa sull’assunto che i leader siano razionali. Ma se le dinamiche interne li spingono a mostrarsi irrazionalmente aggressivi, allora questo equilibrio rischia di diventare solo un’illusione.
La comunità internazionale appare impotente. Gli appelli alla moderazione lanciati da Washington, Pechino e Bruxelles si moltiplicano, ma nessuno dei due governi sembra intenzionato a fermarsi. Gli Stati Uniti, da tempo più vicini all’India, non possono permettersi di alienarsi completamente Islamabad, soprattutto in vista del ritiro strategico dall’Afghanistan e della lotta al terrorismo transfrontaliero. La Cina, alleata storica del Pakistan ma partner economico cruciale per l’India, si muove con prudenza, tentando una mediazione indiretta che finora ha prodotto solo comunicati generici.
Anche l’Iran ha proposto una piattaforma di mediazione regionale, ma la sua proposta è stata accolta con diffidenza da entrambi i fronti. In sostanza, manca oggi un attore terzo che possa fungere da “garante neutrale” e ricostruire un canale di dialogo tra Nuova Delhi e Islamabad.
L’attuale crisi tra India e Pakistan non è una guerra nel senso tradizionale del termine, ma rappresenta un conflitto politico, ideologico e psicologico che si combatte in uno spazio grigio, senza regole chiare né arbitri riconosciuti. È una guerra di nervi, di posture, di narrazioni. Ma come ogni conflitto latente, può degenerare in qualcosa di molto più concreto.
Né Modi né la leadership pakistana desiderano davvero un conflitto su vasta scala: le conseguenze umanitarie, economiche e geopolitiche sarebbero catastrofiche. Tuttavia, entrambi i governi sono prigionieri della loro stessa narrativa, intrappolati tra la necessità di mostrarsi forti e il timore di perdere la faccia. In questo contesto, il rischio più grande non è una guerra pianificata, ma una guerra accidentale.
Per questo, ogni ora senza mediazione reale è un passo verso il baratro. La zona grigia in cui ci troviamo oggi è una terra di nessuno, dove gli errori costano caro e dove il silenzio della diplomazia pesa più di mille colpi di cannone. Tocca ora alla comunità internazionale, con urgenza e lucidità, impedire che il subcontinente asiatico venga nuovamente trascinato nel vortice della guerra. Il tempo è l’unica risorsa che non si può negoziare. E sta finendo.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0





























































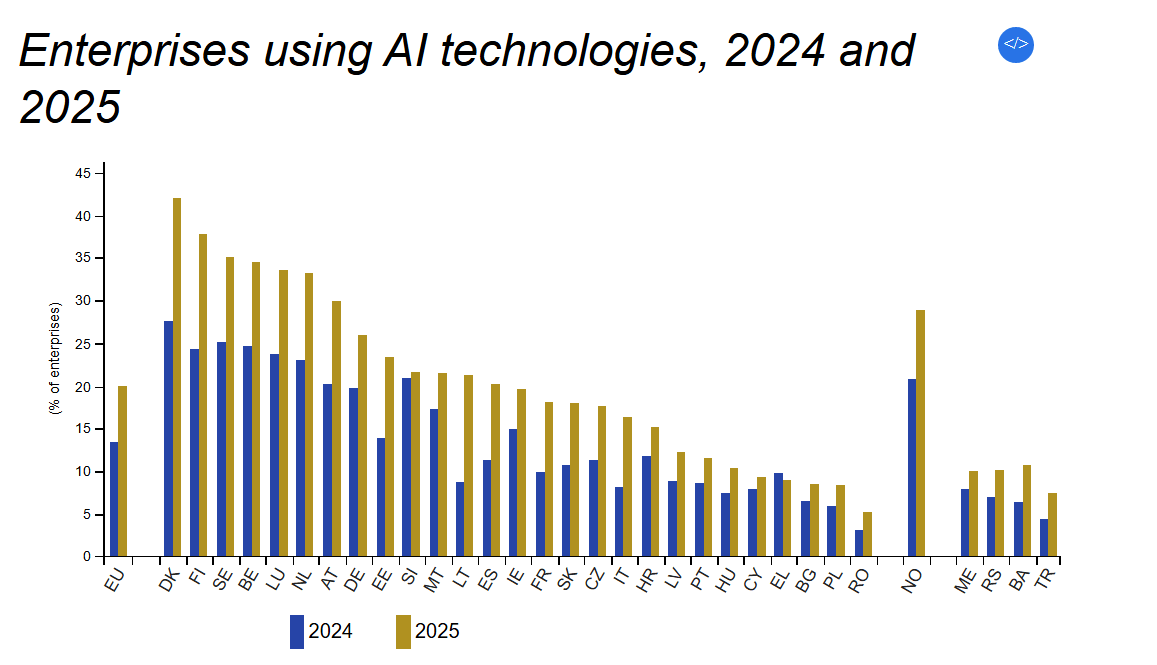
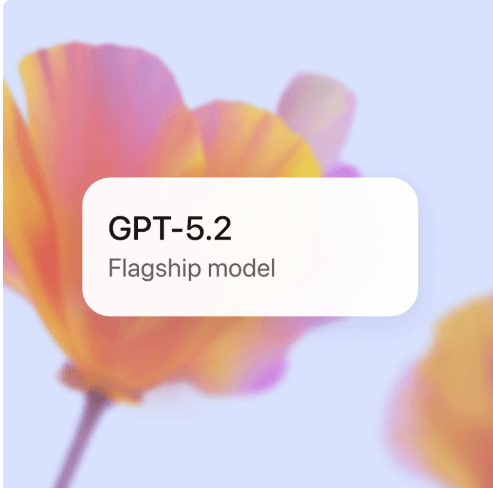





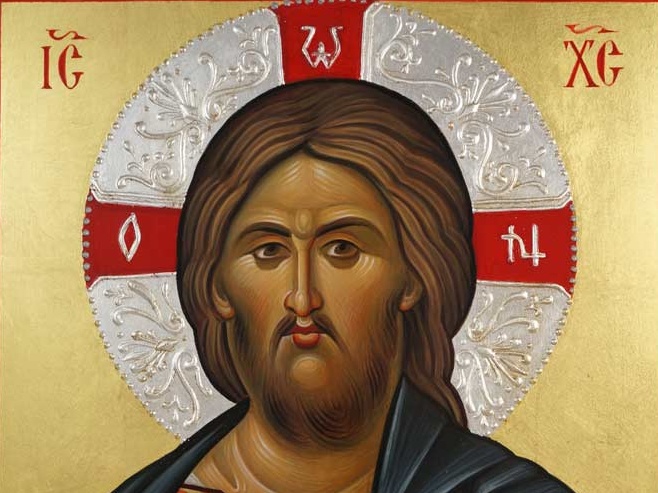
























































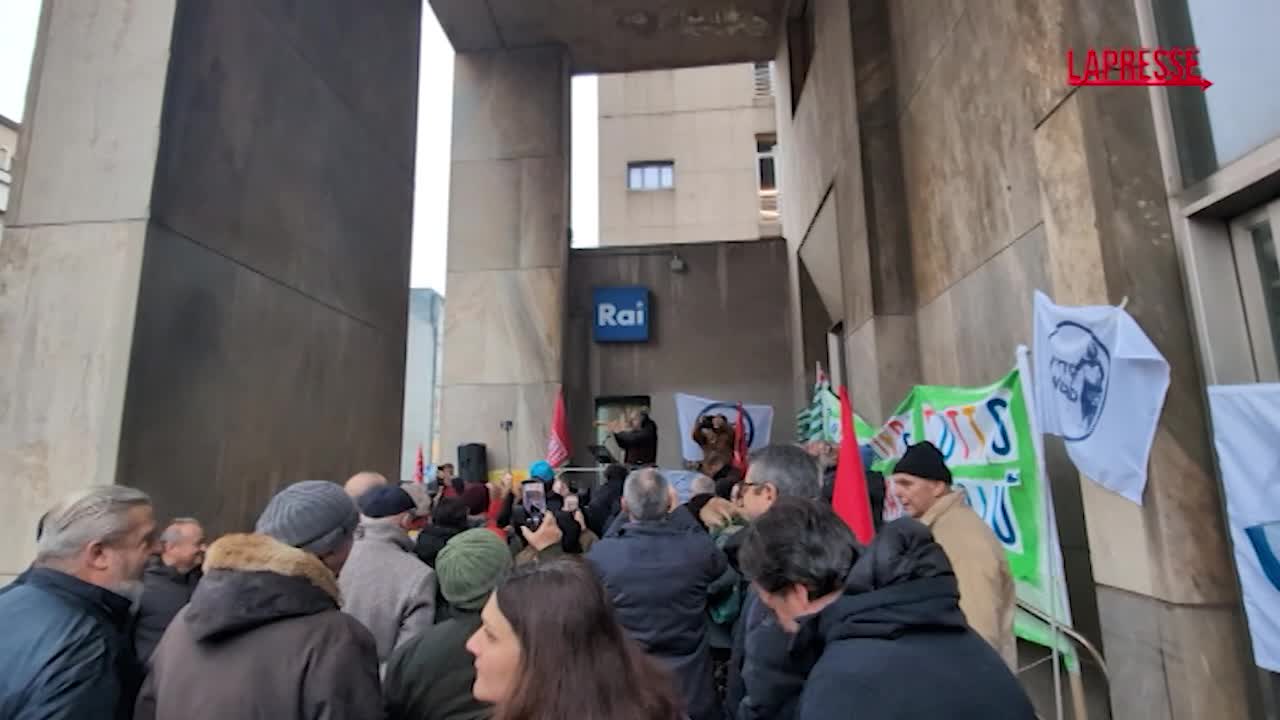






















































_(47)-1765888135875.jpg--piemonte__40_nuovi_agenti_di_polizia_locale__il_98__corso_regionale_si_chiude_al_castello_visconteo_sforzesco_di_novara.jpg?1765888136053#)
-1732265778353.png--domodossola_milano__stop_ai_treni_durante_le_vacanze_di_natale__ecco_cosa_si_ferma.png?1732265780351#)







-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)




















































