L’egemonia del racconto: l’informazione come liturgia dell’occidente

di Rocco Valentino Mottola –
Da tempo ormai m’interrogo con crescente perplessità, venata, lo ammetto, da una punta di malinconico disgusto, sulle ragioni profonde che hanno condotto i media occidentali a cantare, con mirabile disciplina corale, un’unica e inviolabile narrazione. Sia chiaro: non si tratta di semplice convergenza d’opinioni, bensì di una vera e propria architettura del discorso pubblico, all’interno della quale ogni voce dissonante viene estirpata come un’erbaccia molesta nell’orto ordinatissimo della Verità autorizzata.
Prendiamo ad esempio la crisi ucraina: chiunque osi sollevare dubbi, avanzare letture alternative, o anche solo proporre sfumature interpretative, si ritrova additato come traditore del patto non scritto che regge la nostra presunta superiorità morale. Ma lo schema si ripete, quasi con noiosa puntualità, su ogni altro tema sensibile: pandemia, Palestina, geopolitica globale. Il pluralismo d’opinione, fondamento teorico della democrazia liberale, si dissolve in favore di una monocultura dell’informazione che confina il dissenso nello spazio angusto dell’indicibile.
Saremmo tentati di attribuire tale fenomeno a un caso isolato, a una fortuita eccessiva prudenza editoriale. Ma sarebbe ingenuità. O peggio: connivenza. L’origine, piuttosto, è strutturale. I principali media dell’Occidente, oggi, non sono più sentinelle del potere: ne sono appendici, prolungamenti estetici e retorici, estetizzatori dell’ordine costituito (d’altronde i grandi gruppi editoriali sono tutti di proprietà di grossi conglomerati finanziari e industriali, o comunque di soggetti molto vicini al potere politico). Le redazioni, un tempo laboratori di verità scomode, si sono mutate in sacrestie laiche, in cui si officiava, e si officia tuttora, il culto del mondo così com’è. Il giornalismo, in questo scenario, non indaga: conferma. Non esplora: legittima.
E così accade che le testate un tempo faro del pensiero critico ,The New York Times, Le Monde, BBC, Corriere della Sera, si facciano strumento, talvolta persino inconsapevole, di un’opera di sofisticata omologazione. Laddove si evocano valori come “libertà”, “democrazia”, “diritti umani”, si celebra spesso, in realtà, il rito apotropaico della rimozione del dubbio. Ogni opinione che osi contraddire la linea sacra dell’Occidente viene così sbrigativamente relegata a propaganda ostile, come se il solo fatto di interrogarsi su una versione dominante dei fatti costituisse già una forma di alto tradimento epistemologico.
Non serve più la censura, quella brutale, quella volgare dei regimi esplicitamente autoritari. No: la nostra è molto più raffinata, più elegante, più insidiosa. È una censura vestita di civiltà, di buone maniere, di etica professionale. Una censura interiorizzata, introiettata dai giornalisti stessi, che imparano a camminare, con un senso quasi religioso di devozione – entro i margini del discorso consentito. Una sorta di autocastrazione morale mascherata da deontologia.
E quando il dissenso riesce comunque a emergere, magari per voce di figure scomode come Seymour Hersh o Noam Chomsky, viene accolto con la stessa benevolenza riservata ai profeti nel deserto: con un misto di paternalismo, scherno e malcelata irritazione. Non si discute ciò che essi dicono: si discute il fatto stesso che abbiano osato dirlo.
Nel frattempo il grande spauracchio della “disinformazione” viene abilmente manipolato per operare una selezione darwiniana del pensiero. La minaccia, reale, di fake news diventa il pretesto per screditare anche il pensiero critico più serio e documentato. Il risultato è un ecosistema mediatico nel quale tutto ciò che non è conforme viene marchiato, con infantile disinvoltura, come “propaganda russa” o “complottismo”. Le piattaforme digitali, zelanti servitori del nuovo ordine comunicativo, completano l’opera: gli algoritmi penalizzano, i fact-checker condannano, i contenuti scomodi spariscono – non per decreto, ma per dissoluzione algoritmica. Come neve al sole della legittimità.
Ma il vero dramma è che questa situazione non viene subita da un popolo ignorante e passivo. No: viene accolta con sorprendente entusiasmo proprio da quel pubblico che si considera colto, informato, razionale. Come se l’istruzione, invece di rendere più liberi, avesse reso più docili. Come se la cultura, da strumento di liberazione, si fosse fatta accessorio di status, buono solo per distinguersi dalla plebe, ma incapace di generare uno sguardo realmente critico.
Come spiegare questo paradosso? Forse perché la razionalità, se non accompagnata da una vera volontà di verità, diventa un’arma spuntata, anzi peggio: uno scudo narcisistico. Gli intellettuali odierni, o presunti tali, non cercano la realtà, cercano conferme. E in questo gioco di specchi, finiscono col difendere il sistema che li gratifica, li legittima, li premia. Non per convinzione profonda, ma per paura del disallineamento, per timore di perdere privilegi, reputazione, accettazione sociale.
La democrazia, in questo contesto, rischia di diventare una maschera tragica. Il voto resta, certo. Le libertà formali non mancano. Ma se il cittadino non ha accesso a un’informazione plurale, se non può confrontare visioni, se non ha gli strumenti per decodificare la narrazione che gli viene propinata ogni giorno, allora la sua libertà è un fantasma, una coreografia di superficie. E il consenso che esprime alle urne, lungi dall’essere “informato”, è semplicemente condizionato.
Laddove la stampa si fa organo del potere anziché suo cane da guardia, la democrazia vacilla, anche se continua a proclamarsi tale. Il vero pericolo, oggi, non è la menzogna clamorosa, ma la mezza verità costante. Non è la censura esplicita, ma la selezione silenziosa. Non è il regime, ma la liturgia. Nel silenzio accondiscendente della borghesia riflessiva, nelle stanze ovattate dell’opinione colta, tra una rassegna stampa e un aperitivo progressista, si nasconde la complicità più subdola.
E allora, forse, il problema non è solo l’inganno. È la comoda voluttà con cui ci si lascia ingannare. Perché smascherare certe narrazioni implicherebbe dover abbandonare le certezze rassicuranti, scrostare la patina della superiorità morale e guardare in faccia un Occidente che, troppo spesso, confonde i propri interessi con i diritti umani, le sue guerre con crociate etiche, e il pensiero critico con una minaccia all’ordine.
In fondo, è molto più semplice credere di vivere nel migliore dei mondi possibili, piuttosto che riconoscere di abitare in un raffinato apparato di consenso, dove le opinioni si indossano come abiti firmati: ben tagliate, costose, e del tutto identiche.
Non c’è bisogno di bruciare libri né di imbavagliare giornalisti: basta convincere tutti che le uniche notizie vere sono quelle che non fanno troppo male. E così, mentre si celebra la libertà con toni solenni, si assiste silenziosamente, garbatamente, al suo svuotamento.
Non siamo più di fronte a un’informazione addomesticata. Siamo di fronte a un pubblico che applaude il domatore.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0





























































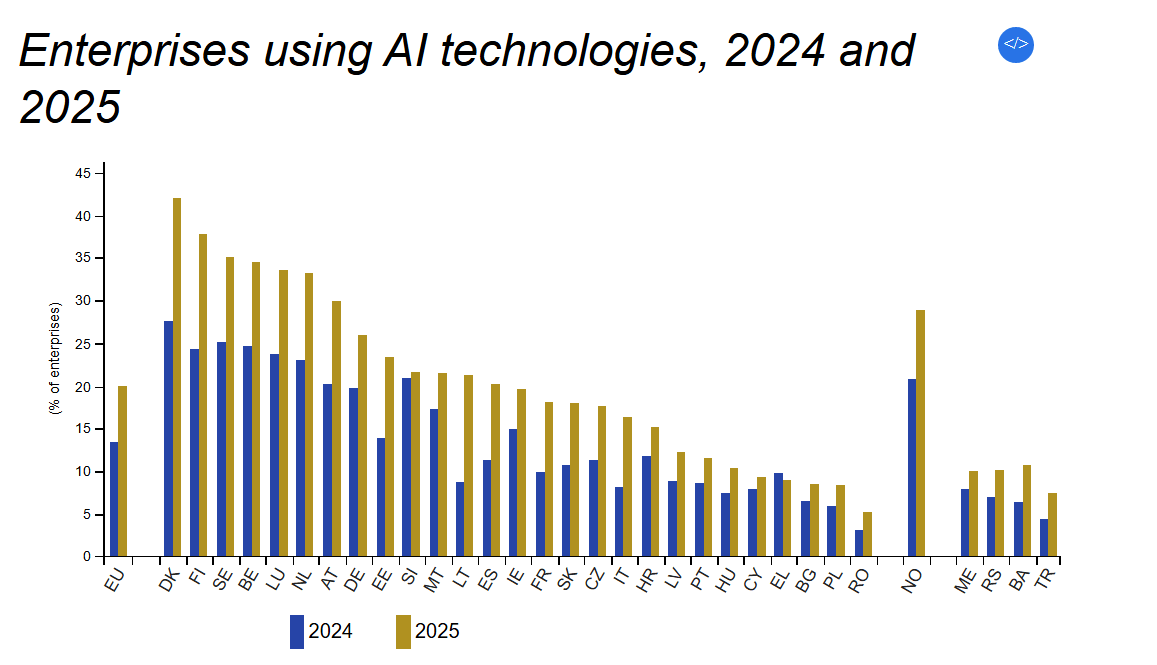
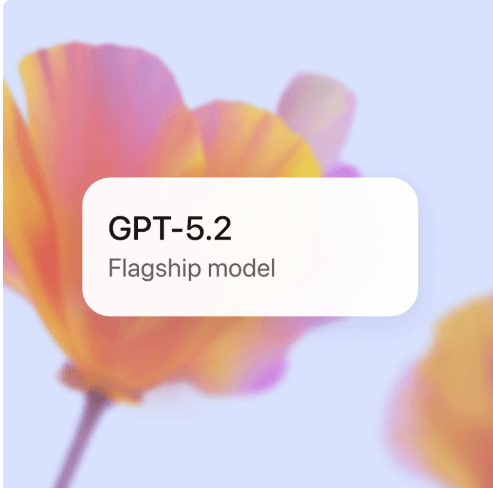





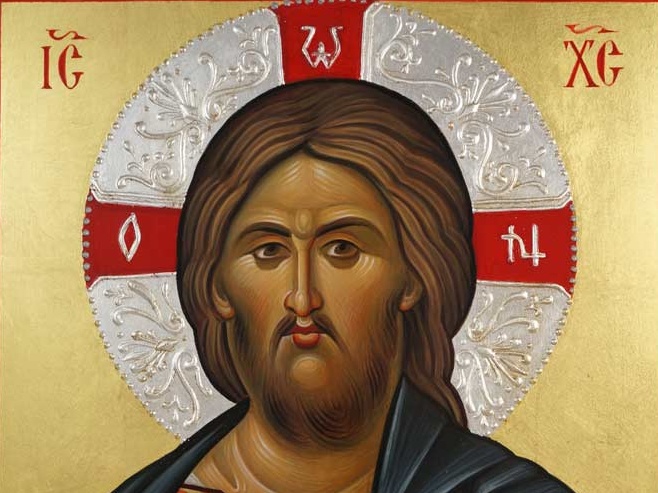
























































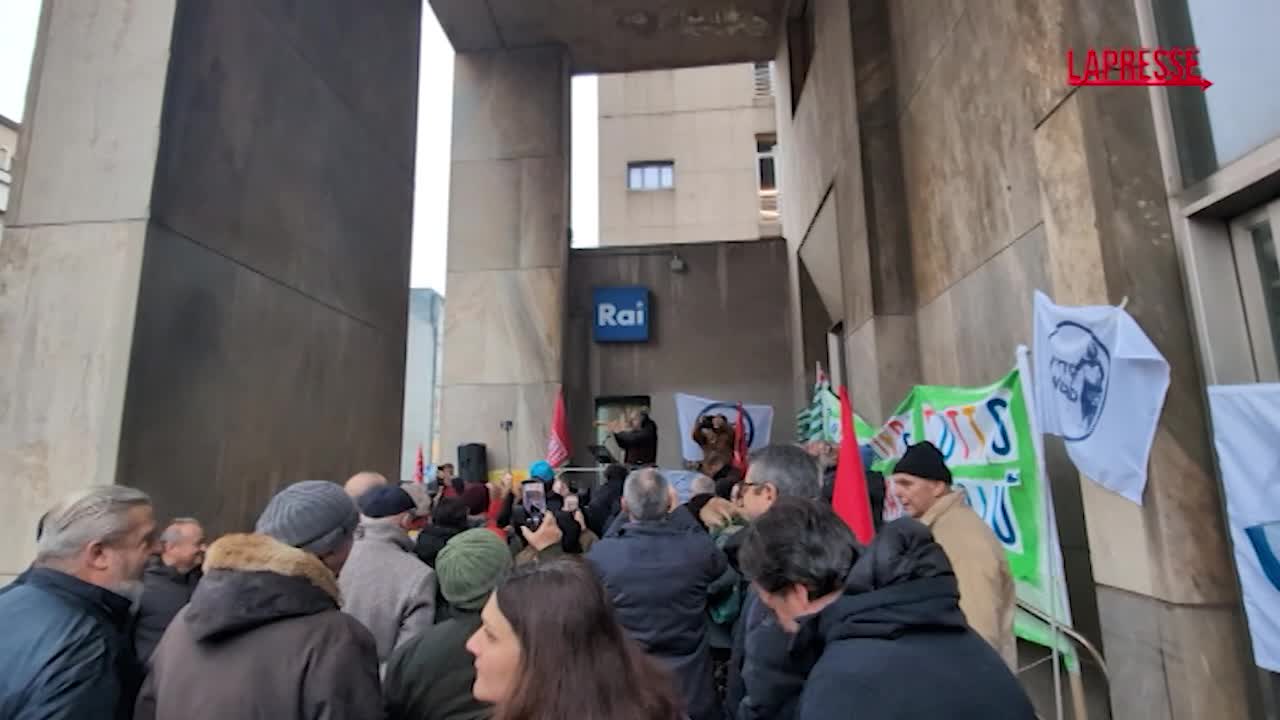






















































_(47)-1765888135875.jpg--piemonte__40_nuovi_agenti_di_polizia_locale__il_98__corso_regionale_si_chiude_al_castello_visconteo_sforzesco_di_novara.jpg?1765888136053#)
-1732265778353.png--domodossola_milano__stop_ai_treni_durante_le_vacanze_di_natale__ecco_cosa_si_ferma.png?1732265780351#)







-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)






















































