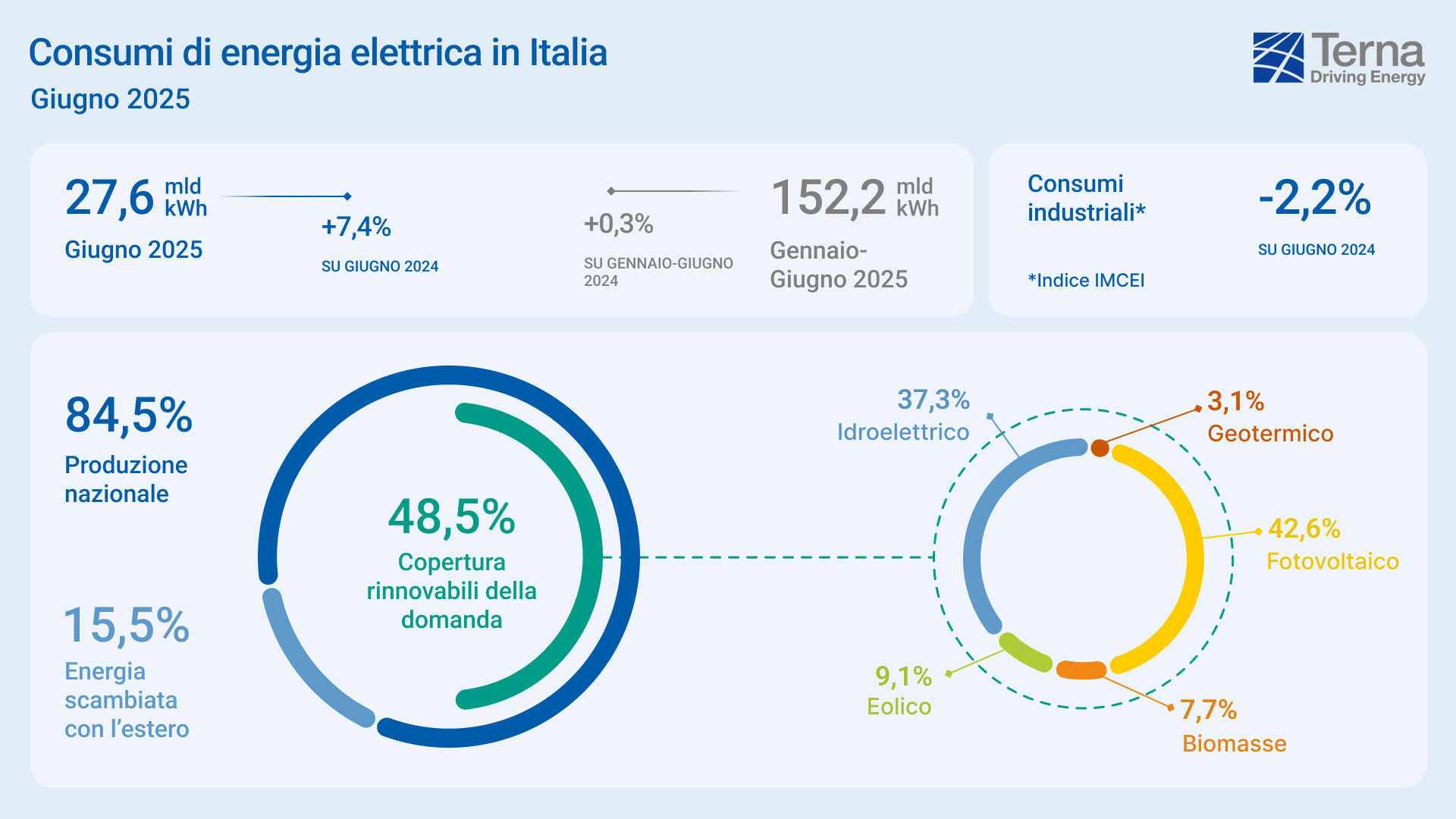Se una foto trova voce


Il testo che trovate di seguito è scritto da Francesca Milano. “Lei, – come scrive Mario Calabresi nella sua newsletter Altre storie – ha iniziato a fare la giornalista perché le è sempre piaciuto raccontare le storie delle persone. Ha collaborato con diversi giornali e ha lavorato per 15 anni a Il Sole 24 Ore. Oggi è responsabile dei podcast giornalistici di Chora Media”.
Le abbiamo chiesto la possibilità di riprendere questo testo per consentire a più persone possibili di conoscere questa storia. Di approfondire quanto successo in Bosnia 30 anni fa e molto ben descritto nella serie podcast Srebrenica, un genocidio dimenticato di Paolo Rumiz con Roberta Biagiarelli. Il podcast lo potete ascoltare qui.
Il testo di Francesca Milano
Era quella che avevo in mente, senza mai averla vista prima: una foto corale, che raccontasse la disperazione e la paura. Una foto senza uomini adulti, per sottolineare la loro scomparsa come vittime del genocidio: sterminare la popolazione musulmana della Bosnia significava, nelle intenzioni dei serbi, cancellarne la storia, i cognomi, la possibilità di portare avanti la stirpe. In quella immagine c’erano solamente donne e bambini, gli ultimi bosgnacchi a cui il generale Ratko Mladić concedeva la grazia di vivere.
Ne abbiamo acquistato i diritti, l’abbiamo usata come copertina, abbiamo pubblicato il podcast.
E poi, qualche giorno dopo, ho ricevuto un messaggio dall’autrice e voce narrante, Roberta Biagiarelli: “Una donna dall’America ha riconosciuto sua madre nella foto della copertina”. Seguiva uno screenshot della cover, con un cerchio un po’ sbilenco realizzato su Whatsapp per indicare a quale di quelle donne ci si riferisse. Nella foto, a causa del formato delle copertine dei podcast, il volto è quasi tagliato, la donna entra appena nell’immagine. Ha i capelli chiari, coperti da un fazzoletto, guarda in basso, forse nemmeno si accorge di Pascal Guyot che sta realizzando un reportage sui camion che deportavano a Tuzla le donne e i bambini che si erano rifugiati nell’enclave di Srebrenica.
Il messaggio era arrivato a Roberta dall’imam principale della Comunità islamica dei bosniaci in Italia Ahmed Ef. Tabaković. Qualche giorno prima, Roberta gli aveva inviato il link al podcast e lui, a sua volta, lo aveva condiviso con i suoi contatti. “La donna della copertina portava in braccio una bambina”, scriveva ancora l’imam.
Sono andata a cercare la foto originale di Guyot prima del taglio effettuato per trasformare un’immagine orizzontale in una quadrata. La donna bionda che guarda in basso aveva in braccio, in effetti, una bambina altrettanto bionda con un cappellino di lana verde legato sotto il mento.
La bambina – scopriremo qualche giorno dopo – si chiama Belma. Il 29 marzo 1993, giorno in cui Pascal Guyot scatta quella foto, ha due anni ed è stata appena deportata a Tuzla insieme a sua madre, Senada Ahmetović.
Quel giorno, il giorno della deportazione a bordo di un camion bianco, Belma è ancora figlia unica: sua sorella Sumejja – che scriverà poi all’imam dicendogli di aver riconosciuto sua madre nella copertina del podcast – non è ancora nata. Ma è lei a raccontare la storia della sua famiglia, in una videocall con Roberta Biagiarelli.
“Nel 1992 mia madre aveva solo 21 anni e viveva a Nova Kasaba con mia sorella maggiore Belma. In quel periodo mio padre, Ibiš Šabić, lavorava con mio nonno in Germania”.
Sumejja conosce questa storia perché l’ha ricostruita pian piano, mettendo insieme i brevi racconti che i suoi genitori hanno fatto negli anni del dopoguerra, anni in cui hanno parlato poco e mal volentieri di quel periodo.
“Mio padre Ibiš è morto di cancro nel 2016, e mia madre è ancora traumatizzata e ha difficoltà a parlare di quegli anni. Vorrei aver chiesto di più a mio padre, sapere cosa aveva vissuto”.
Uno dei pochi aneddoti raccontati ai figli è quello dell’aprile del 1992, quando inizia l’assedio a Nova Kasaba: “Mia madre e la sua famiglia si nascondevano nei boschi ogni giorno e tornavano a casa solo di notte, quando era un po’ più sicuro stare in paese. Una notte, tornando a casa, scoprì che i serbi avevano radunato nel cortile della scuola tutti gli uomini arrivati in autobus da Krasan Polje e li avevano giustiziati. I corpi rimasero lì fino al giorno dopo, quando i serbi tornarono con una ruspa. Scavarono una fossa enorme alla periferia del villaggio, vicino a Milići, e li seppellirono tutti in una fossa comune”.
Nel mese di settembre del 1992, il padre di Sumejja torna dalla Germania e raggiunge la famiglia, che intanto si era spostata a Talovići da alcuni parenti. “Quando anche a Talovići iniziarono i combattimenti, fuggirono a Kaldrmica: mia madre racconta di quando una granata colpì la casa: lei era nella vasca da bagno con mia sorella, le pareti crollarono, e si ritrovò nella vasca da bagno sotto il cielo. Fuggirono attraverso i canali di scolo sotterranei mentre i serbi sparavano sopra e tutto intorno a loro era distrutto”.
All’inizio del marzo 1993, mentre alloggiano in una casa, qualcuno bussa alla porta di notte. “Dovete andare a Srebrenica”, dice. E così la famiglia si mette di nuovo in movimento. “Mia madre racconta che erano affamati, non avevano niente da mangiare e camminavano nel fango, dormivano nei fienili. Hanno visto persone che trasportavano altre persone troppo deboli per camminare, persone bloccate nel fango, persone con vermi nelle ferite. Mia madre descrive quelle scene come quelle che si vedono in un film di guerra”.
Nei racconti che Senada ha fatto a sua figlia Sumejja c’è tanta disperazione ma anche tanta solidarietà: per un certo periodo la famiglia in fuga dalla guerra si ferma a Sušnjare, da un cugino. Dormono in 22 sul pavimento di un garage, e riescono anche a fare spazio e ad accogliere estranei feriti.
“Poi arrivarono a Srebrenica, dove in teoria dovevano essere protetti dai caschi blu dell’Onu – racconta Sumejja -. Non c’era niente da mangiare, mia madre mi ha raccontato che salivano sulle colline dove gli aerei sganciavano dei pacchi di aiuti umanitari, ma solo una volta sono riusciti a portare a casa qualcosa”.
Il 29 marzo 1993 a Srebrenica entrano dei camion. “Fu detto a tutti che chi saliva sarebbe sopravvissuto. Mia madre, mia zia e mia sorella salirono a bordo. Era così affollato che un uomo anziano morì soffocato. Mia madre cercò freneticamente suo fratello minore, ma non riuscì a trovarlo. Qualcuno le disse che era salito su un altro camion e che era al sicuro“.
Salgono a bordo verso le 4 del mattino e arrivano a Tuzla verso le 17. “All’arrivo, mia madre scoprì che durante il tragitto qualcuno aveva detto a suo fratello di scendere dal camion per far salire altre persone. Lui aveva una disabilità mentale, non capì bene, scese e fu lasciato indietro. Tornò a Srebrenica, dove era rimasto anche mio padre, come tutti i maschi adulti. Nel 1994 mio padre Ibiš riuscì a fargli avere i documenti per partire con l’UNPROFOR verso Zagabria, in Croazia, dove mio nonno materno, che abitava in Svizzera da dieci anni, andò poi a prenderlo”.
Nell’aprile del 1994, anche Senada e la piccola Belma riescono a partire per la Svizzera. Il 20 giugno 1995, poche settimane prima del genocidio, il marito di Senada, Ibiš, riesce a lasciare Srebrenica e arriva a Tuzla dopo aver camminato a piedi per giorni.
Nel settembre 1995, Senada e Belma ritornano in Bosnia e la famiglia finalmente si riunisce: “I miei non si vedevano da due anni – racconta Sumejja -. Erano riusciti a tenersi in contatto grazie a lettere e messaggi inviati attraverso i radioamatori. Ma di tutte le lettere mia madre riuscì a salvarne solo due”.
Dopo il genocidio avvenuto nel mese di luglio del 1995 e la fine della guerra, la famiglia Šabić torna in Bosnia e trova casa a Jasenica, non lontano da Tuzla, dove nascono prima suo fratello Benjamin e da ultima Sumejja.
“Nel 2000, infine – racconta Sumejja – ci siamo trasferiti in America alla ricerca di una vita migliore. Siamo arrivati a St. Louis, nel Missouri. Questa città è conosciuta come “piccola Bosnia”. È la città con la più grande popolazione di bosniaci al di fuori della Bosnia-Erzegovina. Io sono cresciuta qui e poi sono tornata a Visoko, in Bosnia, per frequentare una madrasa, una scuola islamica”. Qui Sumejja ha conosciuto l’imam Ahmed Ef. Tabaković, grazie al quale poi scoprirà la foto di sua madre nella cover del podcast.
Oggi Sumejja vive a Chicago. Si è sposata tre anni fa, è specializzata in malattie infettive e lavora nel Dipartimento di Sanità Pubblica. Come molti figli della diaspora, quando può torna in Bosnia per ricordare la storia di quella guerra dimenticata. Sua madre Senada si è trasferita a Des Moines, Iowa, per vivere con Belma, oggi madre di due figli. Suo fratello Benjamin vive ancora a St. Louis con la sua famiglia.
“Grazie per aver parlato della storia del mio popolo e per aver pubblicato quella foto” dice alla fine della conversazione con Roberta Biagiarelli.
E a proposito di questa conversazione, c’è una piccola storia nella storia, ma anche questa merita di essere raccontata: a tradurre in diretta dal bosniaco all’italiano, durante la video call, è stata l’architetta Kanita Focak, un’amica di Roberta. Kanita è una istituzione a Sarajevo, parla tante lingue, ma non ha mai voluto lasciare la città, dove ha vissuto anche durante i quattro anni dell’assedio con i suoi due figli. Suo marito era stato ucciso da un proiettile sparato dalla montagna e che aveva trapassato il muro di casa nell’aprile del 1992, in uno dei primi giorni di guerra: è morto sul divano mentre guardava la televisione per cercare di capire attraverso un notiziario che cosa stesse succedendo nel suo Paese. Kanita ha generosamente trasformato il suo dolore in un aiuto concreto per chi fa informazione: negli anni della guerra la sua casa si è aperta ed è diventata un punto di appoggio e uno studio televisivo per i collegamenti dei giornalisti di tutto il mondo, dalla CNN alla BBC. Le immagini della biblioteca di Sarajevo che bruciava nell’agosto del 1992, sono state girate dalla finestra del suo salotto.
L'articolo La cosa più buona della Sagra della Patata di Cunardo non è fatta di patate sembra essere il primo su VareseNews.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0






























































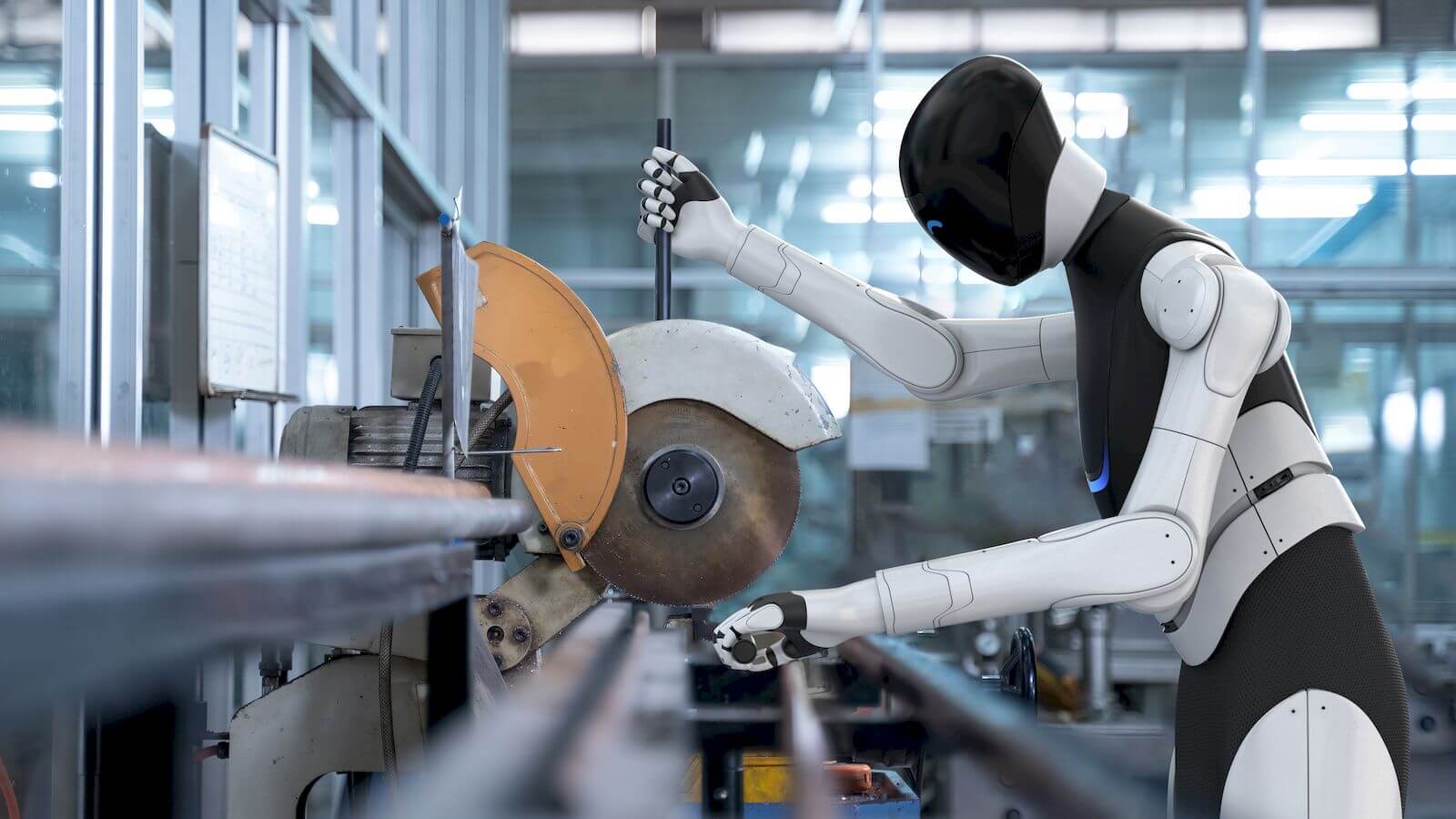



















/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/08/europa-paesi-con-salari-minimi-piu-alti-e-piu-bassi.jpg)
/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/08/wp_drafter_179955.jpg)
/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/08/con-trade-republic-hai-carta-debito-visa-2-percento-liquidita.jpg)
/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/08/telemarketing-stretta-dal-19-agosto-ecco-la-novita.jpg)






































































































-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)