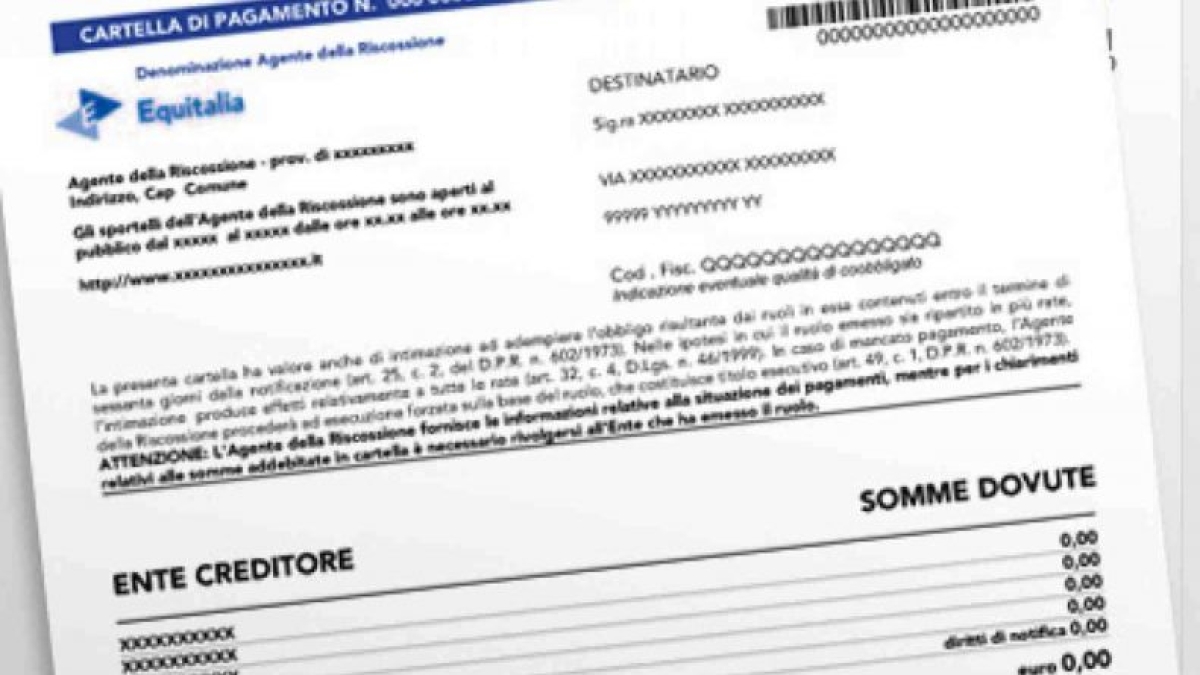Un anno di politiche ambientali a Firenze: promesse in cammino e prove generali


Il primo anno dell’amministrazione Funaro consegna un quadro composito delle politiche ambientali cittadine: progressi concreti e investimenti incoraggianti, ma anche lentezze strutturali e nodi che attendono passi concreti. In un contesto segnato da aspettative civiche crescenti, facciamo insieme un piccolo (non esaustivo) bilancio.
Mobilità sostenibile: muovere le persone, non le auto
Sicuramente la tramvia resta l’asse portante della mobilità a Firenze, con cantieri in corso e in partenza (come le nuove linee 3.2.2 fino a Rovezzano e 4 fino a Campi Bisenzio). Un investimento strategico, in grado di ridurre drasticamente traffico veicolare e inquinamento, a patto di integrarsi con ciclabilità, trasporto pubblico su gomma e sharing mobility ben funzionanti. Sulla ciclabilità, l’amministrazione comunale ha messo in campo soluzioni interessanti e una rinnovata attenzione: 18 velostazioni, in via di attivazione, offriranno spazi custoditi e attrezzati per biciclette, officine self-service e colonnine di ricarica per bici elettriche, in punti chiave della città. È un passo avanti nella direzione dell’intermodalità, così come lo è l’aver reso il servizio di bike sharing più accessibile grazie a tariffe differenziate tra abbonati al trasporto pubblico locale e le altre categorie di utilizzatori, incoraggiando un uso integrato di bus, tram e bici. Le bici private, invece, faticano ancora a trovare spazi dedicati a bordo dei tram.
La rete di piste ciclabili cresce, ma non sempre in modo sicuro o funzionale: a fronte di nuovi tratti annunciati, persistono lacune progettuali. FIAB Firenze Ciclabile ha più volte denunciato problemi di discontinuità nei percorsi, carenze nella connessione tra i quartieri, e la progettazione insufficiente di alcune piste, spesso prive di barriere protettive, con segnaletica assente o poco chiara e una convivenza pericolosa con auto e pedoni.
Difficile poi ignorare i segnali contraddittori sul tema parcheggi: aumento dei posti disponibili e tariffe agevolate rischiano di riattivare un circolo vizioso. È vero che la ricerca del parcheggio genera stress e inquinamento – in media 15 minuti al giorno, circa 91 ore l’anno – ma soluzioni pensate (anche) come compensazione durante i cantieri tramviari rischiano di consolidare la cultura dell’auto. Gli studi sono chiari: aumentare la disponibilità di parcheggi aumenta l’uso del mezzo privato, vanificando gli sforzi per ridurre il traffico e migliorare la qualità dell’aria. Firenze resta ancora una città più adatta alle auto che alle persone. Resta il sospetto che, di fronte ai sondaggi, la giunta abbia scelto la strada più spendibile politicamente, in vista delle prossime elezioni regionali.
Quanto alla mobilità elettrica privata, manca ancora una strategia organica. Lo stanziamento di 1,2 milioni di euro per incentivare l’acquisto di veicoli meno inquinanti include anche veicoli ibridi e a benzina Euro 6. La rete di ricarica elettrica procede in ordine sparso, affidata perlopiù a soggetti privati. In assenza di un disegno coerente e di una visione pubblica forte, la transizione rischia di rimanere limitata a una nicchia. Eppure guidare – anche culturalmente – questa transizione è cruciale davanti a un'opinione pubblica diffidente verso l’elettrico, altrimenti il rischio è che resti appannaggio di pochi.
Una promessa importante, ancora tutta da concretizzare, riguarda il potenziamento del servizio di trasporto pubblico nelle fasce notturne e l’anticipo delle corse mattutine verso luoghi strategici come ospedali - una delle misure chiave al centro della proposta #FirenzeDiNotte avanzata da Volt. Sul fronte della mobilità condivisa, invece, il car sharing resta al palo, mentre la sharing mobility su monopattini, bici e motorini elettrici attende un vero rilancio. La giunta ha promesso più concorrenza tra operatori e incentivi per il car pooling, ma per ora le intenzioni restano sulla carta.
È stata anche annunciata la creazione di un sistema tangenziale tra hub intermodali, per connettere i “raggi” della tramvia e migliorare i collegamenti periferia-periferia – una misura già al centro del programma di Volt. Ma su mezzi, tempi e modalità, per ora, tutto tace.
Verde urbano: serve ancora più coraggio (e più manutenzione)
Con l’adozione del piano IRIS, il Piano del Verde e degli Spazi Aperti, l’amministrazione ha abbracciato una visione più strategica del sistema del verde urbano, ponendo al centro qualità della vita, giustizia ambientale e adattamento al cambiamento climatico. La strategia si ispira alla regola 3-30-300 (almeno tre alberi visibili da ogni finestra, 30% di copertura arborea per quartiere, massimo 300 metri da un’area verde accessibile per ciascun abitante) e si accompagna a una mappa interattiva pensata per aumentare trasparenza e partecipazione.
Tuttavia, alla cornice strategica devono seguire cura e continuità. La gestione del verde – e la fiducia dei cittadini – si gioca nella manutenzione quotidiana: alberi piantati e poi lasciati seccare, altri coperti di catrame come accaduto di recente a Gavinana, sono episodi che rischiano di compromettere in partenza la credibilità di qualunque piano. Come ha ricordato il prof. Francesco Ferrini, ordinario di Arboricoltura e coltivazioni arboree all’Università di Firenze, «il lavoro inizia quando si pianta, non finisce»: servono risorse stabili, personale formato, visione tecnica e responsabilità amministrativa per garantire la salute e la sopravvivenza del patrimonio arboreo.
Tra le direttrici previste da IRIS figura anche la depavimentazione, intesa come restituzione alla città di suolo vivo e permeabile. È una leva chiave per rafforzare la resilienza urbana, mitigare le isole di calore e migliorare il drenaggio naturale delle acque. Come ha osservato il prof. Stefano Mancuso, «ogni città può depavimentare fino al 20% della superficie stradale». Firenze ha ancora molta strada da fare – o, meglio, da ripensare. Occorre maggiore determinazione anche nel recuperare microspazi abbandonati o sottoutilizzati e nel riconvertire in piccoli angoli verdi (pocket garden, rain garden) aree oggi dominate dalla sosta – spesso anche selvaggia. Liberare superfici per interventi di verde di prossimità, diffusi e capillari, è una sfida decisiva rispetto alla quale non è più il tempo di arretrare. Il progetto avviato dalla giunta Nardella per individuare 25 aree da rinverdire si è però scontrato con l’indisponibilità a rinunciare anche a pochi stalli per auto, e ne sono state realizzate molte meno.
Sul fronte dell’adattamento climatico, è partita la sperimentazione dei primi rifugi climatici, spazi pubblici freschi e accessibili in cui trovare sollievo durante i picchi di calore. Attualmente sono 44 tra biblioteche, parchi e giardini. L’iniziativa, promossa su impulso di AVS–Ecolò, è un buon punto di partenza. Perché questi luoghi si affermino come veri presìdi urbani di esercizio del diritto al verde e al fresco, nel tempo sarà necessario aumentarne il numero e migliorarne comfort, fruibilità e distribuzione sul territorio.
Orti urbani e politica locale del cibo: coltivare comunità
Nel 2024 il Comune ha avviato F’Orti!, primo progetto di orti urbani di comunità gestiti direttamente dall’amministrazione. Cinque aree sono state assegnate a cittadini e associazioni, con oltre 150 adesioni raccolte in pochi mesi e una partecipazione distribuita su tutti i quartieri. Un segnale incoraggiante, che mostra quanto il bisogno di spazi verdi e relazionali sia sentito anche su scala di prossimità.
Sul piano più ampio della food policy, l’Amministrazione ha rilanciato l’impegno a costruire una strategia locale per un’alimentazione sostenibile, in coerenza con il Milan Urban Food Policy Pact e il progetto europeo In Cibo Civitas. A questo si affianca il lavoro del Distretto di Economia Civile (DEC) e le sinergie avviate con buone pratiche di altre città, anche grazie a momenti di confronto come l’evento Dalla Terra al Piatto.
Anche qui, la sfida è proseguire da quanto avviato, arrivando a costruire in modo partecipato una vera politica alimentare locale (di dimensione metropolitana) urbana, che rafforzi i mercati alimentari di prossimità, promuova filiere locali e biologiche, e orienti mense scolastiche e in generale pubbliche verso criteri più sostenibili, sia dal punto di vista ambientale che sociale.
Economia circolare: il miglior rifiuto è quello che non si produce
Nel 2021, la precedente amministrazione Nardella aveva sottoscritto il Patto per l’Economia Circolare - un accordo tra Comune, associazioni, imprese ed enti locali per passare da un modello lineare a uno più sostenibile. A questo si era aggiunto il piano “Firenze Città Circolare”, che punta a superare il 70% di raccolta differenziata e ad avviare al riciclo almeno il 55% dei materiali raccolti.
Guardando più da vicino, tuttavia, la sfida principale resta quella di ridurre alla fonte la quantità di rifiuti prodotti: un fronte su cui ci si è mossi finora con un passo ancora troppo timido rispetto alla portata del problema. Nel 2019, sotto il mandato Nardella, era stata introdotta la “Stoviglioteca” — tuttora attiva tramite due circoli ARCI — che offre un servizio di prestito in comodato d’uso gratuito di stoviglie durevoli e lavabili (piatti, posate, bicchieri) per eventi di piccola e media scala. Esistono poi esperienze consolidate come il Centro del Riuso di Canciulle (San Casciano), riaperto regolarmente grazie all’impegno di volontari. Anche le iniziative civiche come i Restart Party (sul modello dei repair cafè) e il gruppo Restarters Firenze meritano di essere riconosciute e sostenute: segnalano che la cittadinanza è pronta a mobilitarsi per il riuso e la riparazione, ma ha bisogno di spazi, strumenti e percorsi pubblici integrati per farlo.
In una città dove la crescente domanda di cibo e bevande da asporto – alimentata sia dal turismo che dalle nuove abitudini di consumo dei residenti – genera ogni giorno un fiume di rifiuti da imballaggio, intervenire a monte con una politica strutturale di prevenzione non è più rinviabile. È qui che si inserisce il contributo di Volt, che nel 2024 ha portato nel programma della coalizione (e dunque nel programma di mandato della sindaca Funaro), e in parallelo all’interno del Distretto dell’Economia Civile di Firenze (DEC), la proposta del vuoto a (buon) rendere — oggi formalmente recepita nel Manifesto del Distretto. Frutto di un lavoro condiviso con esperti come Irene Ivoi e Danilo Boni, la misura mira a promuovere l’uso di contenitori riutilizzabili (bicchieri, borracce, stoviglie, vaschette) restituibili nei punti vendita, sanificati e reimmessi nel circuito, con un piccolo deposito cauzionale rimborsato al momento della riconsegna. Si tratta di un approccio già sperimentato con successo in molte città europee, replicabile a Firenze in almeno quattro ambiti chiave: concerti e grandi eventi, mercati alimentari, bar e pub, fiere e sagre. Partendo da aree e occasioni pilota — come piazza Santo Spirito, il Mercato Centrale, il Mercato di Sant’Ambrogio — si può avviare una politica strutturale di prevenzione del rifiuto su scala cittadina, accompagnata da linee guida per eventi sostenibili, incentivi per gli esercenti che adottano soluzioni riutilizzabili (es. sgravi TARI, agevolazioni sul suolo pubblico), campagne di comunicazione efficaci e riconoscibili.
È il momento di imboccare con decisione la via sistemica dell’economia circolare, che parte dalla prevenzione e si fonda sulla responsabilità condivisa. Ridurre i rifiuti alla fonte non è un vezzo, ma una necessità strutturale: da affrontare con gradualità, certo, ma anche con convinzione e coraggio.
Energia: l’urgenza della transizione, i passi da accelerare
Sul fronte dell’energia, la nuova amministrazione ha ereditato una volontà chiara: favorire la diffusione di impianti da fonti rinnovabili (FER), puntando sul fotovoltaico diffuso e sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Il nodo critico resta però la lentezza nell’attuazione concreta, a fronte di un’urgenza climatica che non ammette più ritardi.
In una città che ha fatto della bellezza architettonica un tratto distintivo, il fotovoltaico sconta ancora resistenze culturali, regolamenti datati e iter autorizzativi complessi. Eppure, come ricordano da tempo associazioni ecologiste e numerose voci della società civile, «la rivoluzione solare» può e deve trovare spazio anche a Firenze: sui tetti degli edifici pubblici, scolastici, dei depositi Ataf, delle pensiline e nelle aree industriali dismesse.
Tra i segnali da registrare c’è l’approvazione all’unanimità, in Consiglio comunale, dell’Ordine del giorno promosso da AVS–Ecolò per semplificare le procedure di installazione degli impianti fotovoltaici. Il testo chiede la revisione delle prescrizioni urbanistiche e paesaggistiche che ancora oggi ostacolano molti interventi – anche in aree non vincolate – e l’avvio di un confronto con Regione e Soprintendenza per aggiornare i criteri anche nelle aree UNESCO. Un passaggio significativo, che riflette una nuova convergenza politica e il lavoro culturale portato avanti negli ultimi anni da reti civiche e movimenti per la giustizia climatica. Resta ora da vedere se la Giunta vorrà dare seguito a questo mandato politico chiaro.
La notizia più recente è l’annuncio, da parte della vicesindaca Paola Galgani, della creazione di una Fondazione per la promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali (CERS) attraverso un ruolo di regia pubblica. È un passo importante, che potrebbe imprimere una svolta a una stagione finora segnata da attese e rinvii. Basti pensare alle progettualità di CER annunciate nei quartieri 4 e 5, che risultano ancora bloccate – anche se non è stato chiarito, ad oggi, da quali ostacoli tecnici o politici. Da monitorare anche la situazione a Campo di Marte: nel 2022, il progetto di riqualificazione dello stadio Franchi, incluso nel Dossier PNRR del Comune di Firenze, prevedeva l’installazione di un impianto fotovoltaico integrato nella nuova copertura, pensato anche per contribuire all’attivazione di una CER nel Quartiere 2. Dopo il definanziamento del progetto, la misura era stata sospesa insieme alle altre opere previste. Con il recente rifinanziamento annunciato dal governo nel luglio 2025 – 55 milioni di euro riassegnati al Comune – resta da chiarire se la componente fotovoltaica sarà reintegrata nella nuova fase progettuale. Si tratterebbe di un tassello importante: includerla renderebbe l’intervento più coerente con gli obiettivi di decarbonizzazione della città. Non risultano, al momento, comunicazioni ufficiali su questo punto: ma sarebbe utile – e necessario – che l’amministrazione chiarisse al più presto fattibilità, tempi e modalità di realizzazione.
Intanto, oltre al Franchi, si avverte una lentezza generalizzata anche nella diffusione di pannelli solari su tetti pubblici, pensiline e depositi (come quelli Ataf), nonostante proposte già condivise con le associazioni ecologiste abbiano ricevuto segnali di apertura – per ora solo cauti – da parte del Comune. È però incoraggiante il recente annuncio della vicesindaca Paola Galgani: il Comune investirà 2 milioni di euro per installare impianti fotovoltaici sui tetti degli uffici comunali, con l’obiettivo di coprire il 100% dei consumi energetici dell’amministrazione da fonti rinnovabili. Un passo importante, che segnala una volontà concreta di “guidare con l’esempio” e di avviare un processo di transizione anche nel patrimonio pubblico. È tempo che quei «sì» diventino atti operativi e visibili, su scala ampia e diffusa.
Per concludere…
Nel complesso, il primo anno della giunta Funaro mostra segnali di vitalità e apertura, ma anche molte attese rimaste sospese. Dai trasporti al verde, dai rifiuti all’energia, le scelte compiute iniziano a disegnare una traiettoria. Ma a fronte dell’emergenza climatica, della crisi ambientale e delle disuguaglianze territoriali, è sul terreno dell’attuazione che si misurerà la distanza tra intenzioni e risultati. La buona notizia è che alcuni strumenti ci sono già, così come un’opinione pubblica più consapevole, attori sociali pronti a collaborare e persino un clima politico più disponibile a convergere su scelte coraggiose. La cattiva notizia è che il tempo si sta esaurendo: non possiamo permetterci di avanzare al ritmo delle burocrazie né di rallentare nei tempi sospesi della politica, come in questa lunga fase pre-elettorale verso le regionali.
Per questo, se un appello finale è possibile, è quello a fare della transizione ecologica, e della “Firenze sostenibile”, una vera priorità trasversale, da rendere visibile, misurabile, partecipata. È il momento di passare dalla sperimentazione alla strategia, dai progetti pilota a politiche strutturali. C’è voluto tanto, forse troppo, ma diverse cose si sono messe in moto. Ora serve una spinta decisa. Bene, ma facciamo in fretta.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0















































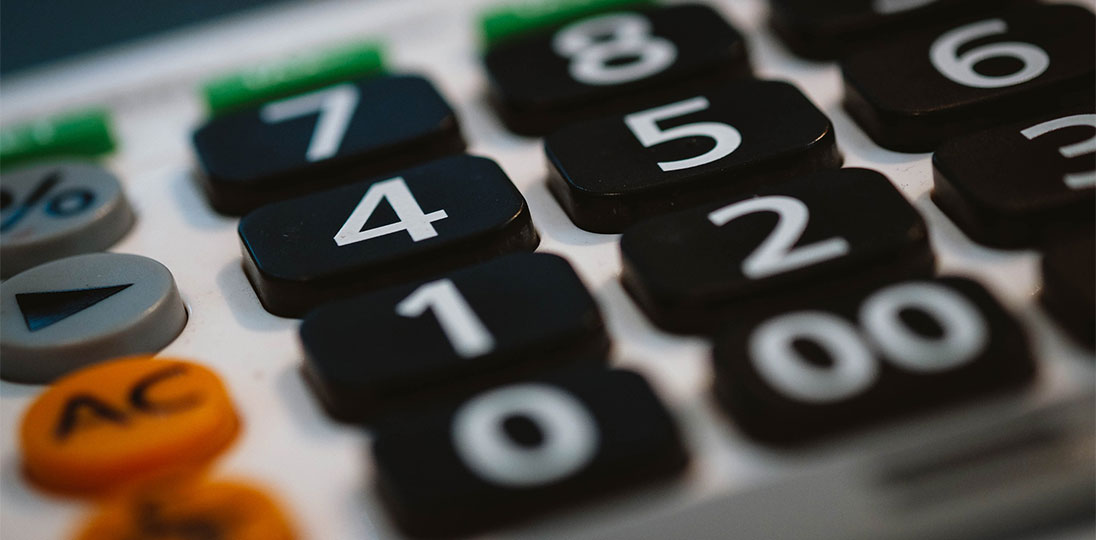







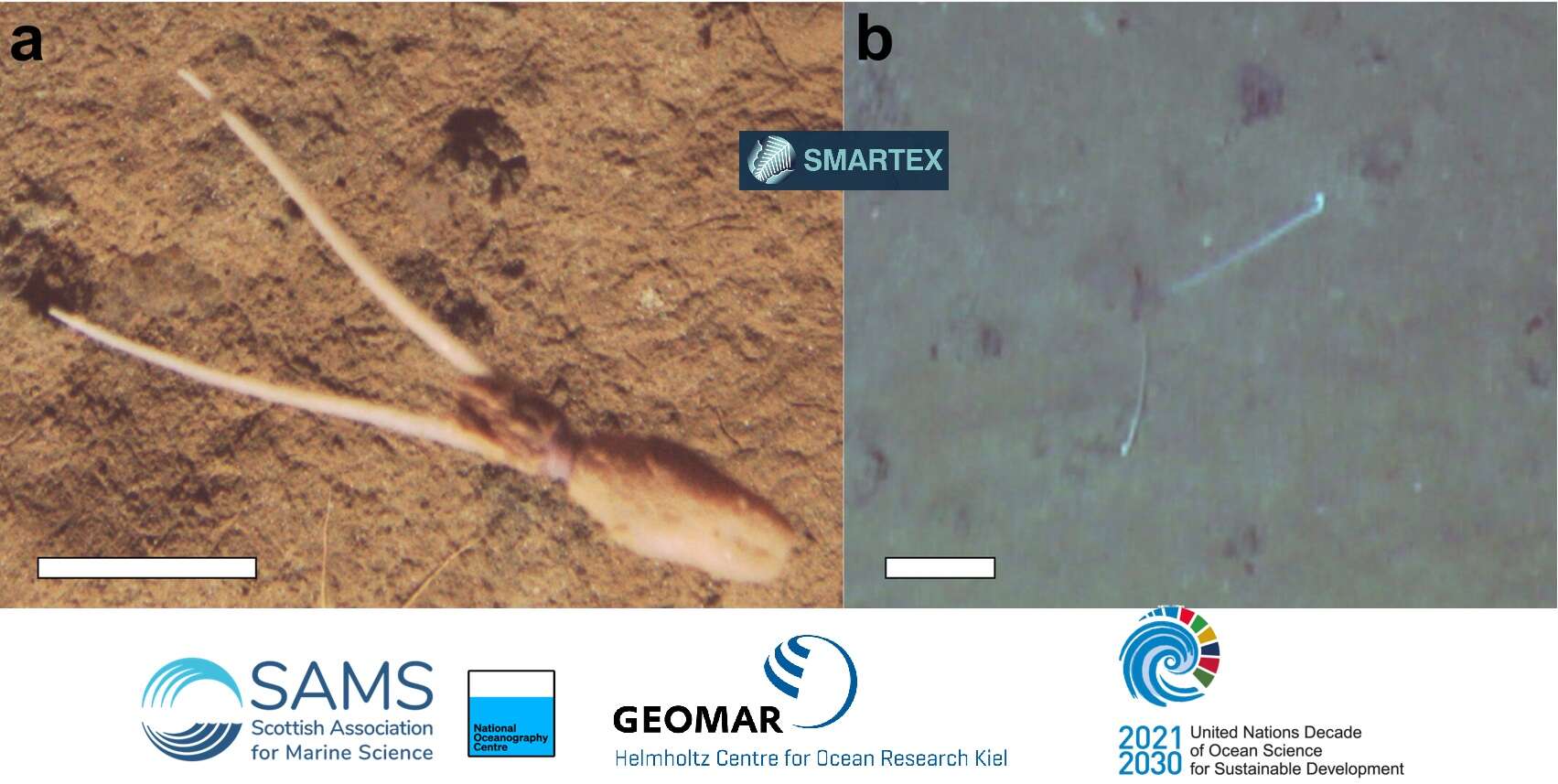






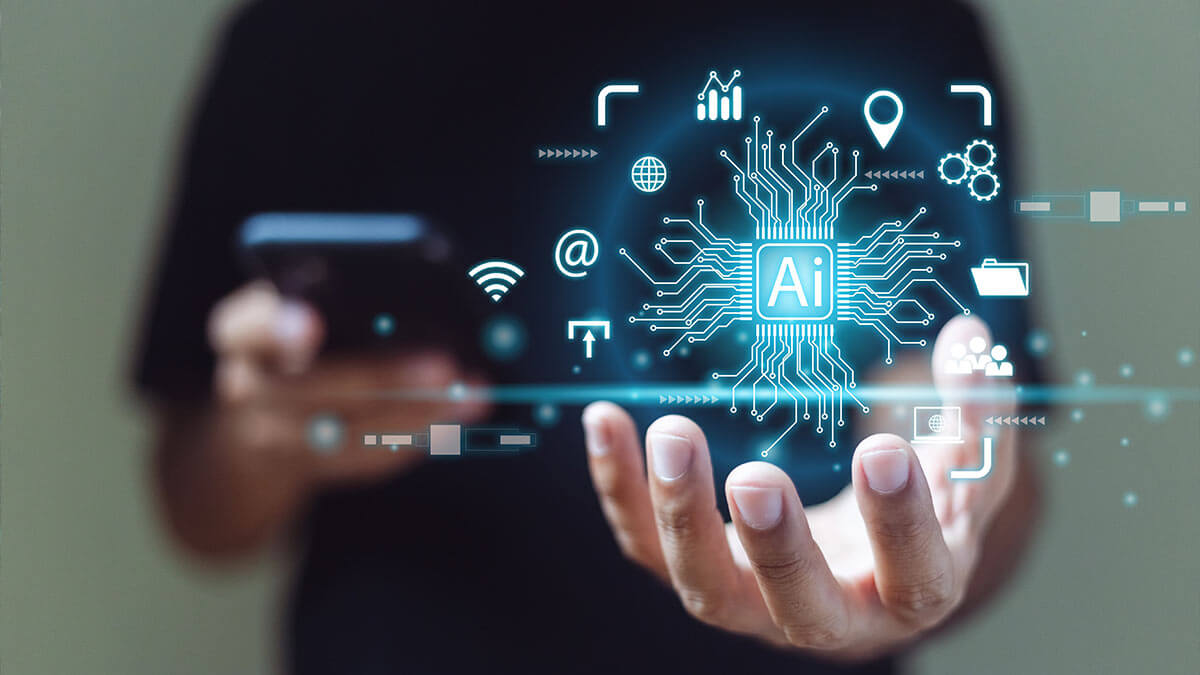


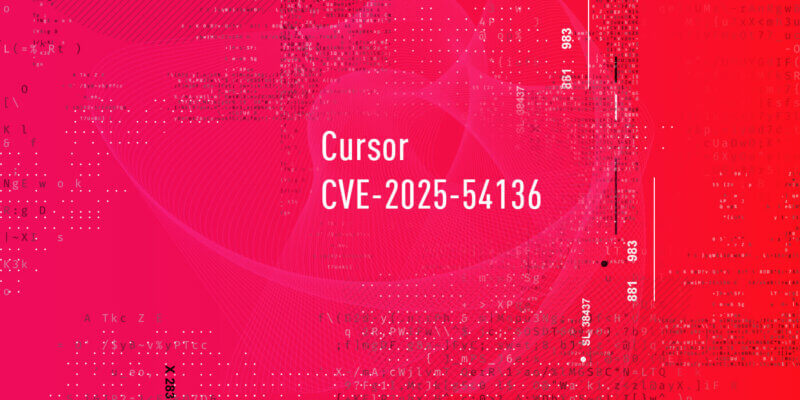















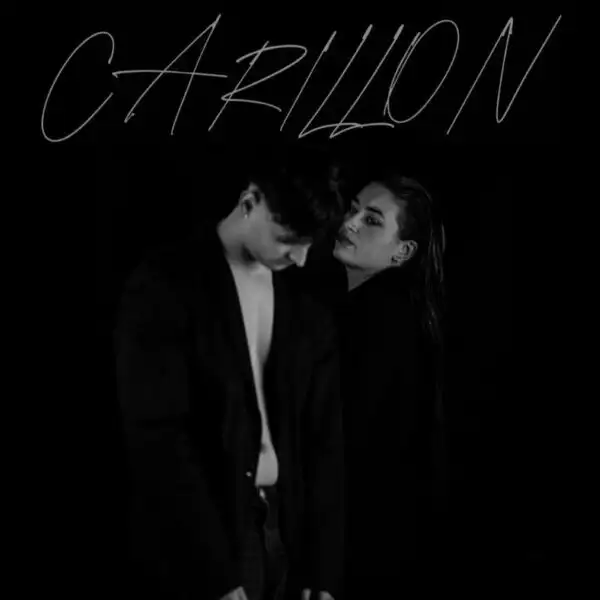





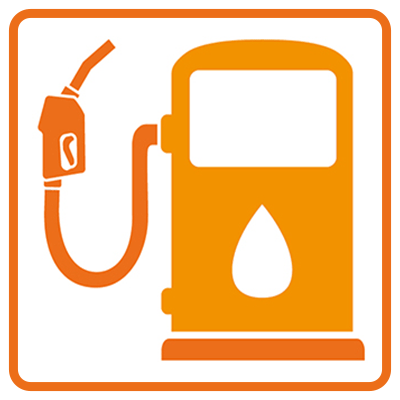




























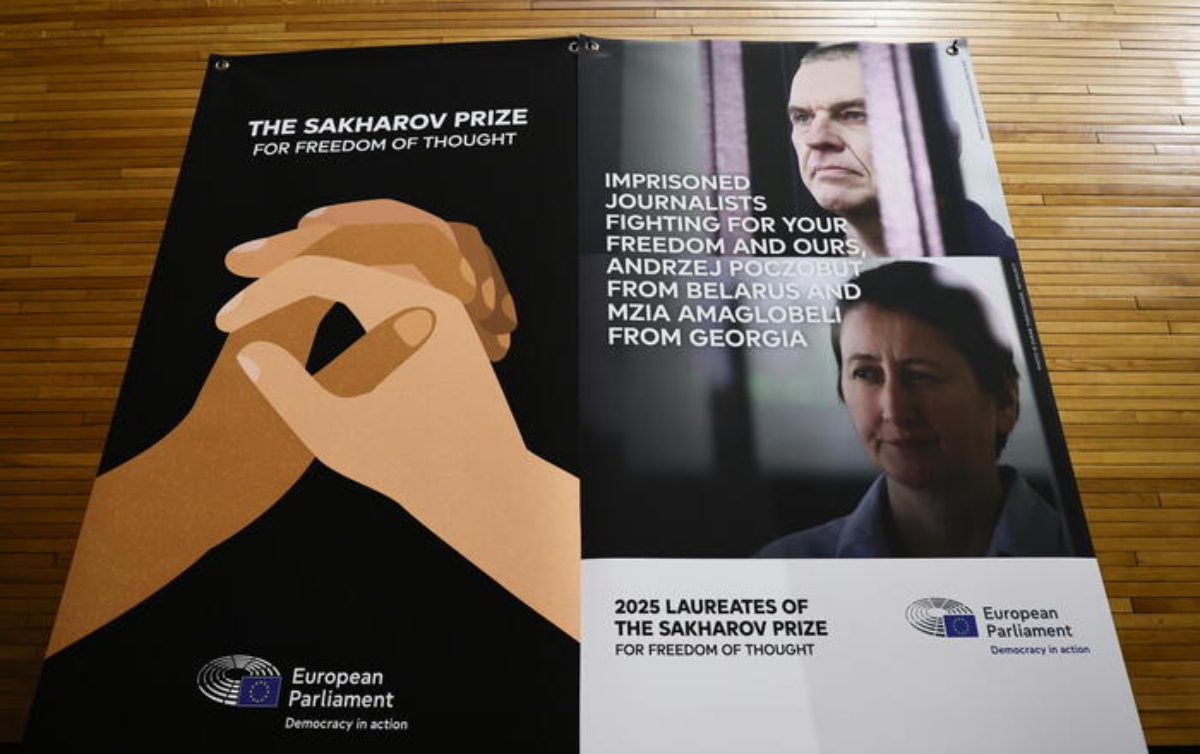



































































_(50)-1765960548246.jpg--tamponamento_tra_due_auto_sulla_provinciale_che_collega_castellamonte_a_cuorgne__grande_spavento_e_lievi_contusioni_per_i_conducenti.jpg?1765960548409#)






-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)