Una musica senza margini d’errore può ancora emozionare?


Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Etc dedicato al tema della Fede. Ordinabile qui (senza spese di spedizione)
Alma Brava è una giovane cantante nata a Barcellona. Viene descritta dall’etichetta che la rappresenta, All Music Works, come «un’anima sensibile e poetica» capace di unire pop alternativo, musica tradizionale spagnola e suoni latinoamericani. Il suo primo Ep, “Quiero Soñar”, disponibile integralmente su Spotify, ha una copertina molto, forse troppo, simile a “Bar Mediterraneo” dei Nu Genea. Fin qui nulla di strano, ma è sufficiente una rapida ricerca per capire che in realtà Alma Brava non esiste, e che All Music Works è una label – la prima al mondo, nata nel settembre 2024 – che lavora solamente con artisti virtuali, contraddistinti da storie, fotografie e soprattutto canzoni inventate dall’intelligenza artificiale. Un evento analogo è accaduto quest’anno, poco prima di Sanremo 2025, quando Loop srl, azienda bolognese che si occupa di performance marketing, ha lanciato Saremo AI Music Festival, con cantanti e brani creati da software generativi.
I cantanti messi al mondo dall’AI sono l’esasperazione della smaterializzazione del prodotto musicale, un fenomeno che da diversi anni vede programmi come Suno, Boomy o Aiva creare melodie partendo dalle indicazioni di un utente. Esattamente come fa ChatGPT con i testi e le immagini. Fin dagli albori, però, sono stati soprattutto i grandi player dell’industria discografica a sfruttare a pieno le potenzialità dell’intelligenza artificiale nella musica, monetizzando, tagliando i costi e innalzando ulteriori barriere all’ingresso per gli artisti indipendenti, spesso penalizzati da un sistema che premia solo chi soddisfa la fame vorace e instancabile dell’algoritmo.
Basti pensare che la prima canzone pop generata con l’AI, “Daddy’s Car” (2016), è stata ottenuta grazie a Flow Machines, software di una major del calibro di Sony. Nell’aprile 2024 Spotify, per fare un esempio più vicino alle nostre esperienze, ha annunciato una nuova funzionalità in fase beta che permette agli utenti di generare playlist personalizzate inserendo un semplice comando testuale (prompt), successivamente elaborato dall’intelligenza artificiale del colosso svedese. Il risultato è una lista di brani perfettamente in linea con i gusti, le inclinazioni e i desideri dell’ascoltatore.
Secondo Raffaele Lauretti, fondatore e direttore artistico dell’etichetta PLUMA Dischi , «gli artisti che sognano di fare questo mestiere sono consapevoli della complessità del momento storico. Alcuni hanno semplicemente abbracciato l’AI, affidando a questi software la creazione di una copertina o di una base su cui poi costruire un testo. Deezer sta introducendo un filtro per permettere agli utenti di distinguere la musica creata con l’AI da quella “tradizionale”, ma finora è l’unico store che si sta muovendo in questa direzione». L’intelligenza artificiale, insomma, è definitivamente sbarcata nel mondo della musica. È successo rapidamente, senza che ce ne accorgessimo davvero, quindi ora non ci resta che affrontare il cambiamento in maniera proattiva e non catastrofista.
«Oggi esistono non solo gli artisti virtuali, ma interi canali YouTube che propongono canzoni e video creati esclusivamente con queste tecnologie. Alcuni brani sono fatti bene, perché l’AI si allena interfacciandosi con della musica che esiste davvero. La competizione sta aumentando ma sta anche mutando, perché non è basata sulla cura umana: è a tutti gli effetti una content economy allineata alla bulimia innescata tanti anni fa da internet», continua Lauretti.
Come tutte le rivoluzioni digitali, anche quella della musica creata dall’AI è accompagnata da dilemmi non solo economici e tecnici, ma anche etici e soprattutto filosofici. Dilemmi che attanagliano l’intera filiera produttiva della musica, dagli artisti agli ascoltatori, chiamati a compiere un nuovo atto di fede verso un prodotto che solo all’apparenza è privo dello zampino umano. A ricordarlo è il filosofo Carlo Serra, uno dei più importanti ricercatori italiani attivi nel campo della filosofia della musica: «Questa forma di virtualità musicale non è nient’altro che una pratica compositiva, non c’è nulla di male a inventare un artista che, di fatto, è una macchina travestita.
Dentro a questo fenomeno, sia chiaro, l’umano c’è fino al midollo: da una parte, come anticipato, parliamo a tutti gli effetti di pratiche compositive, mentre dall’altra parte esiste il desiderio dell’utente, che non è passivo. La componente umana risiede nelle pieghe del desiderio che l’AI (e chi la usa, ndr) cerca di rendere meccanico». L’atto di fede sta quindi cambiando destinatario: non è più il singolo artista, l’etichetta discografica o un genere associato a determinati valori, rituali e subculture, ma «un intero sistema di rappresentazione che la musica mette in gioco». Secondo Serra, infatti, l’AI «non “vende” solamente un singolo cantante o un algoritmo capace di generare un brano, ma una nuova struttura dell’immaginario che racconta e inventa questa pratica compositiva. È un procedimento perfetto, sembra pensato da un sociologo bravo».
Da decenni, con la creazione del formato MP3 e la possibilità di ascoltare musica ininterrottamente su dispositivi mobili, la forma canzone è un oggetto virtuale, un prodotto digitale onnipresente nella nostra vita che diamo erroneamente per scontato. Per questo, spiega l’esperto, l’intervento dell’intelligenza artificiale è «un’evoluzione logica» del medium musicale e dell’industria che lo confeziona. Sono, semplicemente, cambiati i tempi e gli strumenti. «La musica con le macchine si è sempre fatta fin dai tempi del filosofo e storico Athanasius Kircher (1602-1680, ndr); matematici e teorici hanno spesso cercato di tradurre il linguaggio compositivo in stringhe matematiche, e le stringe matematiche in strutture di elaborazione di forme musicali. Questo è un sogno che c’è dall’inizio del mondo della musica. Pensa che nel mondo pitagorico si parlava addirittura di “armonia delle sfere”», continua Carlo Serra, che ha menzionato una delle teorie chiave della cosmologia antica: i corpi celesti, diceva Pitagora, si muovono secondo rapporti matematici armonici, producendo dei suoni impercettibili all’orecchio umano ma essenziali per governare l’universo.
Ma non è solo Pitagora lo studioso da riscoprire per tentare di comprendere il vero impatto della musica creata dall’AI. Nel 1964, tra le pagine di Understanding Media: The Extensions of Man, il sociologo e filosofo Marshall McLuhan scrisse che «il medium è il messaggio» e coniò il termine “villaggio globale”, dando forma alla capacità dei mezzi di comunicazione di plasmare la società, creare comunità interconnesse, abbattere i confini e modificare la nostra percezione della realtà, indipendentemente dal contenuto proposto. Al netto delle accuse di determinismo tecnologico, McLuhan fu sotto certi versi profetico: «Diceva che la televisione è un medium attivo che crea tribù di consumatori. E quando scriveva questo, si immaginava la possibilità di un’evoluzione simile a quella che stiamo vivendo con l’intelligenza artificiale. Quest’ultima è un meraviglioso strumento, ma non può fare tutto: può solamente connettere. Il problema non è che le macchine assomigliano troppo a noi, ma che noi – nella nostra pigrizia – cerchiamo di assomigliare sempre di più alle macchine. McLuhan ha previsto tutte queste cose in modo geniale, partendo dall’idea che la macchina risponda a un’esigenza del corpo che in qualche modo stordisce, narcotizza e sostituisce. Ma queste sostituzioni del corpo, come scriveva McLuhan, sono instabili. E ogni volta che un medium si impone, tutti gli altri devono cercare di riplasmarne l’equilibrio».
La macchina, che in questo caso è l’AI, crea e coltiva una solida relazione semantica con l’utente, che inserendo un prompt comunica le sue esigenze, anche frivole, in un determinato momento della giornata o della vita. È un rapporto, quello tra uomo e tecnologia, che sta facendo un salto di qualità a causa (o grazie) alla proliferazione dei musicisti virtuali: un contesto in cui ogni forma di immaginario diventa legittimo. «I contenuti variano non solo a seconda del pubblico che vuoi plasmare attraverso queste figure create con l’AI, ma anche a seconda del successo che avranno con quel tipo di pubblico», prosegue Serra, secondo cui l’industria musicale che sfrutta l’AI «costruisce le modalità psicologiche di un cantante», creandogli attorno una storia e un genere musicale perfettamente calzanti.
La pensa allo stesso modo Raffaele Lauretti, secondo cui il business degli artisti virtuali e della musica fatta con l’AI «punterà molto di più sull’estetica e sulla capacità di una traccia di adattarsi a determinate esigenze. Le persone oggi non si affezionano più alle etichette – che anni fa erano dei bollini di garanzia – ma al gusto del prompt, capace di selezionare la musica giusta per le tue necessità». «Quando ero ragazzo – riprende la parola Carlo Serra – c’erano i gruppi che volevano assomigliare ai Beatles, poi a Prince e così via. Ma, se ci pensi, era lo stesso lavoro fatto oggi con l’AI, solo che lì dietro c’erano un gruppo di produttori e un musicista in carne e ossa. E allora perché perdere tempo con un essere umano quando posso costruire direttamente un fantoccio?».
La domanda di Carlo Serra è provocatoria ed è in grado di spianare la strada a una riflessione sulle divergenze – al momento incolmabili – tra un cantante in carne e ossa e un musicista virtuale rappresentato da una label come All Music Works (che, nota a margine, non ha mai risposto alle richieste di intervista di Linkiesta Etc). Il primo punto riguarda, secondo il filosofo, «la crisi dell’artista, che è l’aspetto decisivo delle evoluzioni nel mondo musicale». Il pubblico è costantemente abituato ad assistere, più o meno in diretta, all’immagine del musicista che cambia, appassisce e si arrende allo scorrere del tempo, ai vizi, alle droghe, alle patologie fisiche e mentali.
Un crollo che, secondo Serra, «può succedere anche alla figura virtuale, che magari può “essere invecchiata” nel tempo, ma la differenza sostanziale è che queste creature non cambiano davvero e non crescono. O meglio, crescono solo attraverso chi sta dietro di loro. È un problema, perché ci sono pochi imprevisti, non ci sono variabili che possano esplodere». Si passa quindi dalla crisi dell’artista alla crisi del mondo produttivo, che avviene quando un musicista virtuale diventa noioso e prevedibile, e la gente smette di ascoltarlo: «Quando un gruppo di autori crea un calco della propria creatività con una struttura dialogica interna, non prevede nulla che possa essere d’attrito. Inoltre, con l’IA, noi utenti possiamo ridurre la performance esattamente a ciò che desideriamo. E questo sì, è meccanico», dice Serra.
Ciò non significa che la qualità sia necessariamente bassa. A febbraio di quest’anno, a pochi giorni da Sanremo 2025, su YouTube sono stati pubblicati centinaia di brani che proponevano i testi originali delle canzoni in gara sopra melodie inventate dall’AI, capace di studiare i repertori musicali degli artisti reali: «Già l’anno scorso avevamo avvistato il fenomeno, ma i brani e i profili erano abbastanza grossolani per qualità. Adesso, grazie ai progressi enormi dell’intelligenza artificiale, i brani sono tantissimi e spesso convincenti», ha dichiarato Luca Vespignani, amministratore delegato di DpC (tra le aziende leader nella tutela dei contenuti online), a Repubblica.
Lo stesso Serra ha ammesso che la nuova musica fatta con l’AI ha stravolto positivamente i suoi pregiudizi («saranno delle riproduzioni di cose già fatte»), perché ormai si sta consolidando un business maturo e non più fondato – come avveniva fino a quattro o cinque anni fa – sulla creazione di canzoni simili a brani celebri e saldamente radicati nell’immaginario collettivo: «Ora il genere se lo devono inventare, non lo devono più copiare», dice Serra, che torna infine sulla grande questione dell’immaginabilità degli output artistici dell’intelligenza artificiale. «Quando si lavora con materiali plastici che si possono continuamente riplasmare, le possibilità di errore diminuiscono. Puoi creare storie, puoi raccontare tutto, ma mancherà sempre quell’elemento imprevedibile».
È difficile capire cosa accadrà in futuro. L’intelligenza artificiale, a differenza dei metaversi per come li aveva immaginati Mark Zuckerberg, è qui per restare, ma nel business musicale potrebbe crearsi – per i motivi di cui sopra – una saturazione. Il punto, però, non è la nostra capacità (o incapacità) di affezionarci a un artista virtuale, perché tutti, per esempio, da bambini provavamo emozioni forti nei confronti dei personaggi dei cartoni animati. Come detto, la pratica compositiva della musica creata con l’AI è mossa da un desiderio attivo. Ecco perché, conclude Carlo Serra, il problema etico è un altro: «Capire i movimenti del desiderio umano attraverso queste strutture iconiche e il modo in cui esse rispondono ai nostri bisogni». Una missione che potrebbe diventare possibile grazie alla progressiva democratizzazione di queste tecnologie.
L'articolo Una musica senza margini d’errore può ancora emozionare? proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0






























































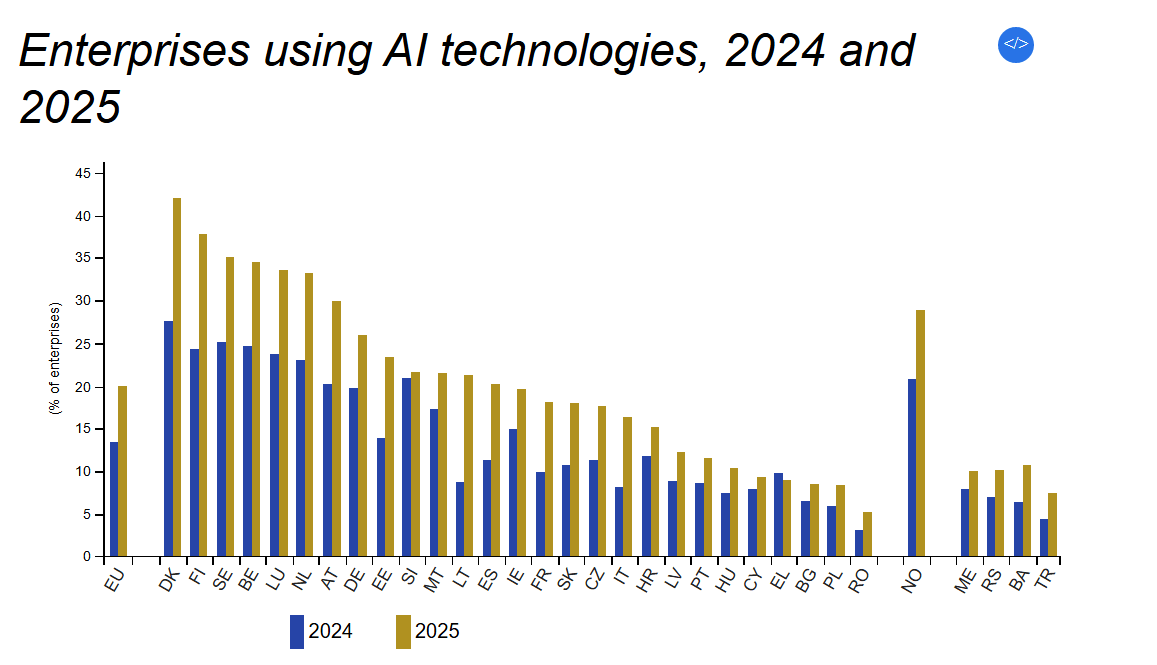
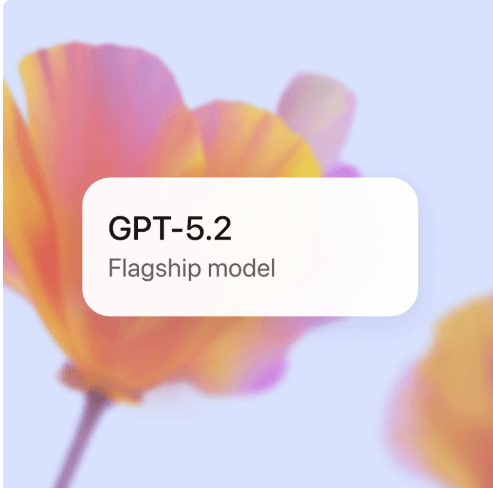






























































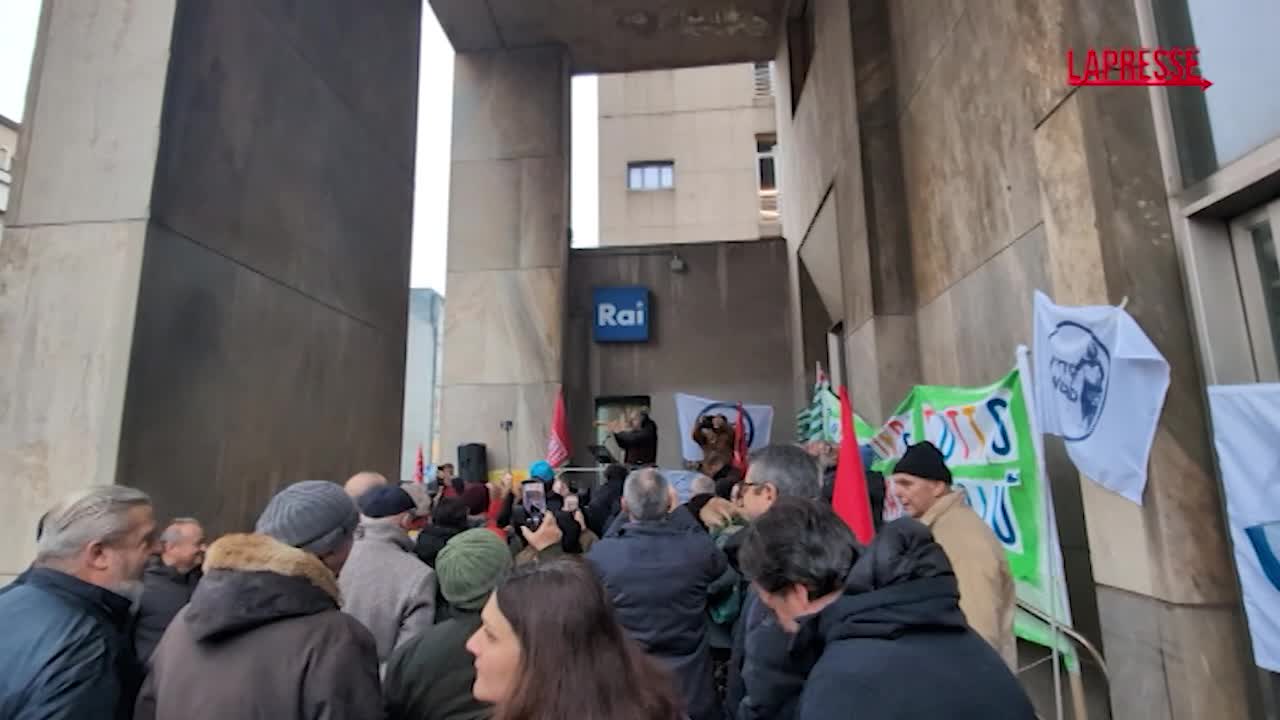






















































_(47)-1765888135875.jpg--piemonte__40_nuovi_agenti_di_polizia_locale__il_98__corso_regionale_si_chiude_al_castello_visconteo_sforzesco_di_novara.jpg?1765888136053#)
-1732265778353.png--domodossola_milano__stop_ai_treni_durante_le_vacanze_di_natale__ecco_cosa_si_ferma.png?1732265780351#)







-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)





















































