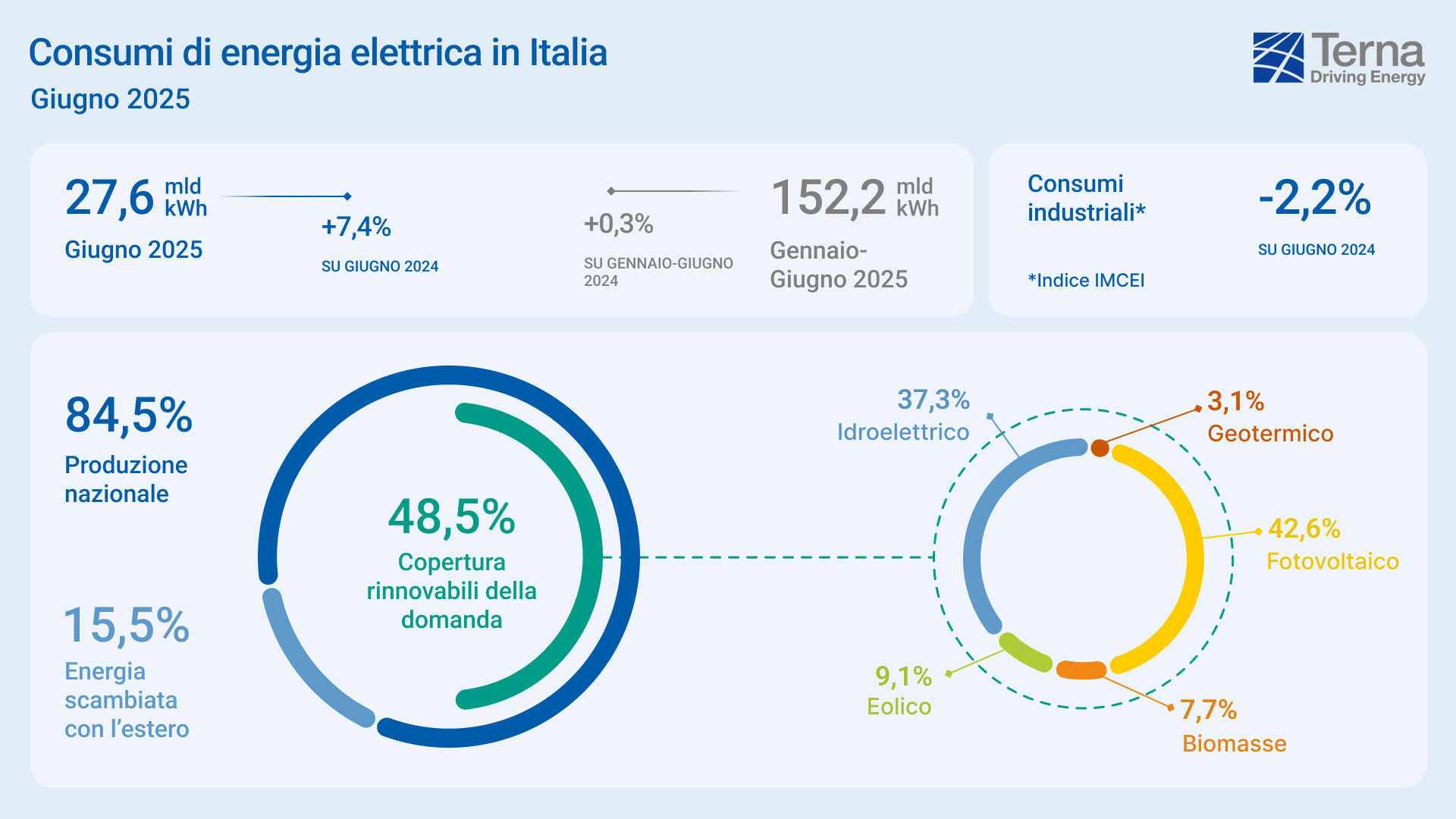I sei sopravvissuti di Hiroshima raccontano il peso morale del restare vivi per caso


Il 6 agosto 1945, esattamente alle otto e quindici minuti del mattino, ora del Giappone, nel momento in cui la bomba atomica esplodeva su Hiroshima, la signorina Toshiko Sasaki, impiegata all’ufficio personale della Fonderia di stagno dell’Asia orientale, si era appena seduta al suo posto negli uffici dello stabilimento e stava girandosi a parlare con la ragazza della scrivania accanto.
Nello stesso istante, il dottor Masakazu Fujii si stava accomodando a gambe incrociate nella veranda del suo ospedale privato, affacciata su uno dei sette fiumi a delta che suddividono Hiroshima, a leggere l’“Asahi” di Osaka; la signora Hatsuyo Nakamura, vedova di un sarto, era alla finestra della cucina e osservava un vicino che stava abbattendo la propria casa che sorgeva sulla linea tagliafuoco della difesa antiaerea; padre Wilhelm Kleinsorge, un prete tedesco della Compagnia di Gesù, steso in mutande su una branda al terzo e ultimo piano dell’edificio che ospitava la missione del suo ordine, leggeva una rivista gesuita, “Stimmen der Zeit”; il dottor Terufumi Sasaki, giovane membro dell’équipe chirurgica del grande, moderno ospedale della Croce Rossa della città, percorreva un corridoio dell’ospedale con in mano un campione di sangue per un test di Wassermann; e il reverendo Kiyoshi Tanimoto, pastore della Chiesa metodista di Hiroshima, era fermo davanti al portone dell’abitazione di un uomo ricco, nel sobborgo occidentale di Koi, e si preparava a scaricare da un carretto le cose che aveva evacuato dalla città per paura del massiccio attacco dei b-29 che tutti si attendevano su Hiroshima.
Centomila individui furono uccisi dalla bomba atomica, e questi sei furono tra i superstiti. Si chiedono ancora perché sono vivi, mentre tanti altri sono morti. Ciascuno di loro può citare tanti piccoli elementi fortuiti o atti deliberati – un passo fatto appena in tempo, la decisione di entrare in casa, la scelta di un mezzo pubblico al posto di un altro – che lo hanno salvato. E ora ciascuno di loro sa che nell’atto di sopravvivere ha vissuto dieci vite e visto più morti di quanti avrebbe mai immaginato. In quel momento, nessuno di loro sapeva nulla.
Quel mattino il reverendo Tanimoto si alzò alle cinque. Era solo in canonica, perché da qualche tempo sua moglie andava a passare la notte con la figlioletta di un anno presso un’amica a Ushida, un sobborgo a nord. Di tutte le città importanti del Giappone, solo due, Kyoto e Hiroshima, non avevano ricevuto la visita in forze dei b-san, o Mr. B, come i giapponesi chiamavano, con un misto di rispetto e di mesta familiarità, i b-29; e Tanimoto, come tutti i suoi vicini e amici, non riusciva quasi più a reggere l’ansia. Aveva sentito descrivere in sgradevole dettaglio gli attacchi massicci a Kure, Iwakuni, Tokuyama e altre città vicine; era sicuro che presto sarebbe venuto il turno di Hiroshima. Aveva dormito male quella notte, perché c’erano stati parecchi allarmi aerei.
Allarmi di quel tipo risuonavano ogni notte a Hiroshima da settimane, perché a quel tempo i b-29 stavano usando il lago Biwa, a nord-est della città, come punto di raccolta, e qualunque obiettivo gli americani progettassero di colpire, le Superfortezze affluivano sopra la costa nei pressi di Hiroshima. La frequenza degli allarmi e la prolungata assenza di Mr. B dalla città avevano innervosito gli abitanti; girava voce che gli americani volessero riservare a Hiroshima un trattamento speciale.
Tanimoto era un uomo piccolo che parlava, rideva e gridava facilmente. Portava i capelli neri con la riga in mezzo e piuttosto lunghi; la prominenza delle ossa frontali appena sopra le sopracciglia, e la piccolezza di baffi, bocca e mento, gli conferivano un curioso aspetto vecchio-giovane, fanciullesco eppure saggio, debole e insieme fiero. I suoi movimenti erano rapidi e nervosi, ma con un ritegno che rivelava la sua natura cauta e riflessiva. Ed effettivamente, nei difficili giorni prima della bomba stava dando mostra proprio di quelle qualità.
Oltre ad avere mandato la moglie a trascorrere le notti a Ushida, Tanimoto aveva trasferito tutto ciò che c’era di trasportabile nella sua chiesa, situata nel popoloso distretto residenziale di Nagaragawa, in una casa di proprietà di un industriale del rayon a Koi, a tre chilometri dal centro della città. L’uomo del rayon, un certo signor Matsui, aveva aperto la sua tenuta, allora non abitata, a un gran numero di amici e conoscenti, in modo che potessero evacuare tutto quel che volevano a distanza di sicurezza dall’area dei probabili obiettivi.
Tanimoto non aveva avuto difficoltà a spostare da solo sedie, innari, Bibbie, paramenti d’altare e registri della chiesa con un carretto a mano, ma per la consolle dell’organo e il pianoforte verticale aveva bisogno d’aiuto. Il giorno prima un suo amico di nome Matsuo gli aveva dato una mano a trasportare il pianoforte a Koi; in cambio, lui aveva promesso di aiutare quel giorno il signor Matsuo a portar via le cose appartenenti a una delle figlie. Ecco perché si era alzato così presto.
Tanimoto si preparò la colazione. Si sentiva terribilmente stanco. Lo sforzo di trasportare il pianoforte il giorno prima, una notte insonne, settimane di preoccupazione e di dieta squilibrata, gli obblighi della sua parrocchia – tutto contribuiva a renderlo poco preparato al lavoro di quel giorno.
C’era anche un’altra questione: Tanimoto aveva studiato teologia all’Emory College di Atlanta, in Georgia; si era diplomato nel 1940; parlava un eccellente inglese; portava abiti americani; aveva intrattenuto una corrispondenza epistolare con vari amici americani fino allo scoppio della guerra; e fra una popolazione ossessionata dal timore di essere spiata – forse lo temeva persino lui – si sentiva sempre più a disagio.
Era stato più volte interrogato dalla polizia, e solo qualche giorno prima aveva saputo che un suo conoscente di una certa influenza, un certo signor Tanaka, ufficiale in pensione della flotta di motonavi Toyo Kisen Kaisha, un anticristiano famoso a Hiroshima per i suoi ostentati atti di beneficenza e famigerato per il suo dispotismo personale, aveva detto in giro che non bisognava fidarsi di lui.
Per compensare e dimostrarsi pubblicamente un buon giapponese, Tanimoto aveva assunto la presidenza del suo tonarigumi, ovvero l’Associazione di quartiere, e questa carica aveva aggiunto agli altri suoi doveri e preoccupazioni il compito di organizzare la difesa antiaerea per una ventina di famiglie.
Prima delle sei e mezzo, quella mattina, Tanimoto uscì per recarsi a casa di Matsuo. Lì scoprì che il carico che dovevano trasportare era costituito da un tansu, un grosso armadio giapponese, pieno di abiti e di oggetti casalinghi. I due uomini si avviarono. Era un mattino perfettamente limpido e così caldo che la giornata si preannunciava opprimente.
Dopo qualche minuto, si udì la sirena dell’allarme antiaereo – un fischio lungo un minuto che segnalava aerei in avvicinamento, ma che per gli abitanti di Hiroshima indicava un basso grado di pericolo, dato che suonava tutte le mattine a quell’ora quando passava un aereo meteorologico americano.
I due uomini spinsero e trainarono il carretto a mano per le strade della città. Hiroshima era una città disposta a ventaglio, che sorgeva in gran parte sulle sei isole formate dai sette corsi d’acqua che si diramavano dal fiume Ota; i principali quartieri commerciali e residenziali, che occupavano una decina di chilometri quadrati nel centro della città, ospitavano i tre quarti della popolazione, ridotta in seguito a vari programmi di evacuazione da un picco in tempo di guerra di trecentottantamila persone a circa duecentoquarantacinquemila.
Le fabbriche e gli altri quartieri residenziali, o sobborghi, si stendevano compatti ai margini della città. A sud c’era la zona portuale, un aeroporto, e il Mare interno costellato di isole. Una catena di montagne circondava gli altri tre lati del delta. Tanimoto e Matsuo si inoltrarono nella zona commerciale, già piena di gente, attraversarono due dei fiumi fino alle ripide strade di Koi, e da lì salirono verso la periferia e le colline.
Quando iniziarono a risalire una valle lontana dall’ammasso di case, suonò il cessato allarme. (Gli operatori radar giapponesi, rilevando solo tre aerei, pensarono che fossero in ricognizione.) Spingere il carro fino alla casa dell’uomo del rayon fu faticoso, e i due uomini, dopo aver percorso il vialetto fino ai gradini d’ingresso, si fermarono un attimo a riposare.
Un’ala dell’edificio nascondeva la città alla loro vista. Come molte abitazioni in questa zona del Giappone, la casa aveva una struttura in legno e pareti anch’esse di legno che sostenevano un pesante tetto di tegole. Il salotto, stipato di biancheria e abiti arrotolati, sembrava una fresca cantina piena di cuscini gonfi. Di fronte alla casa, a destra della porta, c’era un ampio giardino roccioso ben curato. Non si sentiva rumore di aerei. Il mattino era silenzioso; il luogo fresco e piacevole.
Poi uno spaventoso lampo luminoso squarciò il cielo. Tanimoto ricorda distintamente che si mosse da est verso ovest, dalla città verso le colline. Sembrava una lamina di sole. Sia lui sia Matsuo ebbero un moto di terrore, ed entrambi ebbero il tempo di reagire (perché si trovavano a circa tre chilometri e mezzo dal centro dell’esplosione). Matsuo salì di corsa i gradini e si precipitò in casa, tuffandosi fra i rotoli di biancheria e seppellendosi lì sotto. Tanimoto fece quattro o cinque passi e si gettò fra due grossi massi in giardino, abbracciando stretto uno di essi.
Dato che aveva la faccia premuta contro la pietra, non vide ciò che accadde. Sentì una pressione improvvisa, e poi schegge e pezzi di legno e frammenti di tegole che gli cadevano addosso. Non udì alcun boato. (Quasi nessuno a Hiroshima ricorda di aver udito il rumore della bomba. Ma un pescatore nel suo sampan sul Mare interno vicino a Tsuzu, l’uomo presso cui vivevano la suocera e la cognata di Tanimoto, vide il lampo e udì una tremenda esplosione; era a più di trenta chilometri da Hiroshima, ma il boato fu più forte di quando i b-29 colpirono Iwakuni, a soli otto chilometri di distanza.)
Quando osò alzare la testa, Tanimoto vide che la casa dell’uomo del rayon era crollata. Pensò che fosse stata centrata in pieno da una bomba. Intorno si erano levate nuvole di polvere così fitte da creare una sorta di crepuscolo. In preda al panico, senza pensare in quel momento a Matsuo sotto le rovine, si precipitò in strada. Mentre correva notò che il muro di cemento della proprietà era franato verso la casa, anziché in direzione opposta.
In strada la prima cosa che vide fu la squadra di soldati che in precedenza stava scavando nel fianco opposto della collina uno delle migliaia di rifugi con cui i giapponesi sembravano decisi a resistere all’invasione, collina per collina, vita per vita; i soldati stavano uscendo dal buco, dove avrebbero dovuto essere al sicuro, e avevano del sangue che colava dalla testa, dal petto e dalla schiena. Erano ammutoliti e storditi.
Sotto quella che sembrava una nuvola di polvere circoscritta, il giorno si fece sempre più buio.

“Hiroshima. Il racconto di sei sopravvissuti”, di John Hersey, Utet Libri, 192 pagine, 17 euro
L'articolo I sei sopravvissuti di Hiroshima raccontano il peso morale del restare vivi per caso proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0






























































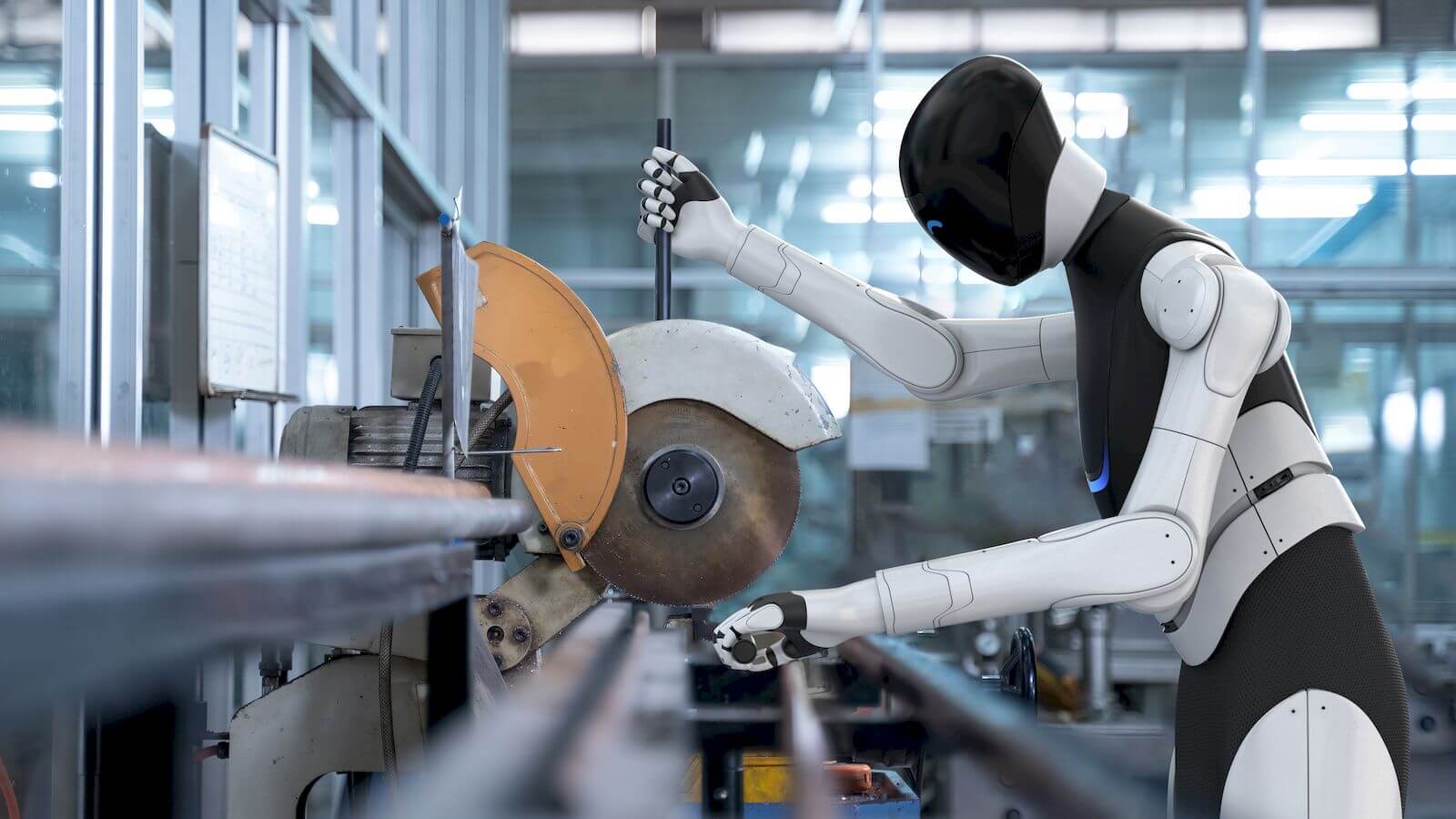



















/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/08/europa-paesi-con-salari-minimi-piu-alti-e-piu-bassi.jpg)
/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/08/wp_drafter_179955.jpg)
/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/08/con-trade-republic-hai-carta-debito-visa-2-percento-liquidita.jpg)
/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/08/telemarketing-stretta-dal-19-agosto-ecco-la-novita.jpg)






































































































-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)