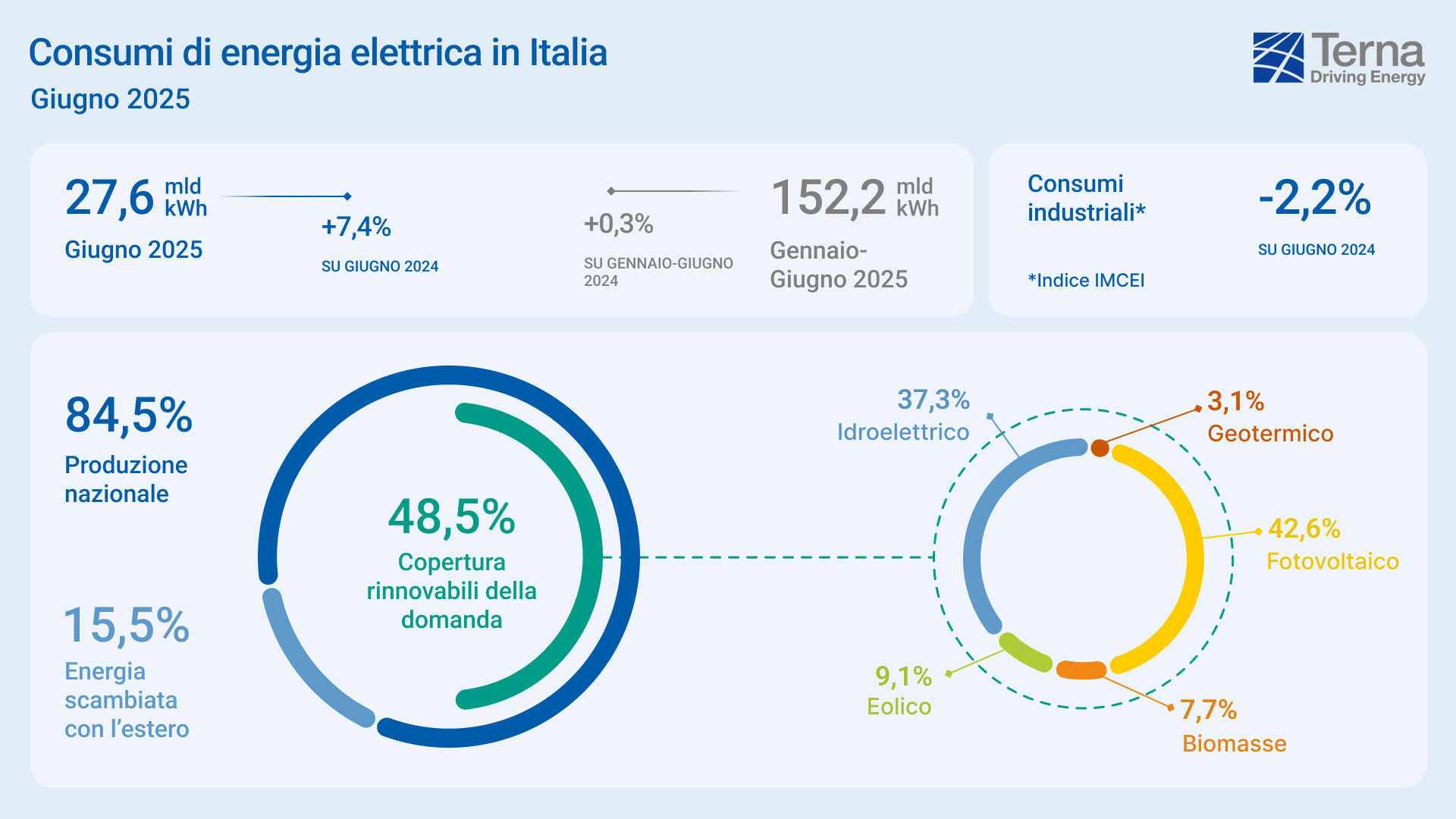Questa non è una recensione degli Oasis a Wembley


Sono contraria alle recensioni dei concerti, perché possono produrre nel lettore solo sentimenti deludenti. Un concerto non è un film, non è un disco, non è un libro, un concerto è un evento irripetibile che nessun mezzo di registrazione può raccontare. Quando un concerto viene ripreso o inciso o scritto non è più un concerto, ma diventa un film, o un disco, o una ricondivisione su Instagram dell’ufficio stampa. Il concerto è una forma di verità, e la verità non la puoi raccontare quando sei invitato come ospite, ma solo quando paghi il biglietto.
Il flusso di soldi che abbiamo immesso nel conto corrente dei Gallagher, credo pari al Pil di un qualunque Paese europeo, giustificherebbe qualsiasi risentimento o delusione, ma non ce ne saranno. Risponderò agli infelici che dicono che la reunion degli Oasis sia stata tutta una questione di soldi con le parole di un Noel Gallagher 1996 doc: «Mi chiedi se sono felice? Ascolta: ho ottantasette milioni di sterline in banca. Ho una Rolls-Royce. Ho tre stalker. Sto per entrare nel consiglio di amministrazione del Manchester City. Probabilmente faccio parte della più grande band del mondo. Sono felice di tutto questo? No, non lo sono. Voglio di più».
Certo, comprare una Rolls-Royce senza avere la patente sarebbe stato già un di più per uno che viene dalla periferia, avere due stalker in più di John Lennon pure per non parlare dell’ingresso nel consiglio di amministrazione della squadra del cuore quando sei un maschio eterosessuale, ma diventare un sex symbol a cinquant’anni a discapito di un fratello che ha sposato Patsy Kensit è oltre ogni immaginazione. Poi, se consideriamo un biglietto e una maglietta una rapina, o siete influencer o non avete mai fatto una rapina.
Il mio amico che dice che il concerto è stata una presa di coscienza ha ragione, e lo è stata nella misura in cui uno capisce chi era, e cosa è diventato. La conclusione inevitabile è che uno si rende conto di essere sempre stato fan del fratello sbagliato, del gruppo sbagliato – la prima cosa che si vedeva arrivando a Wembley era un monitor con scritto «the original blur rivals» –, di aver vissuto andando in giro a dire che il giorno più bello della tua vita è stato quello del tuo matrimonio o quando è nato tuo figlio, e lì ti rendi conto di aver sempre vissuto nella menzogna.
Mio figlio, ribattezzato dalla curva «absolute legend», con la gente all’uscita che gli stringeva la mano, questo concerto se lo ricorderà per sempre anche se non sapeva chi fossero gli Oasis. A Wembley c’erano novantamila persone vestite tutte uguali, novantamila adulti che piangevano come vitelli, nessun PhD in bio, nessuna she/they dai capelli verdi, nessuna bandiera, niente cani da borsetta, nessun influencer, l’unica etichetta era quella dell’Adidas, non c’è stata nessuna rivendicazione se non essere quello che si è stati, quarantenni che hanno vissuto la miglior scena musicale possibile da giovani, e che per tre ore hanno riconosciuto la propria fortuna.
Non era nostalgia, era accettazione della propria storia. Gli Oasis, sorpassando Churchill e Lady D tra le mine antiuomo, hanno realizzato il grande sogno democratico: tutti i concerti hanno la stessa scaletta, lo stesso minutaggio, ogni fan ha esattamente quello che hanno gli altri, tutti hanno deciso di andare a prendere le birre negli stessi punti di scaletta – dopo il primo ritornello di “D’you know what I mean” e sulla coda di “Rock n’Roll star” –, ognuno ha avuto esattamente quello che voleva. Eravamo tutti felici, e lo sapevamo.
Quello che so è che nessuna band al mondo potrà mai muovere quello che hanno mosso gli Oasis, e questo perché hanno raccontato una storia. Il fatto che due fratelli non si siano parlati per quindici anni e che soprattutto non abbiano mai chiesto di non parlare dell’altro durante le interviste – non è insolito che quelli famosi perché parenti di qualcuno abbiano il barbaro coraggio di chiedere di non parlare di quel parente durante le interviste, e allora cosa ci parliamo a fare – raccontano un’epica che non c’è più. Per avere un brivido oramai dobbiamo affidarci a Ultimo che si risente con i giornalisti, e meno male che lo fa, o a guardare il Superbowl di Kendrick Lamar.
L’intelligenza di gestione di questa reunion – la compagna di Liam nonché sua agente spero vinca sia il Nobel per la pace che quello per l’economia – sta tutta nel fatto che non ci siano foto di Liam e Noel insieme fuori dal palco, c’è solo uno scatto con due ragazzini ma loro due non sono vicini. Gli Oasis, non Gallagher, non pubblicano foto con loro, non le pubblicano i figli, le mogli, le ex mogli, gli amici, i calciatori del City. Li vedremo insieme nel documentario in lavorazione, che immagino sia la riproposizione laica del conclave.
All’uscita da Wembley c’erano novantamila persone che dovevano prendere la stessa metro. I poliziotti si sono messi con i megafoni ai lati della coda a mandare le canzoni degli Oasis, si partiva a cantare, i poliziotti cantavano, la coda si fermava e defluiva in maniera ordinata, poi ripartiva un altro pezzo, e tutti a piangere, pure i poliziotti. «Scrivo perché che cazzo si dovrebbe fare quando finisce il campionato? Sedersi e guardare Desperate Housewife?» diceva Noel nel 2008, e noi gli saremo sempre grati di non essersi messo a guardare la tv.
L'articolo Questa non è una recensione degli Oasis a Wembley proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0






























































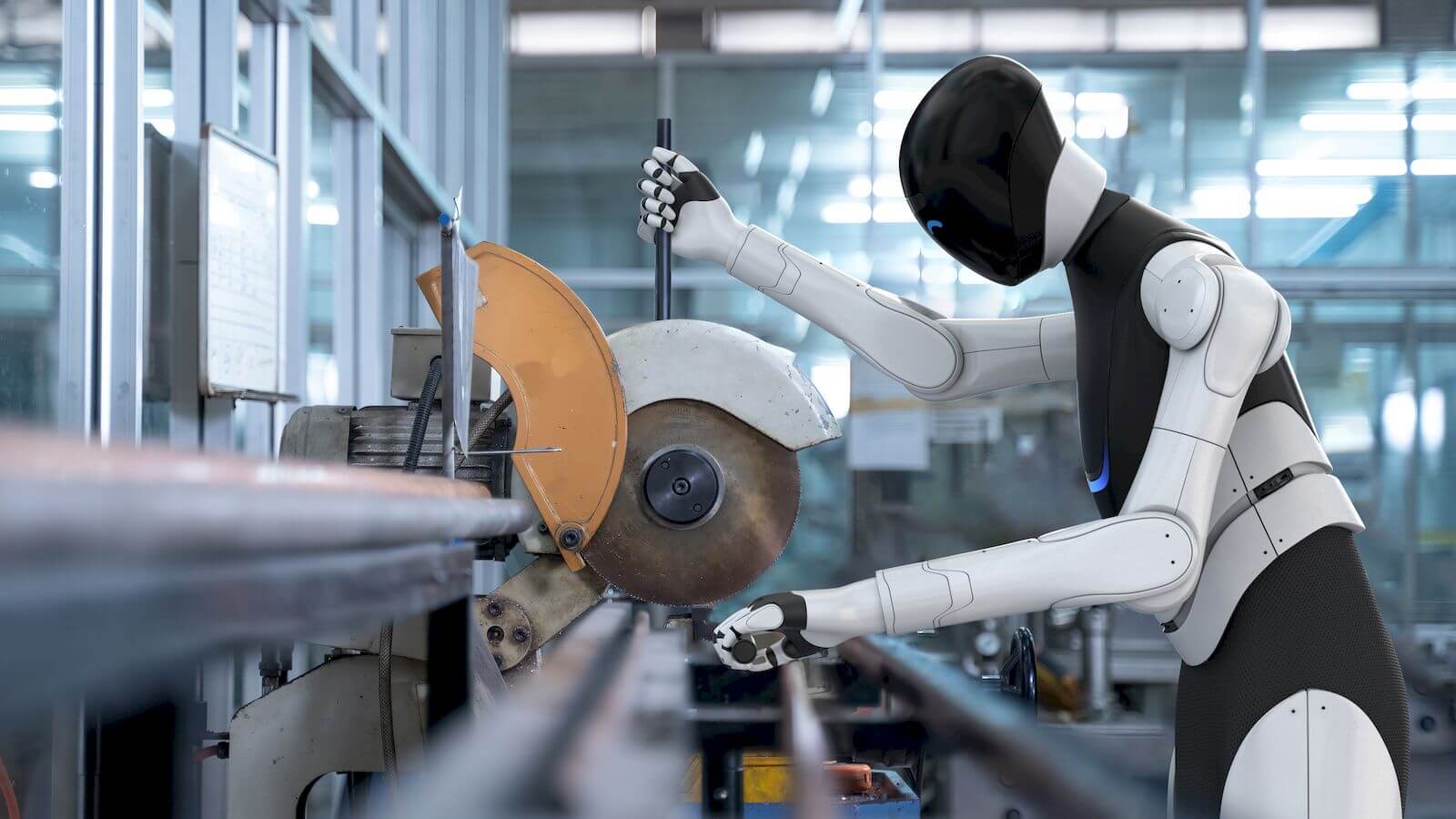



















/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/08/europa-paesi-con-salari-minimi-piu-alti-e-piu-bassi.jpg)
/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/08/wp_drafter_179955.jpg)
/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/08/con-trade-republic-hai-carta-debito-visa-2-percento-liquidita.jpg)
/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/08/telemarketing-stretta-dal-19-agosto-ecco-la-novita.jpg)






































































































-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)