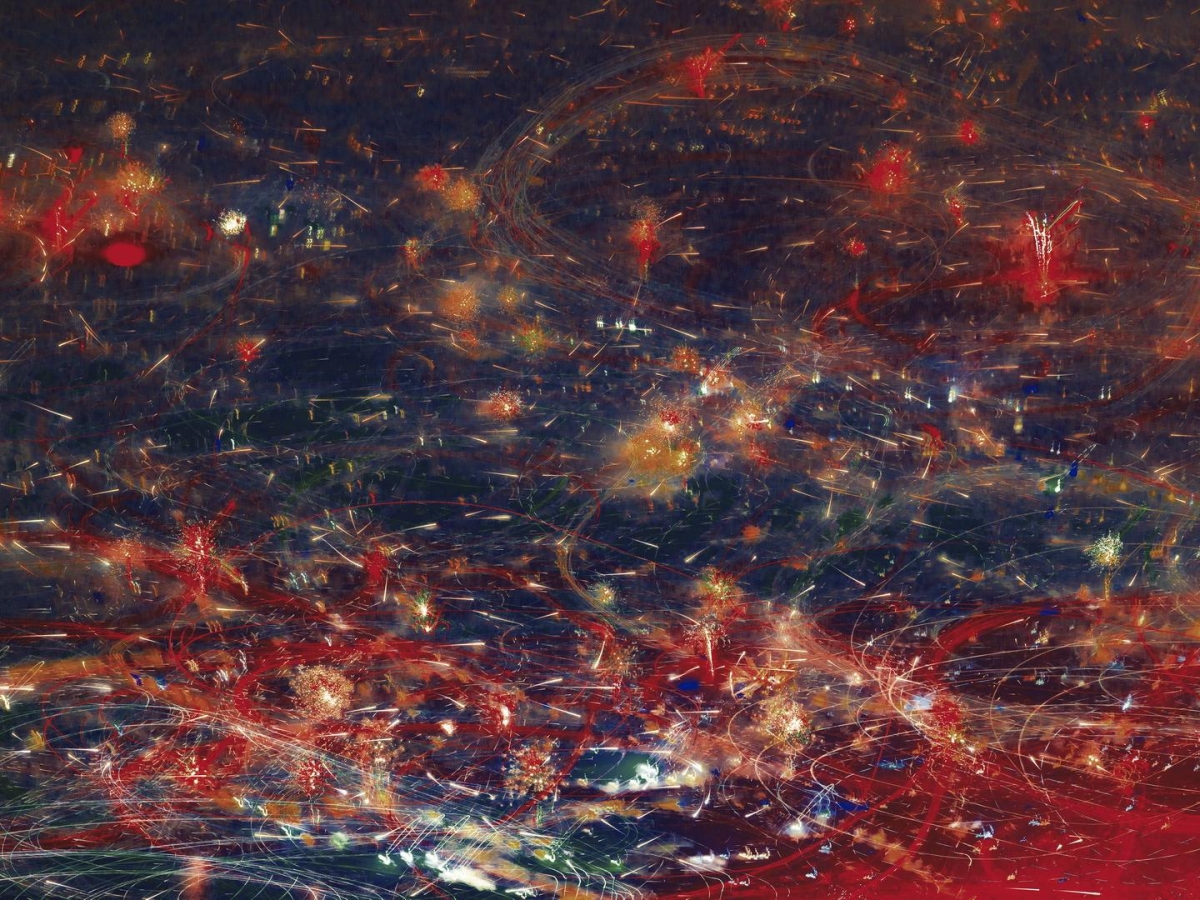Trent’anni dal genocidio di Srebrenica: ricordare per non ripetere

 L'intervento dell'Arcivescovo al convegno
L'intervento dell'Arcivescovo al convegno  L'intervento dell'Arcivescovo al convegno
L'intervento dell'Arcivescovo al convegno Trent’anni della strage di Srebrenica, trent’anni di una ferita che non si rimargina, per quello che dal 2024 è ufficialmente un genocidio, come ha sancito l’Assemblea generale delle Nazioni Unite proclamando l’11 luglio Giornata internazionale di riflessione e commemorazione del genocidio di Srebrenica.
Di questo momento tragico, che portò alla morte di 8372 persone (un dato ancora in forse e tanti resti a cui si cerca di dare un nome), consumatosi tra il 9 e l’11 luglio 1995 nell’enclave “bosgnacca” (musulmana) della Bosnia Erzegovina, con la strage, perpetrata da unità dell’Esercito della Repubblica Serba di Bosnia Erzegovina guidate dal tristemente noto generale Ratko Mladić, si è parlato in un importante e affollato incontro svoltosi presso la Triennale di Milano. Promosso da Caritas ambrosiana e da Ipsia, Ong delle Acli, insieme ad altri soggetti che hanno operato in diversi territori del paese balcanico, l’evento ha visto la presenza e l’intervento finale del l’Arcivescovo di Milano.
I saluti istituzionali

«A 30 anni di distanza, occorre ricordare e riflettere su che cosa può succedere anche nell’Europa cristiana. Il nostro compito – spiega Luciano Gualzetti, direttore di Caritas ambrosiana che, con i “ragazzi di percorsi di pace”, ha pensato di dover ricordare i fatti del ’95 in un evento pubblico – è stato ed è quello di lavorare su progetti per favorire il dialogo partendo dagli ultimi, con l’insegnamento che la pace vince solo se ci sono le condizioni per una pace duratura».
Dopo il saluto del presidente della Triennale, Stefano Boeri, che dice «credo che oggi non possiamo non interrogarci su quanto succede a Gaza o in Ucraina. Siamo felici di poter riflettere sulla memoria, ma anche sull’amnesia collettiva che si deposita facilmente su queste vicende», a prendere la parola è la vicesindaco Anna Scavuzzo, che anche nella sua veste di volontaria nel sostegno umanitario nell’ex Jugoslavia, ricorda: «Sono stati anni in cui le coscienze sono state interrogate. Credo che la convivialità delle differenze, come diceva don Tonino Bello non è facile, ma è uno sforzo necessario. Srebrenica è un pezzo della nostra storia. Porto con orgoglio il saluto di Milano, sapendo quanti nella nostra città si sono spesi per non dimenticare e fare la differenza. Abbiamo bisogno di memoria, giustizia e riconciliazione. In questo luogo di cultura occorre parlare di pace anche con la cultura».

Delfina Colombo, presidente Acli Milano, da parte sua, aggiunge: «Dobbiamo avere il coraggio della pace senza che l’indifferenza prenda il posto della coscienza». Un’indifferenza impossibile ad ascoltare la ricostruzione storica del massacro illustrata da Silvia Maraone, coordinatrice dei progetti Ipsia in Bosnia Erzegovina, partita 30 anni fa come volontaria e rimasta in quei Paesi come cooperante. «Srebrenica ci doveva insegnare qualcosa, come Norimberga, ma non è stato così e per non restare in silenzio è importante essere qui oggi».
Storia di un massacro
Ma come raccontare un genocidio? «Dal punto di vista storico, anche se mancano molti elementi. Nel 1993, una risoluzione del Consiglio di sicurezza già chiedeva a Serbia e Montenegro di evitare il genocidio, ma in verità, solo questo si stava preparando: con la secessione della Croazia, nel 1991, iniziano già i primi massacri. La Bosnia Erzegovina – con una popolazione del 43% bosgnacchi, 31% di serbi, 17% di croati e qualche minoranza – il 3 marzo 1992 dichiara, poi, la sua indipendenza e già da allora prendono avvio le violenze. Da qui l’intricata e tragica vicenda etnica che portò alla strage di più di 8000 persone. «Una strage che ha bisogno di organizzazione e pianificazione e che non si improvvisa, con le sue 3000 fosse comuni primarie spostate successivamente in secondarie e terziarie per la paura di essere scoperti».
E, di fronte a tanto orrore, poco consola che vi siano almeno dei condannati a vita dalla Corte internazionale di Giustizia e dal Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia, in particolare Ratko Mladić e Radovan Karadžić, all’epoca presidente della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina.
La testimonianza di chi c’era
Azra Ibrahimovic era una ragazzina negli anni del genocidio e, oggi, operatrice umanitaria in Ong internazionali, è una testimone preziosa. «Vivevo al confine tra Bosnia e Serbia, da cui sono dovuta fuggire con i miei genitori. Mi trovavo nella città di Tuzla come profuga, con mia madre, essendo separate da mio padre e da mio fratello nemmeno 16enne, quando ho saputo del massacro. Ogni giorno aspettavamo i convogli che venivano da Srebrenica nel 1995: poi abbiamo saputo che erano già stati arrestati nel 1992, uccisi e buttati nella Drina, il fiume che divide la Serbia dalla Bosnia Erzegovina»

«Tante persone, nonostante tutto, sono tornate per cercare di ricostruire una vita normale a Srebrenica, pur vivendo a fianco di quelle tombe bianche del memoriale di Potočari con al centro la sua lapide su cui è inciso il numero 8372 seguito da tre puntini perché ancora non si sa quanti siano stati veramente i morti. Oggi ci sono le case, gli abitanti ma si percepisce la presenza dell’assenza. E quando ritornano gli anniversari come l’11 luglio, i ponti fragili che si sono costruiti, aiutandosi magari gli uni gli altri, cadono, perché molti negano il genocidio. Quando si parla di giustizia non riparata occorre ricordare anche questo: ad esempio, i bambini che vanno a scuola in città devono studiare la lingua serba e un programma di storia dove non si parla di ciò che è accaduto perché oggi Sebrenica è appartenente all’entità della Repubblica serba di Bosnia Erzegovina».
Parole piene di dolore, quelle di Azra, ma anche di speranza nel futuro di una donna coraggiosa che già subito dopo la strage tornò ad aiutare chi aveva meno di lei in un campo profughi, a cui si uniscono quelle dell’Arcivescovo.
L’intervento dell’Arcivescovo
«Nella mia ingenuità ero convinto che fosse naturale fare il bene ed evitare il male, che la pace fosse un bene desiderabile e la guerra una assurdità da evitare; che fosse spontaneo aiutare chi soffre a trovare sollievo o almeno incoraggiarlo a sperare. Ero convinto che la legge fosse da rispettare e la trasgressione da sanzionare. Ma la storia smentisce la mia ingenuità perché ci sono persone che dicono che la guerra sia meglio della pace, il male meglio del bene, la crudeltà più divertente del prendersi cura, la vendetta più giusta del perdono. Ma come si può comprendere la crudeltà? Quali forme di contagio avvelenano gli animi di un popolo fino a indurlo all’assurdo di eseguire un ordine di sterminio?».
L’uso delle parole
Un enigma, come lo definisce il vescovo Mario, che inizia dall’uso delle parole. «Parole smarrite, parole, cacciate via da tutte le parti, coperte dal rumore delle parole gridate, dei sentimenti violenti. Parole come buon senso, verità – che non si sa più dove sia – e responsabilità che non si sa che cosa voglia dire. «Ogni guerra comincia sempre con la menzogna: quella terra è nostra; quel popolo è nemico; quella religione è una minaccia; quella gente ha fatto violenza alla nostra gente. La storia non è una linea che va verso il meglio, ma va dove la facciamo andare e a noi, quindi, compete la responsabilità di vigilare».
Insomma, il dovere della vigilanza e del rispondere – prosegue l’Arcivescovo – alla propria coscienza, agli altri, alla comunità locale e internazionale, alle generazioni future e a Dio», laddove questo senso della vita come responsabilità è negato dall’individualismo contemporaneo.

«Occorre vigilare sulle parole perché le parole non siano contagiate dal veleno. Per esempio: si dice giustizia, ma si intende vendetta; si dice memoria, ma si intende risentimento; si dice nazione, ma si intende egoismo nazionale e imperialismo e non l’aspetto nobile della nazione, ma la sua strumentalizzazione».
Inoltre, serve «prendersi cura delle vittime, come hanno fatto e fanno Caritas e Acli, perché coloro che subiscono violenza invocano aiuto e giustizia». Infine, occorre invocare le istituzioni superiori, perché, come Srebrenica ha insegnato (ai tempi fu catastrofica l’ignavia della Nato), «nel discredito degli organismi internazionali si insinua il contenzioso insolubile. Se non si riconosce un punto di riferimento condiviso al quale si conferisce un potere reale, la comunità internazionale è impotente e gli egoismi nazionali, la coltivazione del risentimento e il desiderio di vendetta, si traducono nella desolazione e nell’assurdità dei genocidi».
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0


















































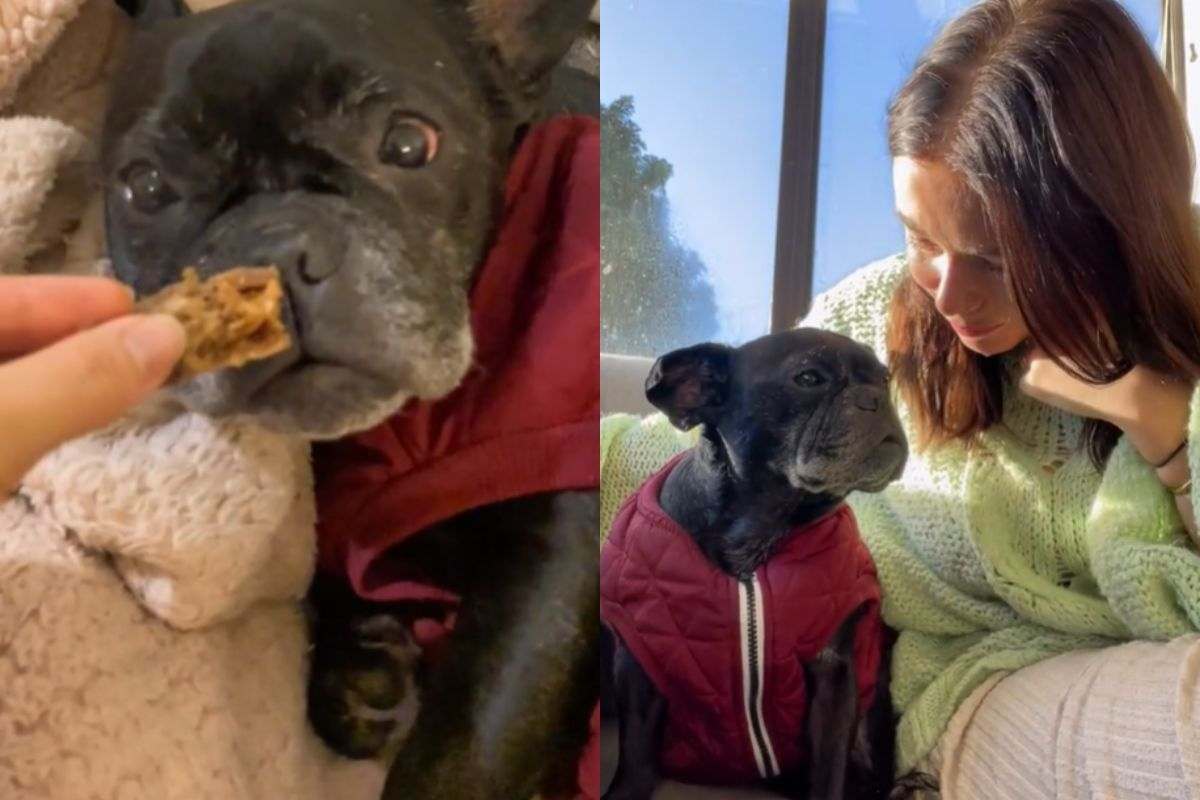















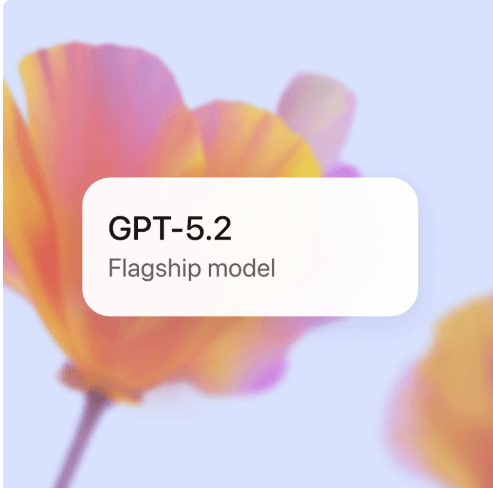
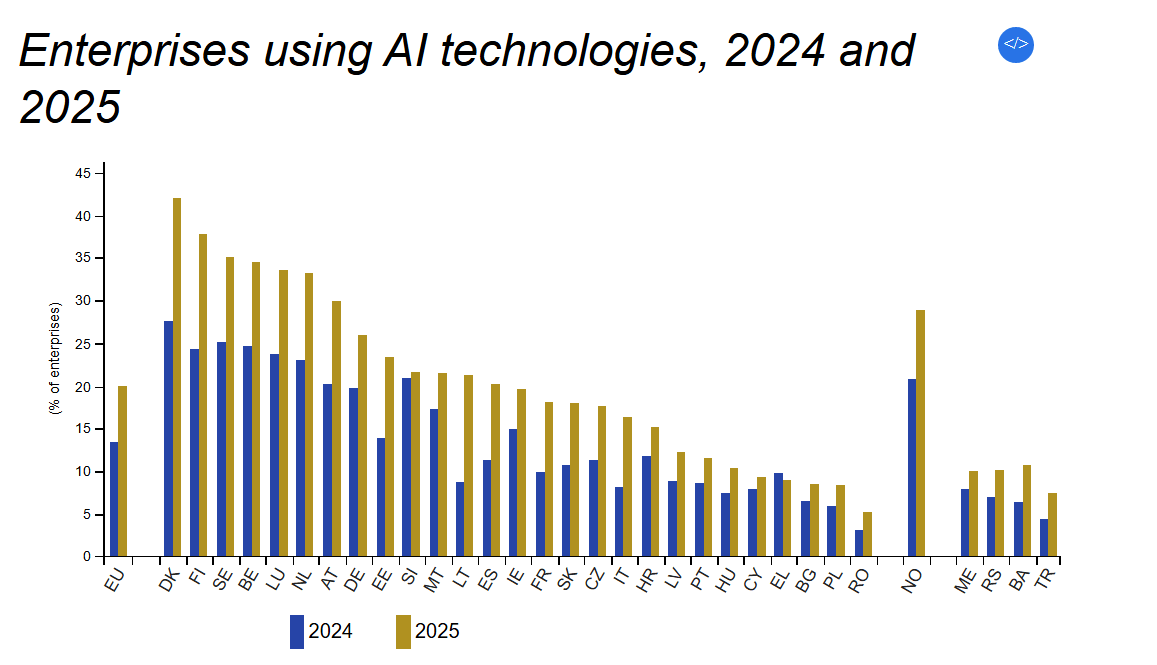

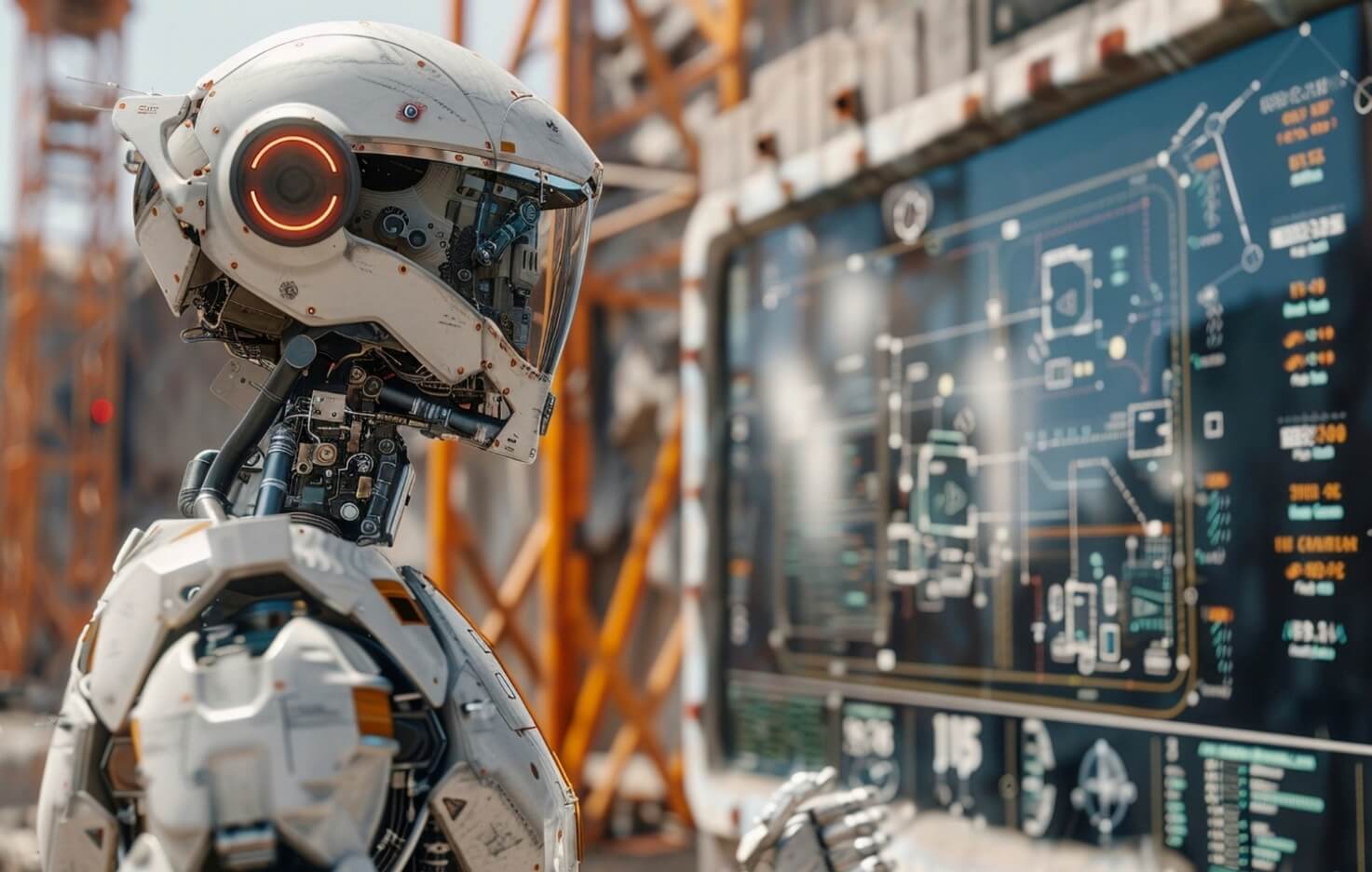


















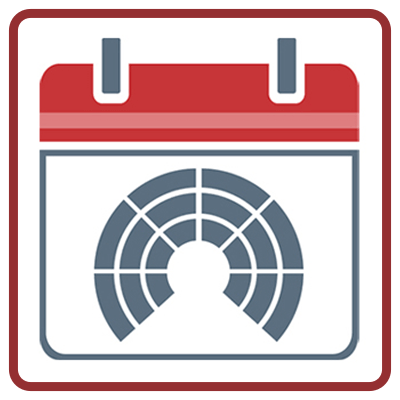


























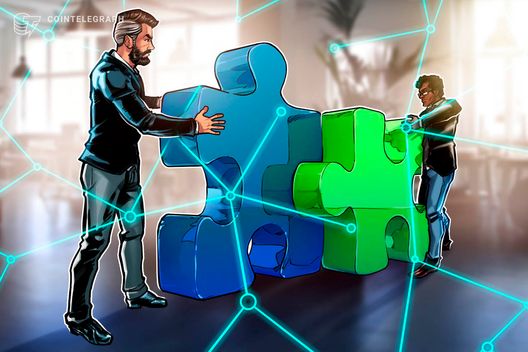
















































































-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)