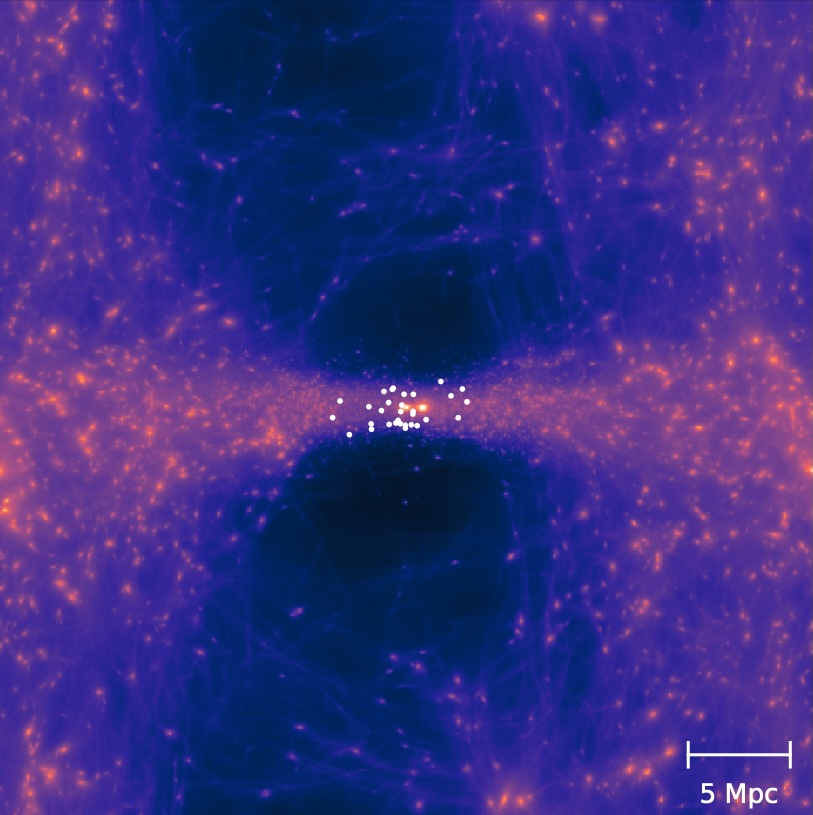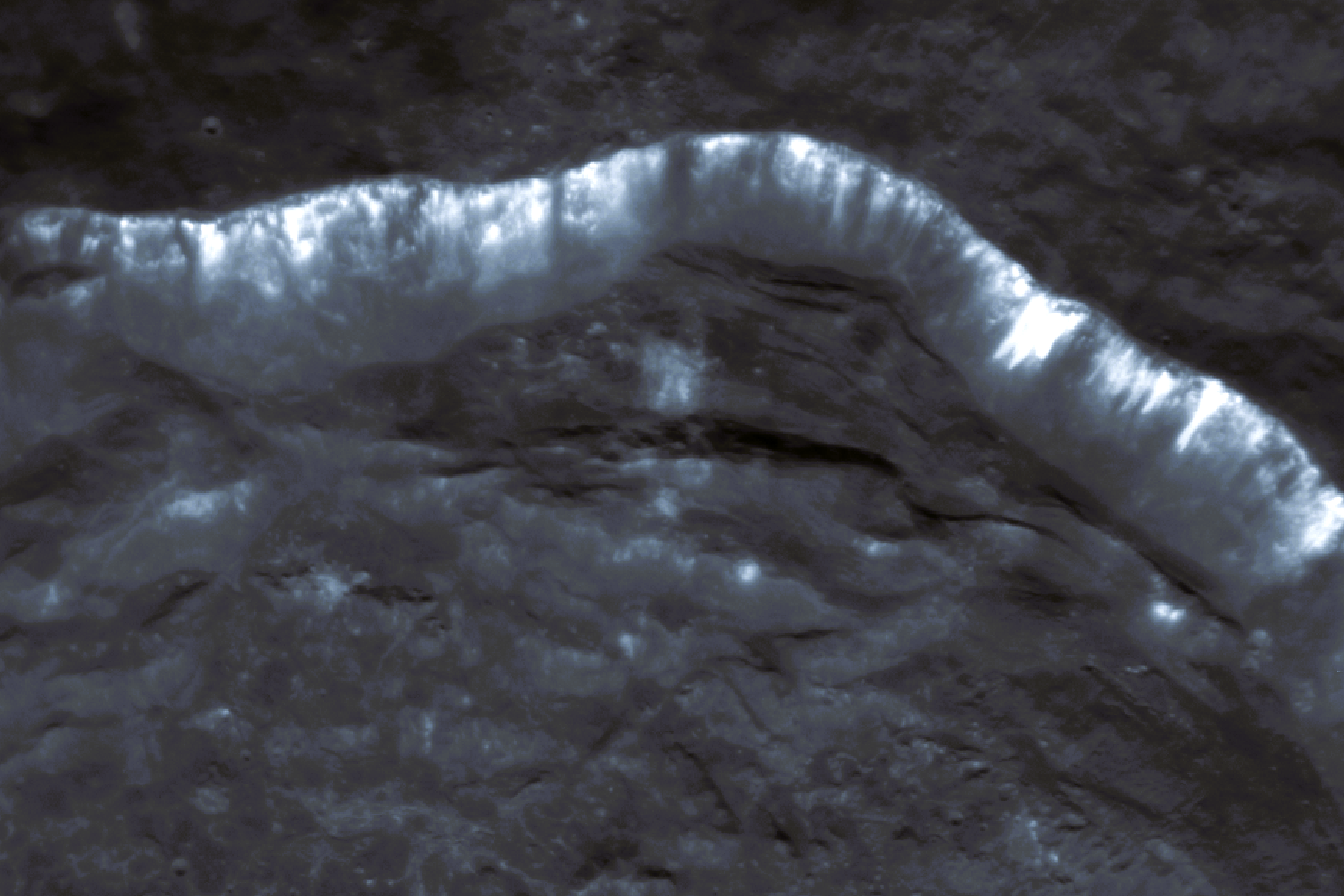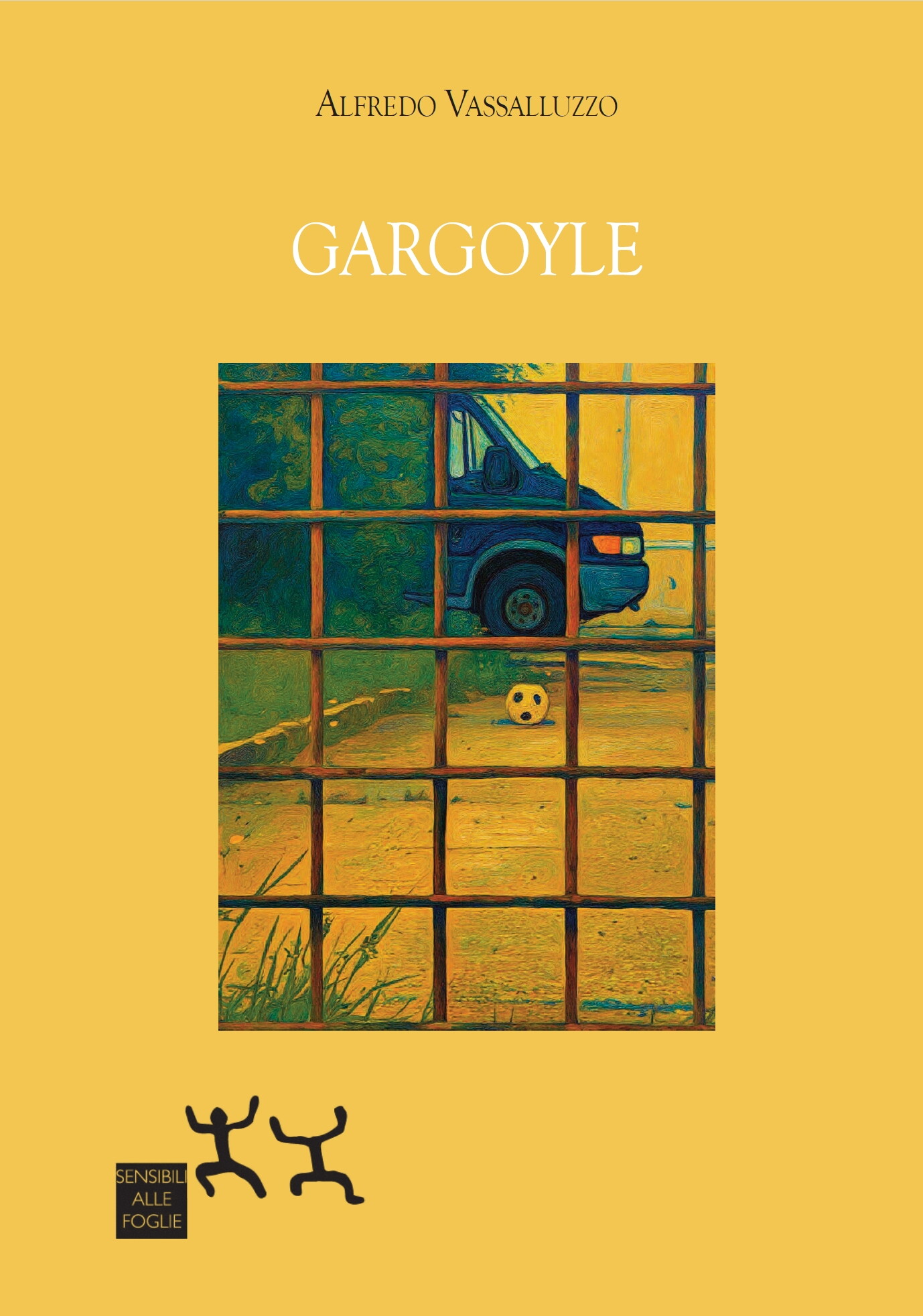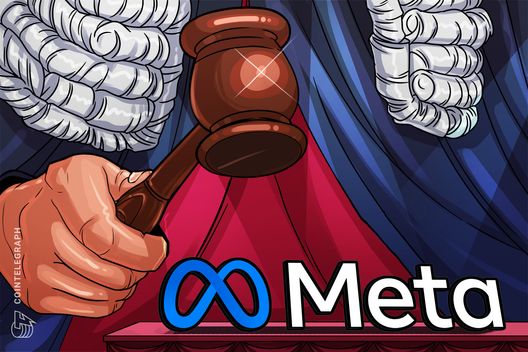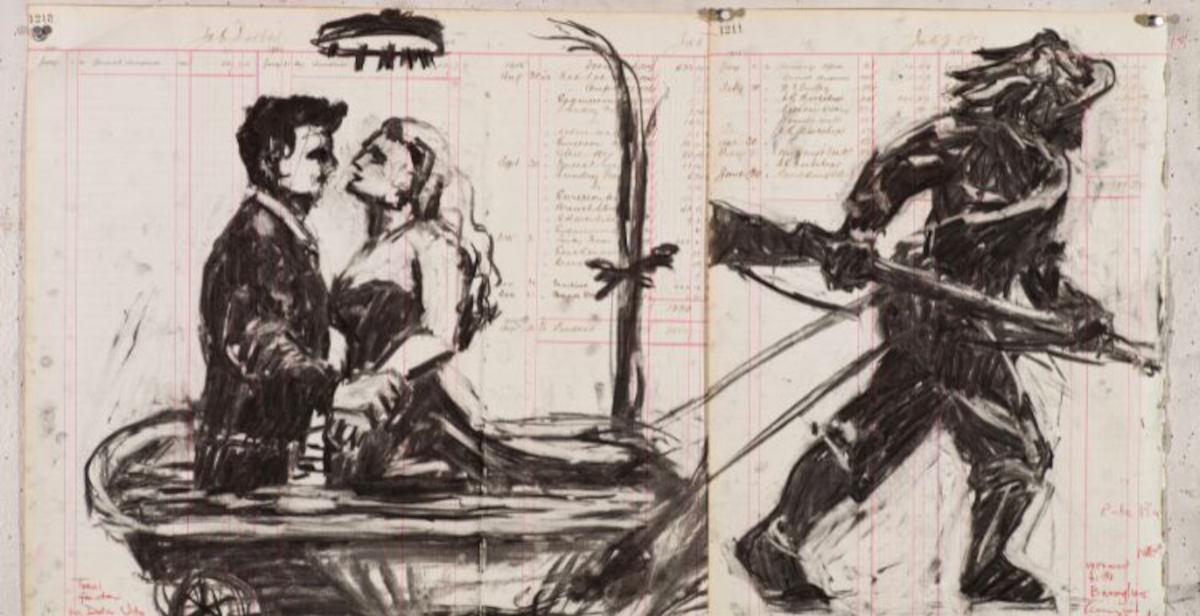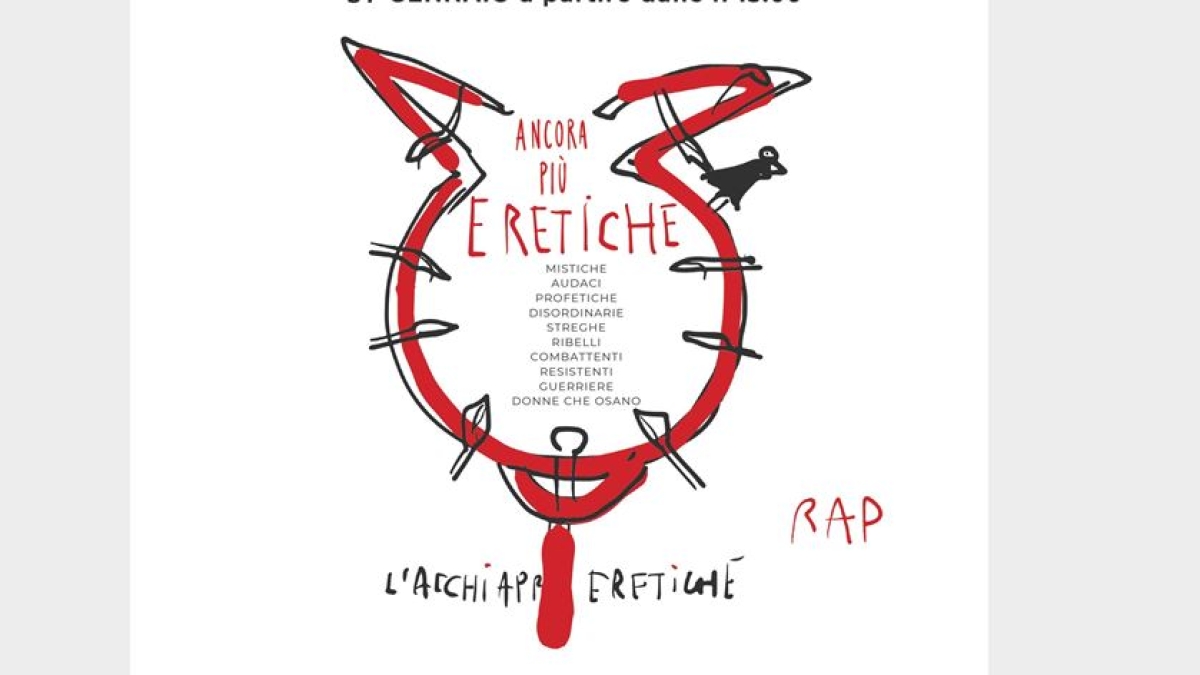Il vero scandalo del documentario di Melania Trump è la prostrazione dei miliardari americani


Il documentario su Melania Trump non passerà alla storia per la peggiore sceneggiatura dai tempi di The Lady di Lory Del Santo, né per il probabile flop al botteghino. Sarà forse studiato dagli storici come un esempio plastico di come i tecnoligarchi americani si sono ridotti pur di non subire ritorsioni da suo marito, Donald Trump, tornato alla Casa Bianca con un potere di intimidazione economica e regolatoria senza precedenti nella storia recente degli Stati Uniti.
Il film, intitolato “Melania” perché alcuni personaggi non hanno bisogno del cognome, come i politici cinquestelle al loro apice, o i cantanti di Amici, uscirà oggi negli Stati Uniti (e anche in Italia), distribuito da Amazon MGM Studios. L’azienda di Jeff Bezos ha sborsato 40 milioni di euro per avere i diritti in esclusiva dello streaming su Prime Video e 35 milioni destinati al marketing e alla distribuzione, con una campagna promozionale paragonabile a quella di un film importante. Circa 28 milioni dell’anticipo sarebbero confluiti direttamente alla first lady; tutti sulla fiducia.
Le prevendite sono andate così male che addirittura a Boston, nel cinema più grande della città, alla prima serata non risulta sia stato venduto nemmeno un biglietto. In queste ore è apparso su Craiglist un annuncio goliardico che offre un biglietto gratuito e cinquanta dollari a chiunque sia disposto ad andare in sala a vedere il film, ma a patto di rimanere fino alla fine. Sul social Truth, Donald Trump ha detto che i biglietti si stanno vendendo «velocemente», ma sappiamo qual è il suo rapporto con la verità alternativa.
Le stime più ottimistiche di incasso per il primo fine settimana oscillano tra 1 e 2 milioni di dollari, rendendo improbabile qualsiasi recupero dell’investimento a meno di una gigantesca campagna di passaparola negativo, per vedere un film troppo brutto per essere vero. Chi ha visto il documentario in anteprima, nella più docile delle recensioni lo ha giudicato «un’operazione di controllo dell’immagine più che un’indagine giornalistica» (New Yorker), «un ritratto elegante ma sorprendentemente vuoto» (New York Times) o «un ritratto controllato fino all’eccesso» (USA Today).
Mentre Bezos spende senza problemi 75 milioni in un probabile fallimento, nella sua Amazon applica una disciplina durissima. A gennaio il gruppo ha confermato il taglio di circa 16.000 posti di lavoro corporate, portando a quasi 30.000 le posizioni eliminate rispetto alla metà del 2025. La ristrutturazione è stata presentata come una semplificazione organizzativa per concentrare le risorse su cloud e intelligenza artificiale. Ancora peggio potrebbe andare al Washington Post, giornale acquistato da Bezos nel 2013 per 250 milioni di dollari promettendo investimenti e indipendenza editoriale. Un impegno riassunto nel motto, ora cancellato, Democracy dies in darkness (la democrazia muore nell’oscurità).
Si è fatto buio presto, visto che secondo uno scoop del New York Magazine, la redazione del Washington Post si prepara a «un’ondata devastante di licenziamenti», con circa 100 posti a rischio su 800 e la possibile chiusura di intere sezioni. Il Post ha perso centinaia di migliaia di abbonati digitali, è sceso ben al di sotto dei livelli del periodo 2016–2020 e nel 2023 ha registrato perdite per circa 77 milioni di dollari. Due anni fa circa 250mila lettori cancellarono il loro abbonamento dopo la decisione di Bezos di impedire alla direzione editoriale di pubblicare l’endorsement ufficiale a favore di Kamala Harris, la candidata del Partito democratico. Pensando al nuovo editore, il critico cinematografico del Washington Post si è portato avanti, definendo Melania un «film promozionale mascherato da documentario» in cui «l’assenza di domande difficili e di voci esterne trasformi il progetto in un esercizio di narrazione unilaterale».
Per il secondo uomo più ricco del mondo, con un patrimonio stimato intorno ai 240 miliardi di dollari, il flop di Melania è irrilevante dal punto di vista finanziario. Sul piano politico, invece, l’investimento è geniale. Il film è stato lanciato con una proiezione privata alla Casa Bianca, un segnale di deferenza preventiva verso un’amministrazione che in ogni momento può incidere direttamente su antitrust, appalti federali, regolazione tecnologica e reputazione delle grandi piattaforme. La mano di Trump po’ esse fero e po’ esse piuma. Secondo una stima dello staff del Senate Health, Education, Labor and Pensions Committee, le recenti modifiche fiscali dell’amministrazione Trump, come il Big Beautiful Bill potrebbero tradursi per Amazon in un vantaggio fiscale complessivo nell’ordine di 15,7 miliardi di dollari su base annua.
Nel documentario di Melania probabilmente ci sarà l’immagine che ricordiamo tutti: i magnati della Silicon Valley in fila dietro Donald Trump, durante la sua seconda cerimonia di inaugurazione: da Mark Zuckerberg di Meta a Sundar Pichai, ceo di Alphabet, che a settembre ha evitato lo smembramento di Google in uno storico procedimento antitrust, ringraziando poco dopo Trump alla Casa Bianca per il «dialogo costruttivo» e per la «risoluzione» del caso, dichiarandosi «contento che fosse finita».
In quella storica foto c’era anche il ceo di Apple Tim Cook che per non sbagliare donò a titolo personale un milione di dollari al comitato che organizzò l’insediamento. Ad agosto, per celebrare un investimento di 600 miliardi di dollari da parte di Apple negli Stati Uniti nei successivi quattro anni, Cook ha regalato a Trump una targa in vetro Corning con una base in oro a 24 carati. Anche qui, investimenti a buon rendere visto che Apple ha beneficiato di esenzioni sui dazi dopo mesi di minacce di Trump su iPhone e altri prodotti assemblati all’estero. I dipendenti di Apple non hanno particolarmente apprezzato la partecipazione di Cook alla proiezione di “Melania” alla Casa Bianca, avvenuta poche ore dopo l’omicidio di Alex Pretti a Minneapolis da parte del Border Patrol. Cook ha invitato un memo ai suoi dipendenti augurandosi una «de-escalation», qualsiasi cosa voglia dire, assicurando in modo alquanto lapalissiano di aver apprezzato in Trump «la sua disponibilità a confrontarsi su questioni che interessano tutti noi». Un po’ come applaudire il pilota per aver fatto atterrare l’aereo.
A colpire non sono questi piccoli atti incoerenti di uomini molto ricchi con interessi più grandi di loro, ma il modo in cui è cambiato rapidamente il rapporto tra potere economico e potere politico negli Stati Uniti. Mai avevamo visto i magnati prostarsi così tanto alla Casa Bianca, né un presidente usare in modo così trasparente e personale il vantaggio del suo potere per intascare denaro o favori personali.
Da sempre i padroni del vapore di qualsiasi epoca hanno finanziato le campagne elettorali sperando che il loro candidato fosse benevolo una volta arrivato alla Casa Bianca. Trattavano i partiti come dei taxi, per citare la celebre frase di Enrico Mattei, da usare finché servono, senza però essere mai umiliati. Alcune volte funzionava benissimo, come nella fine dell’Ottocento, durante la Gilded Age, quando i grandi industriali ottenevano tariffe favorevoli e una regolazione indulgente. Altre volte invece male, come quando il giovanissimo Theodore Roosevelt si ritrovò da vice a presidente dopo la morte di William McKinley e inaugurò una stagione di antitrust aggressivo che smantellò monopoli intoccabili come Standard Oil, dimostrando che il potere politico poteva emanciparsi dai suoi sponsor.
Nel Novecento la dinamica si è ripetuta in forme diverse. Per combattere la Grande Depressione Franklin Delano Roosevelt attuò il New Deal con l’appoggio di settori dell’establishment industriale e finanziario, consapevoli del rischio di collasso del sistema, ma si scontrò apertamente con una parte significativa delle élite economiche che vedevano nel rafforzamento dello Stato una minaccia all’autonomia del mercato. Negli anni successivi, dagli avvertimenti di Dwight Eisenhower contro l’eccessivo potere del complesso militare-industriale fino alla deregolamentazione promossa da Ronald Reagan e sostenuta dai grandi interessi finanziari, il confronto rimase acceso. Ma anche nei momenti di maggiore influenza economica non si arrivò mai a mettere in discussione la legittimità delle istituzioni di controllo e dei contrappesi democratici.
Anche in tempi più recenti, con i fratelli Koch per il Partito repubblicano, il modello restava quello dell’influenza a monte: plasmare l’offerta politica attraverso donazioni, influenzare con report dei think tank e reti ideologiche, senza mai piegare né piegarsi troppo a un singolo leader. Con Donald Trump, però, questo schema si è rovesciato. La sua volubilità degna di Riccardo III, il presidente ha reso docili gli oligarchi pragmatici delle big tech che cercano di coccolarlo con favori sempre più esagerati e pacchiani per evitare ritorsioni. Anche in questo l’America di Trump è sempre più simile alla Russia di Putin. E chi si avvicina troppo al sole, cola a picco come Icaro. Per sua fortuna, Elon Musk è caduto in piedi su un materasso, tornando a occuparsi di Tesla e SpaceX dopo i crolli in borsa a causa del suo fallimentare periodo alla Casa Bianca, quando guidava il Doge e bisticciava con Trump un giorno sì e l’altro pure.
L'articolo Il vero scandalo del documentario di Melania Trump è la prostrazione dei miliardari americani proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0