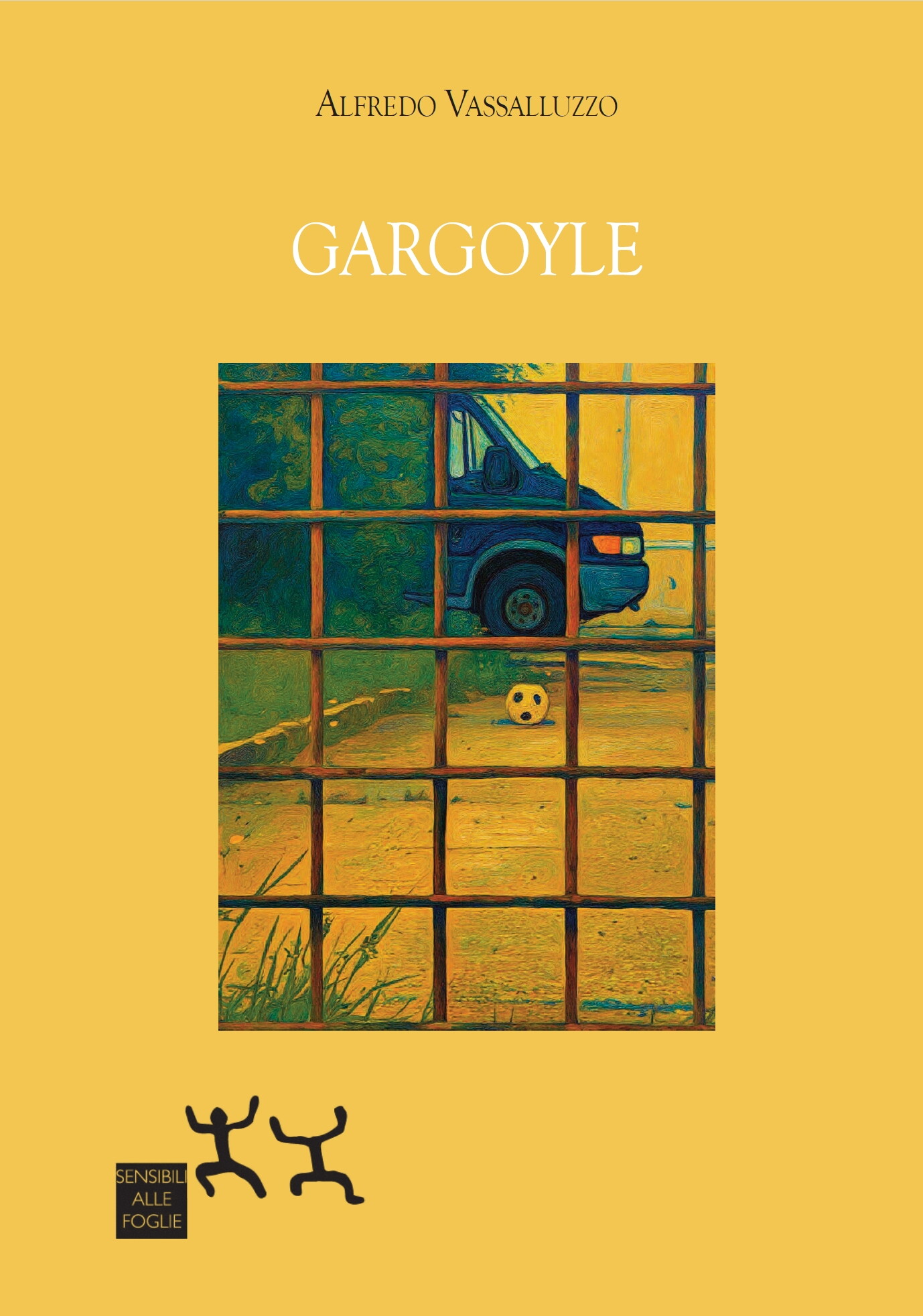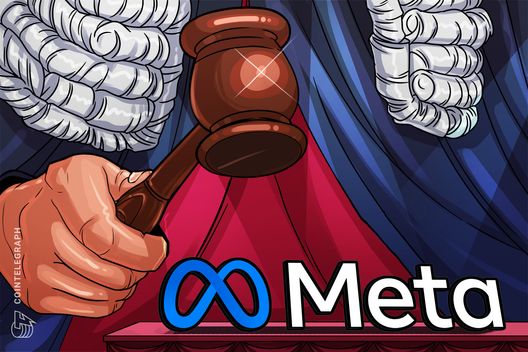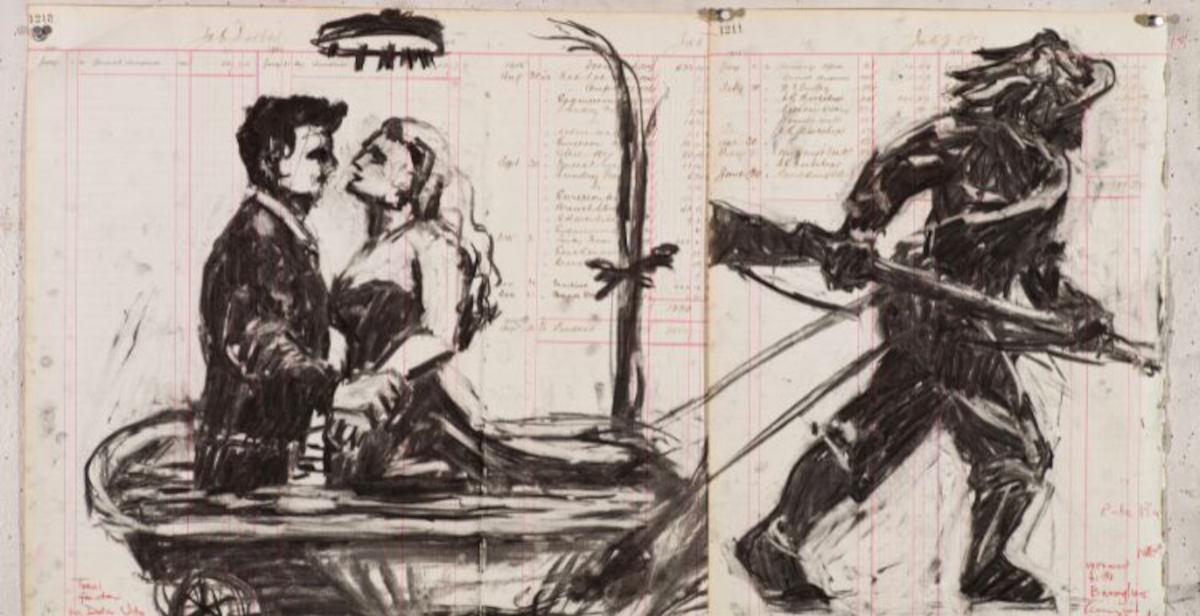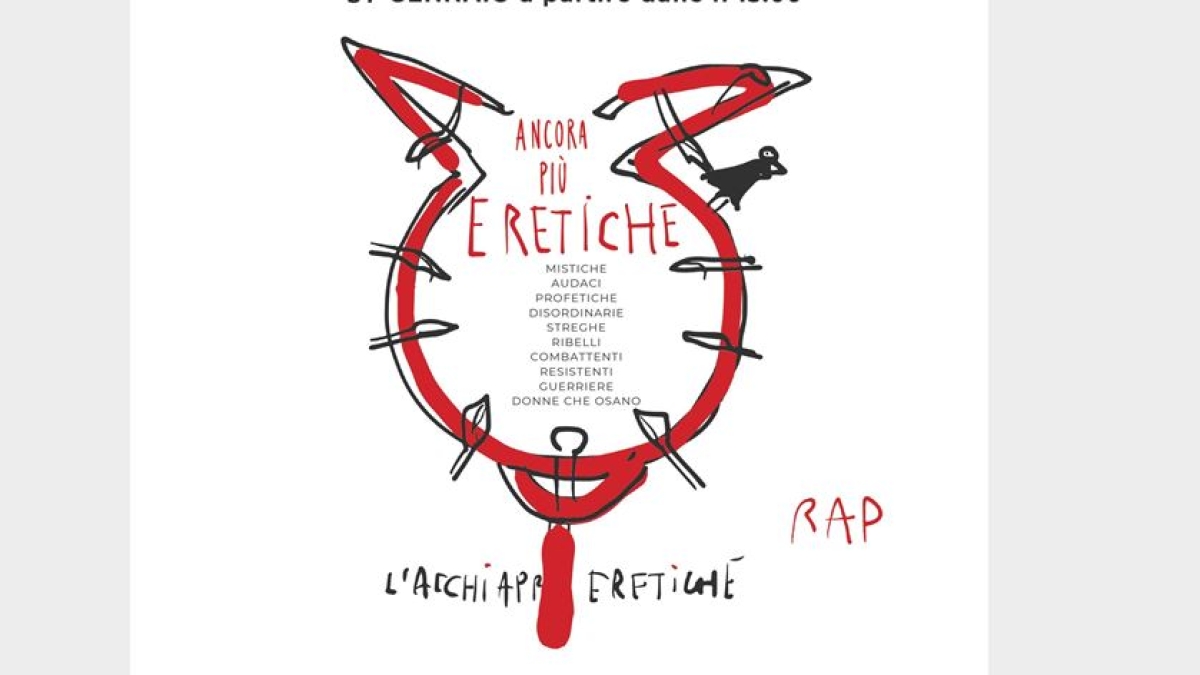Il mio film su Cecilia Sala, e l’ardua evasione dal carcere del personal branding


È mezzanotte e cinque quando il ristoratore ci dice che, da bambino, ha doppiato un personaggio in “La gabbianella e il gatto”. Cecilia Sala sgrana gli occhi e dice che da piccola ha guardato per mesi quel cartone animato tutti i giorni, gli chiede che personaggio, lui dice «il gatto rosso», e questo è il punto in cui, se fossimo nell’ufficio d’un produttore cinematografico, quello ci caccerebbe a calci per eccesso di coincidenze nella sceneggiatura proposta.
Due ore prima, Cecilia Sala ha chiuso il suo spettacolo teatrale con la foto di Arturo, arma di fine di mondo per la conquista dell’internet e più in generale del pubblico medio, che sì, vuole sapere dei paesi lontani per sentirsi informato, vuole vedere da vicino una famosa per sentirsi di esistere, ma soprattutto vuole i gattini. Arturo, il gatto rosso di casa Sala, resta sullo schermo anche dopo gli inchini e le uscite di scena di Cecilia e di quelli che stanno in scena con lei: è una prolunga per applausi, Arturo.
Se siete mai stati a uno di quegli spettacoli di Broadway o del West End, quelli nel cui cast ci sono nomi di Hollywood per attirare un pubblico che si ostina a non considerare svalutata la fama, sapete cosa succede. Non importa se sia in mezzo a un dialogo o in altro punto inadatto: quando entra il famoso – che sia George Clooney o Sarah Jessica Parker o Susan Sarandon – la platea applaude. Non ha ancora fatto niente: lo applaude per ringraziarlo d’essere famoso e d’essere qui, a pochi metri da me, che quindi esisterò della tua fama riflessa.
A fine spettacolo Cecilia firma un numero di libri per il quale qualunque editore si strizzerebbe le mutande, e in quel centinaio di persone che vogliono l’autografo c’è quella che chiede la dedica a tre nomi diversi (perché il telefono da mille euro i figli devono avercelo personale ma non si buttano i soldi in tre copie d’un libro), ci sono quelli che si complimentano (di esistere? Di essere a piede libero? Del libro che non hanno ancora neppure sfogliato?), ma soprattutto ci sono quelli che stanno fuori dalla fila e filmano. Filmano una che hanno visto in tv che firma libri ad altra gente. Per poi dire agli amici non so bene cosa, credo «guarda, ero a tre metri da una famosa».
Cecilia Sala non si è ancora assestata nel suo nuovo ruolo, che è quello di persona famosa, ma soprattutto di persona famosa per un fatto specifico. CeciliaSalaquellaincarceratadagliiraniani. Non si capacita di come cambi l’energia in sala al decimo, al venticinquesimo, al cinquantesimo, al cinquantacinquesimo minuto, che sono quegli intermezzi per cui il pubblico ha pagato un biglietto fingendo di venire a farsi raccontare l’Iran: quelli in cui la convenzione narrativa non è più «Cecilia Sala, giornalista, vi spiega l’Iran», ma «Cecilia Sala, vittima, vi spiega la prigionia».
A un certo punto penso che è come guardare Ethan Hunt. Ethan Hunt appeso a una parete di roccia con una mano sola fa paura, ma è una paura rassicurante, perché sai che Tom Cruise è ancora vivo e non si è sfracellato girando quella scena, e sai che Ethan Hunt arriva vivo alla fine di ogni “Mission: Impossible”. Cecilia Sala che racconta il carcere di Evin dove fingono di impiccarti per terrorizzarti meglio fa paura, ma è una paura rassicurante: è viva, è qui, è tutto passato.
A un certo punto in scena, su uno degli schermi, c’è una foto che poi a casa vado a cercare perché sospetto d’essermela sognata, e invece no, eccola lì. C’è Khomeini che ride, e proteso verso di lui, con la faccia affondata nel suo collo, lo riconosci solo dalla kefiah, c’è Arafat. Sembra una foto del “Tempo delle mele”, Pierre Cosso che dà un bacio sul collo a Sophie Marceau, però al loro posto ci sono due che ai tempi del “Tempo delle mele” vedevamo al tg.
Più tardi, nell’interminabile fila per farsi firmare il libro da quella famosa, un tizio ha due copie. Chiede a Cecilia Sala una dedica a Tizia e una a Caia. Sente il bisogno di precisare che Tizia è sua moglie e Caia la sua amante. È vero? O sta cercando solo di rendersi memorabile agli occhi di quella famosa? È il suo «vedi, amico mio, come diventa importante che in questo istante ci sia anch’io»? Cecilia, che nel ruolo di quella su cui il compratore di libri nel foyer del teatro vuol far colpo ancora non si è assestata, si chiederà poi se un’amante sia felice di ricevere in dono un libro sull’Iran, invece d’un gioiello o d’un mazzo di rose.
Nel film che mi figuro mentre sono seduta a teatro, la prima scena, credo che qualunque sceneggiatore sarebbe d’accordo, non potrebbe che essere quella in cui Cecilia Sala riceve un messaggio di Kazemi Qomi. Le chiedo di ripetermi il nome mentre siamo a cena, solo perché voglio scrivere questo articolo e mi fido più della cronologia del telefono che della mia memoria. Google dice «ex ambasciatore iracheno in Afghanistan», Cecilia sorride, dice qualcosa come «questi ruoli di copertura», sul palco non ricordo come l’avesse qualificato: un soldato, un agente segreto, comunque uno rotto a tutto.
Le scrive che l’appuntamento che avevano quel giorno è disdetto perché non c’è vento e a Teheran c’è troppo smog. Lei sorride con rasserenato senno di poi e dice figurarsi se uno così ha paura dello smog. Quando riceve il messaggio è accucciata sotto il piumone: sta registrando il podcast, e ha il piumone in testa per attutire i rumori di fondo. Passano cinque minuti dall’appuntamento mancato, bussano, e capisce che il tizio non le ha dato buca per lo smog: le ha dato buca perché stanno per arrestarla.
La prima scena del film è Qomi e l’ultima è Arturo, ma il problema è che questo film non s’ha da fare. A Milano lo chiamano personal branding: è quel tic per cui, se diventi famoso per una cosa, ti consigliano di fare sempre e solo quella cosa, così sarai molto riconoscibile e sarai quello del quale il pubblico si fiderà per quella merce lì. Starai all’essere stata incarcerata in una teocrazia come Panino giusto starà ai panini.
Mollare il personal branding con cui hai fatto fortuna per imporre un prodotto radicalmente diverso è un gesto folle, qualunque addetto al marketing te lo sconsiglia, però è mollando i ruoli romantici che Leonardo DiCaprio è diventato Leonardo DiCaprio.
Mentre siamo a tavola il proprietario le presenta un pizzaiolo, è iraniano, si mette a parlare con l’iraniano che è in scena con Cecilia ma ogni tanto si equivocano, accenti diversi, Cecilia chiede cosa significa una parola o un’altra, non so più nell’incomunicabilità superata a botte di sorrisi chi sia il bagnino romagnolo e chi la turista tedesca, ma di certo ormai Cecilia è il punto di riferimento per quel pezzettino di mondo: non ci sarà mai un ristoratore con un dipendente iraniano che non corra a presentarglielo.
Può la galera in Iran essere il “Titanic” di Cecilia Sala? E in questo caso chi sono il suo Spielberg e il suo Scorsese? E, soprattutto, nel secolo della gratificazione immediata, può un DiCaprio aspettare pazientemente cinque anni il suo Scorsese senza dirsi ma sai che c’è, forse mi conviene continuare a fare l’eroe romantico, venire applaudito per il solo fatto di esistere, e fare del mio gatto una star del palcoscenico?
L'articolo Il mio film su Cecilia Sala, e l’ardua evasione dal carcere del personal branding proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0