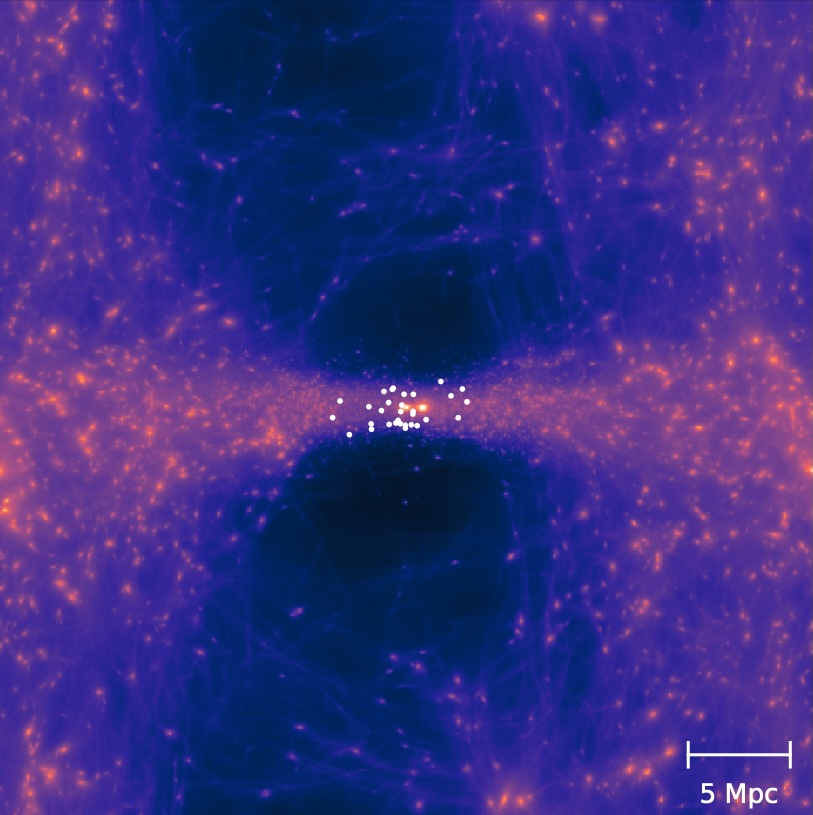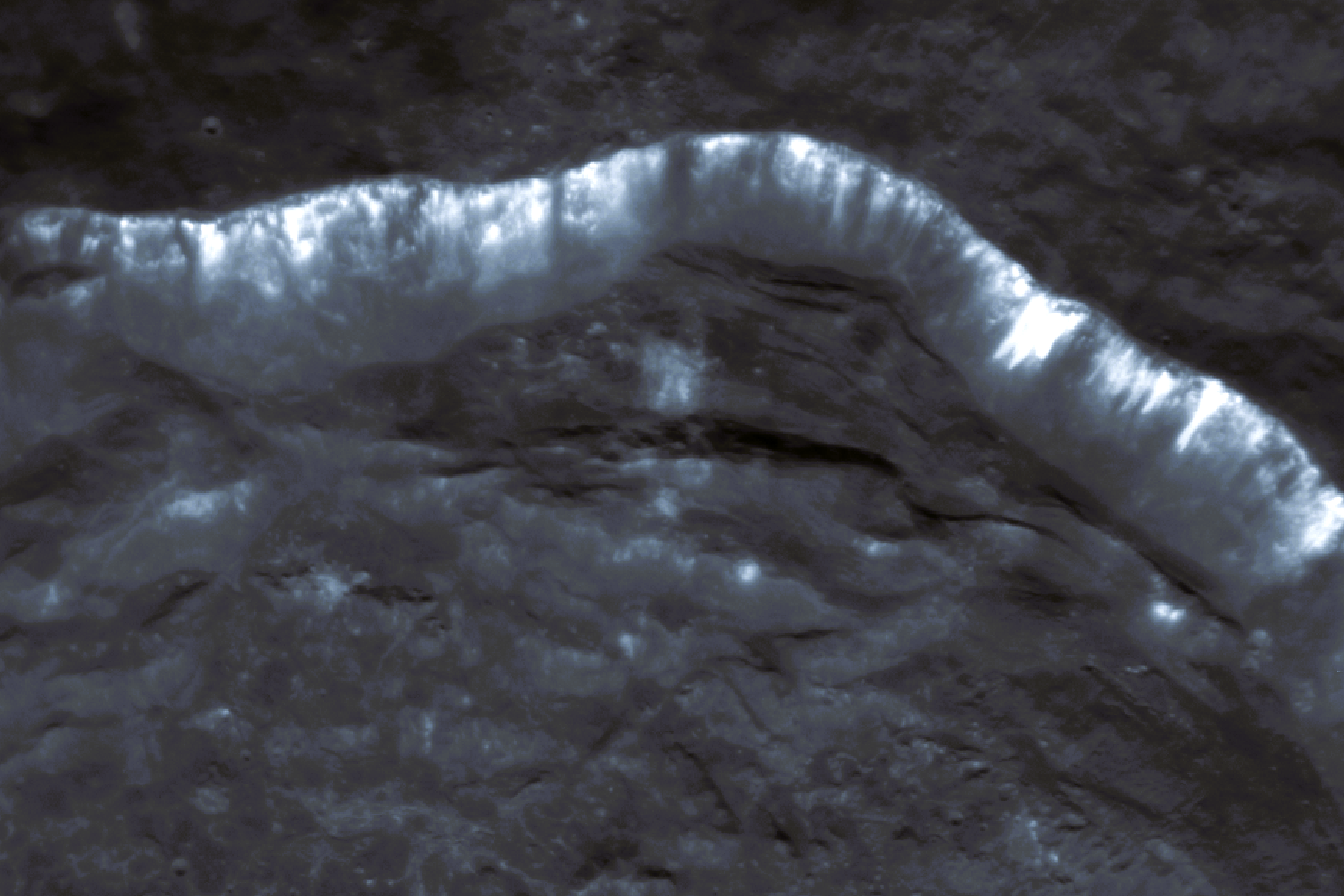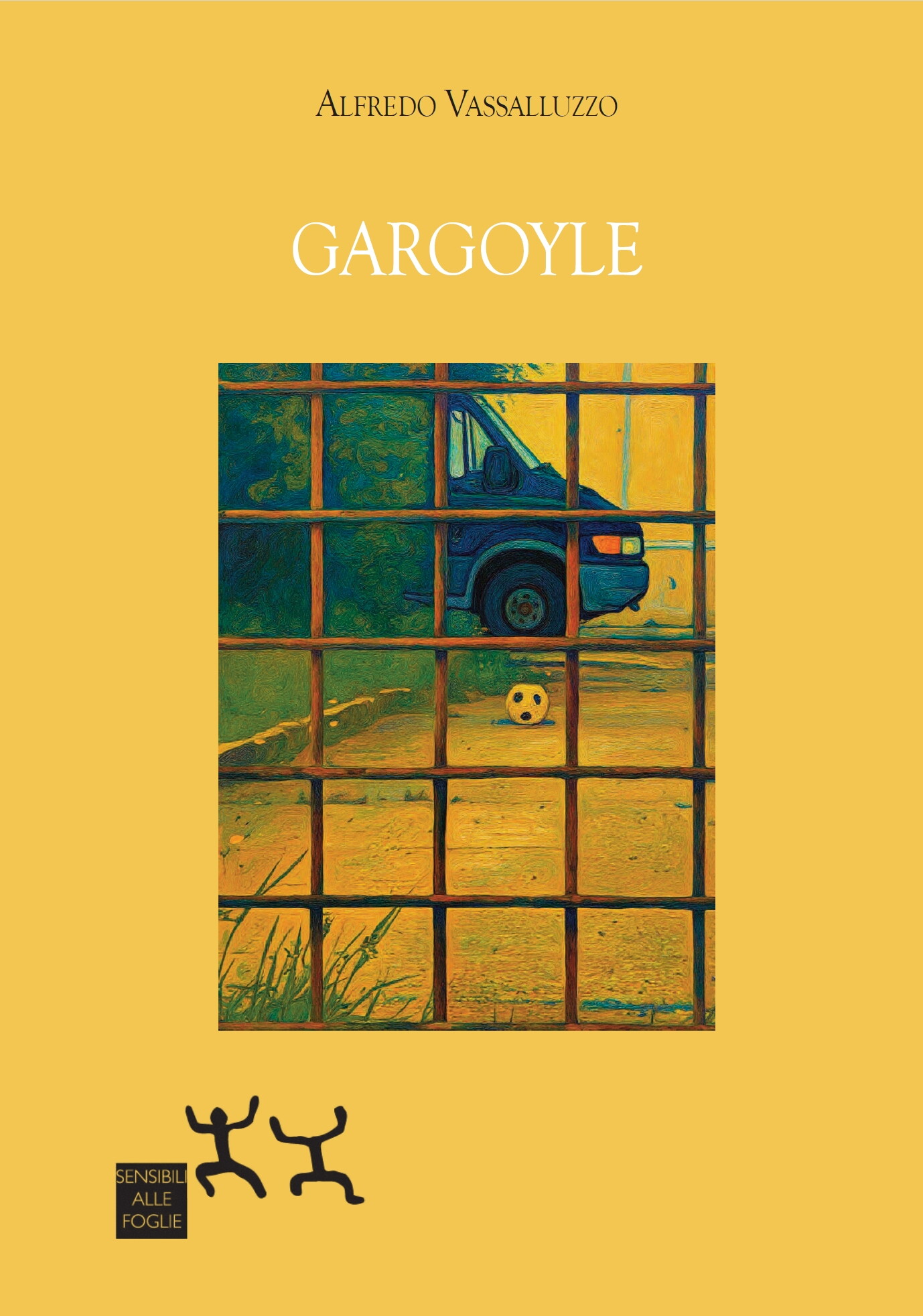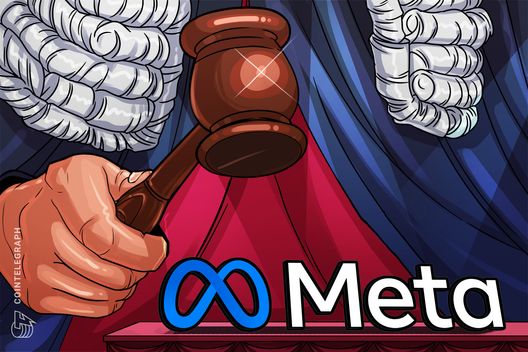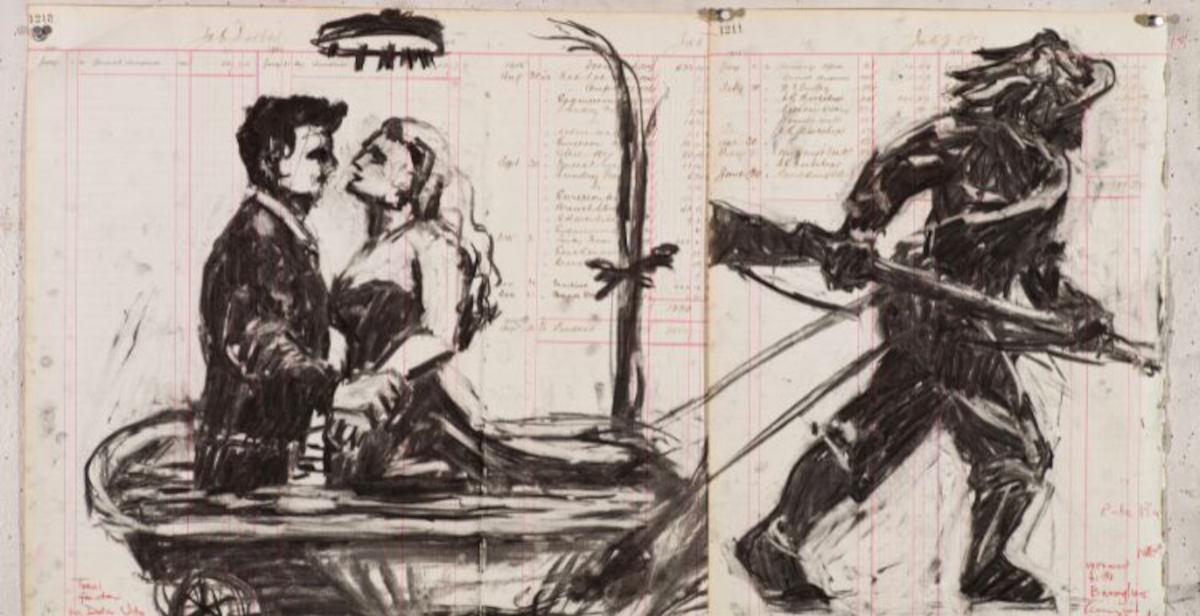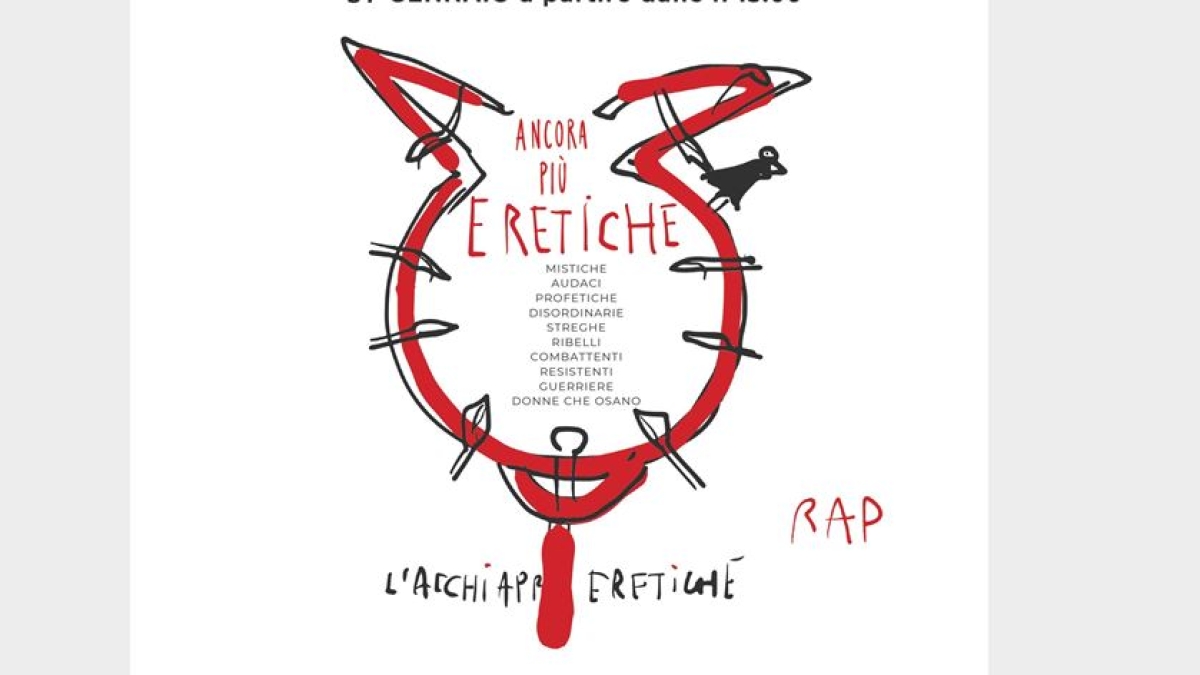L’epopea di una famiglia ebreo-tedesca, e le verità nascoste in un tubetto di dentifricio


Mia nonna è cresciuta lavandosi i denti con un dentifricio radioattivo. L’ingrediente principale era carbonato di calcio esposto a radiazioni, e suo padre era il chimico incaricato di produrlo. Prima ancora che fosse in commercio ne aveva portati alcuni tubetti alla famiglia. Con il marchio «Doramad», prometteva gengive «cariche di una nuova energia vitale» e un sorriso «di un bianco accecante». Abitavano cosí vicino alla fabbrica che mia nonna si addormentava ascoltando il rimestio dell’autoclave. Nel 1935, quando furono costretti a lasciare la Germania, si portarono dietro qualche tubetto, che dall’interno delle valigie continuò a emettere deboli particelle alfa per gli oltre duemila chilometri del loro viaggio verso oriente.
Durante la guerra, mia nonna scoprí che il dentifricio che suo padre, un ebreo, aveva contributo a realizzare era diventato il preferito dell’esercito tedesco. Una filiale della fabbrica nella Cecoslovacchia occupata si assicurava che i soldati che avanzavano verso est, compiendo ogni sorta di violenze e assassinii e incendiando interi villaggi, potessero farlo con un sorriso radioso.
Non che me l’avesse detto lei, intendiamoci. Tutto quello che sapevo sulla vita di mia nonna erano informazioni di seconda mano, aneddoti consumati dal passaparola. Quando mi sposai, mia madre mi regalò un anello che, disse, era «scampato ai nazisti» nel 1935. Guardai l’eliotropio, un ovale nero screziato di rosso, e immaginai la loro fuga con la tranquilla certezza di chi non si è mai preoccupato di indagare piú a fondo. Fu mio zio a regalarmi il poster della fanciulla bionda della Doramad, che sorrideva brillando di luce interiore. Lo appesi sopra la scrivania e cominciai a scrivere la storia di mia nonna e della sua infanzia. Andava tutto a gonfie vele – finché non si intromise la protagonista.
Andai a intervistare mia nonna a casa sua, a Edimburgo. Parliamo di piú di dieci anni fa. Dalla poltroncina bassa su cui era seduta, con addosso un maglione peloso che la faceva sembrare sfocata, mi informò che non ero pronto. Dopo aver decretato che le mie domande erano tutte insulse, sbadigliando in maniera sempre piú plateale mi disse: – Senti, perché non cominci a leggerti un libro sull’argomento? – Qualche mese dopo tornai alla carica, forte del libro che avevo letto, un pluripremiato e sfaccettato memoir intergenerazionale sulla persecuzione di una ricca famiglia ebrea emigrata da Odessa a Vienna e poi a Parigi, un capolavoro che avrei potuto usare come modello per raccontare la sua, di storia.
Peccato che mia nonna lo avesse già letto e detestato. Senza neanche aprirlo, me lo restituí dicendo: – No, era tutto diverso –. Com’era, allora? Non ebbi piú il coraggio di chiederglielo. Dentro di me pensavo che un giorno, verso la fine, mi avrebbe preso la mano e avrebbe cominciato a parlare, a sfogarsi, lasciando riaffiorare decenni di vita – e che quello sarebbe stato il segnale di tirare fuori il taccuino. Invece, a poco a poco, è sopraggiunta la demenza senile e, con essa, la depressione. Mia nonna era sempre stata una persona schietta e spiritosa, e anche quando tale schiettezza sfociava in cattiveria aveva un modo di ridere rovesciando indietro la testa che le permetteva quasi sempre di farla franca. Ora però aveva smesso di ridere e cominciato a far fuori le badanti al ritmo di una alla settimana, talvolta riducendole in lacrime al primo incontro. L’accento scozzese-tedesco conferiva alle sue battute velenose una particolare efficacia. Ma sapeva essere altrettanto dura con se stessa. – Certe persone sono tremendamente gentili, – mi disse una volta, mentre la spingevo in carrozzella nel parco. – E altre sono come me, tremende e basta.
È morta nel 2017, a novantadue anni. Io e mia sorella abbiamo tenuto un elogio funebre congiunto in cui abbiamo cercato di ripetere alcune sue espressioni tipiche, in un misto di scozzese e bavarese, con una spruzzatina di turco. Avevamo chiesto aiuto ad amici e parenti, e sebbene fossero tutti concordi nell’affermare che aveva detto cose memorabili, nessuno ricordava piú quali – a parte una manciata di improperi giudicati troppo triviali per la cerimonia. Sembrava che fossimo riusciti a scoprire solo di non sapere quasi niente di lei. Il che era di per sé evocativo. In quell’assenza avvertivamo la sua presenza.
Solo due anni dopo la sua morte, in occasione di una riunione di famiglia, mi avventurai nella sua camera da letto. Vorrei poter dire che mi misi a ficcanasare in giro per sentirla di nuovo vicina, ma probabilmente era piú vero il contrario. Solo ora che non c’era piú, e non correvo il rischio che mi rispondesse, potevo fare altre domande sulla sua vita. Sapevo che lì da qualche parte c’era una raccolta di documenti noti come «archivio di famiglia». Immaginavo un fascio di lettere sgualcite nascoste sotto un’asse del pavimento, invece trovai un cassetto contrassegnato da un cartellino da valigia: archivio di famiglia. Foderato di carta scolorita arancione, conteneva medaglie di guerra, diplomi, monete antiche, le memorie inedite di suo padre, faldoni di lettere in una grafia inclinata, quasi orizzontale, le registrazioni di varie sue interviste, un’imbarazzante cartellina di mie poesie di cui le avevo fatto solennemente dono da adolescente e una “ricetta” manoscritta per un dentifricio radioattivo risalente al novembre 1925, quando mia nonna aveva un anno e le stavano spuntando i primi denti.
© 2025 Joe Dunthorne
© 2026 Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino

L'articolo L’epopea di una famiglia ebreo-tedesca, e le verità nascoste in un tubetto di dentifricio proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0