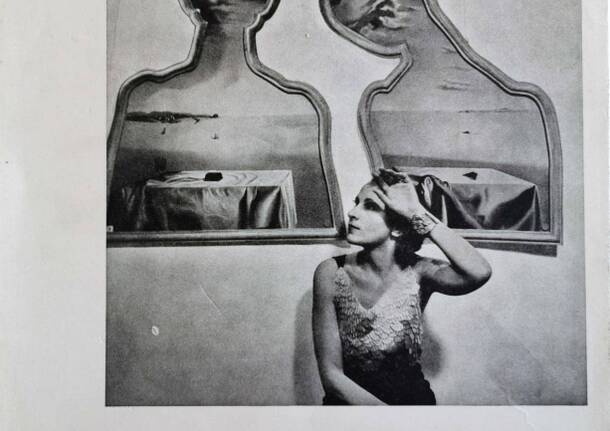Il modello olandese con la settimana lavorativa corta funziona davvero?

lentepubblica.it
Scopriamo in questo breve approfondimento quali sono le specifiche del modello olandese, che si basa sulla settimana lavorativa corta, e quali sono i suoi eventuali pro e contro.
Nei Paesi Bassi il tempo dedicato al lavoro è, in media, il più contenuto d’Europa: poco più di 32 ore settimanali. Non è il frutto di un’imposizione dall’alto, ma l’esito di un contesto in cui il part-time è diffusissimo e normalizzato. Il risultato è un quadro apparentemente paradossale: produttività elevata, occupazione molto alta — circa l’82% delle persone in età attiva — e indicatori di benessere soggettivo tra i migliori al mondo. A questo si aggiunge un altro dato non banale: l’età effettiva di pensionamento, 66,6 anni, è tra le più alte del continente. Si lavora meno ore alla settimana, ma lungo una vita lavorativa che resta piena. È dunque il “segreto” per conciliare crescita economica e qualità della vita? E, soprattutto, si può immaginare un trapianto di questo schema in Italia?
Come funziona davvero il modello olandese con la settimana lavorativa corta
Più che una “settimana corta” nel senso di quattro giorni identici per tutti, l’esperienza olandese è una cultura della riduzione del tempo di lavoro costruita sulla flessibilità. La leva principale è il part-time volontario, accessibile a molte categorie e in numeri ben maggiori rispetto ad altre economie avanzate. Le ore si distribuiscono su quattro o cinque giorni con orari ridotti, oppure si concentrano in turni più intensi, a seconda di esigenze personali e organizzative. Non esiste una grande legge uniforme: la prassi nasce da contrattazione, consuetudini aziendali e aspettative sociali radicate.
Questa impostazione crea un equilibrio diverso tra impresa e lavoratore. Da un lato, le aziende possono modulare gli organici con più precisione; dall’altro, le persone guadagnano margini di autonomia su famiglia, studio, cura dei figli o semplicemente tempo per sé. La spinta all’efficienza oraria è forte: se le ore disponibili sono meno, l’organizzazione tende a eliminare riunioni inutili, ridondanze, passaggi burocratici che non generano valore.
I vantaggi: produttività, partecipazione, benessere
Il primo beneficio è la produttività per ora lavorata. Concentrarsi su finestre temporali più brevi, con obiettivi chiari e tempi certi, riduce la dispersione e migliora l’attenzione. In molti contesti il lavoro si fa più intenso ma anche più mirato, con effetti positivi sulla resa.
Un secondo effetto è l’allargamento della platea occupata. Con orari più contenuti, persone che altrimenti resterebbero ai margini — genitori con carichi di cura, studenti, lavoratori più anziani — trovano spazio nel mercato del lavoro. Il tasso occupazionale olandese lo mostra con evidenza: a fronte di settimane più leggere, lavora una quota molto ampia della popolazione. In confronto, Regno Unito, Stati Uniti e Francia evidenziano livelli più bassi (rispettivamente 75%, 72% e 69% secondo i dati citati nel testo di partenza). Non è solo una questione di numeri: è la capacità di costruire carriere non lineari, che si espandono e si contraggono in base alle fasi della vita, senza costringere a uscire definitivamente dal circuito.
C’è poi il capitolo della salute. Orari che lasciano spazio al riposo, alla socialità e alla prevenzione riducono il rischio di burnout, abbassano l’assenteismo e migliorano il clima interno. Le organizzazioni che abbracciano questo approccio, spesso, registrano una fidelizzazione più alta e un turnover più contenuto, perché il lavoro diventa sostenibile nel tempo.
Infine, la “settimana corta” olandese ha un valore simbolico: indica che la crescita non è sinonimo di straordinari infiniti. Dimostra che si può puntare sulla qualità e sull’innovazione, non soltanto sulla quantità di ore. L’età effettiva di pensionamento elevata si spiega anche così: se il carico settimanale è più equilibrato, si può restare attivi più a lungo senza logorarsi.
Le ombre: disparità, carriere a due velocità, complessità organizzativa
Il lato B esiste e non va minimizzato. Il primo rischio è la “penalità da part-time”: meno ore significano, spesso, retribuzioni ridotte e contribuzioni previdenziali più basse. Se la riduzione non viene accompagnata da adeguati correttivi, la pensione futura può risentirne. Ciò apre un tema di equità intergenerazionale e tra generi, perché in molti paesi — e i Paesi Bassi non fanno eccezione — a scegliere orari ridotti sono in prevalenza le donne, con impatti su carriera e busta paga.
Secondo nodo: la progressione professionale. In contesti molto competitivi, chi lavora part-time talvolta incontra un “soffitto” implicito: meno disponibilità a riunioni tardive, trasferte o progetti intensivi può rallentare l’accesso a ruoli di responsabilità. Senza una vigilanza consapevole, il sistema rischia di creare carriere “di serie A” a tempo pieno e “di serie B” a tempo ridotto.
Terzo elemento: la complessità gestionale per le imprese. Orari spezzati, turni incastrati e staff più frammentati richiedono competenze organizzative, software di pianificazione, chiarezza nei passaggi di consegne. Dove questi strumenti mancano, la qualità del servizio può risentirne. Non tutti i settori si prestano con facilità: nelle filiere manifatturiere a ciclo continuo o nei servizi essenziali (sanità, scuola, trasporti) la copertura deve essere garantita senza soluzione di continuità, e ciò rende l’incastro più delicato.
Infine, occorre evitare letture miracolistiche: la forza dell’economia olandese dipende anche da fattori strutturali — capitale umano, specializzazione, apertura ai mercati — che non si replicano semplicemente riducendo le ore. La settimana corta funziona perché poggia su un ecosistema: organizzazione efficiente, contrattazione matura, servizi di supporto diffusi.
È applicabile in Italia?
La domanda cruciale è qui. L’Italia ha un tessuto produttivo dominato da piccole e medie imprese, forti differenze territoriali, un peso rilevante di turismo e ristorazione, e una pubblica amministrazione che fatica ancora a digitalizzarsi in modo omogeneo. Sono caratteristiche che rendono complesso un cambio uniforme di orario per legge. Ma complesso non vuol dire impossibile.
Alcuni settori sono più pronti di altri. Dove il lavoro è misurabile per obiettivi (servizi professionali, sviluppo software, consulenza, una parte dell’amministrazione), la riduzione oraria può essere sperimentata con maggiore facilità. Nelle catene produttive e nella logistica, invece, servono investimenti tecnologici e una programmazione attenta per evitare colli di bottiglia. Nel turismo, che vive di stagionalità, si può immaginare un’alternanza: settimane più lunghe nei picchi, più corte nei periodi di bassa, con strumenti di compensazione certi.
Tre condizioni, però, appaiono decisive:
-
Neutralità salariale o meccanismi di tutela. Se l’obiettivo è ridurre l’orario a parità di retribuzione, il guadagno di produttività deve essere reale e misurabile; altrimenti, almeno per le fasce più deboli, servono misure che evitino un taglio dei redditi e una futura pensione sottile. In alternativa, si può consentire una modulazione dell’orario volontaria ma accompagnata da contributi figurativi o incentivi mirati.
-
Contrattazione di qualità. Il cuore del modello olandese è la negoziazione. In Italia, i contratti collettivi nazionali potrebbero aprire corridoi per riduzioni di orario settoriali, lasciando alla contrattazione aziendale il compito di costruire soluzioni su misura (quattro giorni, orari flessibili, banca delle ore, rotazioni). L’essenziale è definire obiettivi, indicatori e verifica periodica dei risultati, evitando di scaricare costi organizzativi solo su una parte.
-
Servizi abilitanti e organizzazione. Ridurre l’orario ha senso se la giornata “liberata” può davvero essere usata per vivere meglio: asili accessibili, trasporti efficienti, sanità territoriale, sport e cultura fruibili. Anche dentro le aziende servono strumenti: pianificazione turni, documentazione chiara, processi snelli, uso intelligente del digitale per tagliare tempi morti.
Accanto a queste condizioni, è utile distinguere tra tre strade operative:
-
Settimana compressa: stesso monte ore in quattro giorni. È la formula più semplice per uffici e servizi con attività concentrabili, ma non riduce davvero il carico complessivo — cambia solo la distribuzione.
-
Riduzione secca delle ore: meno tempo a parità di stipendio, in cambio di produttività più alta. Va introdotta per gradi, con obiettivi chiari e monitoraggio trimestrale.
-
Part-time volontario di qualità: per chi sceglie meno ore, garanzie su contributi, accesso alla formazione e possibilità di rientrare a tempo pieno senza stigmi.
Pro e contro nel contesto italiano
Punti a favore: migliore equilibrio vita-lavoro, attrattività per talenti che oggi guardano all’estero, riduzione dell’assenteismo, spinta a innovare i processi. Una settimana più corta può rendere sostenibile la permanenza al lavoro di persone più anziane, alleggerire i carichi di cura e aumentare la partecipazione femminile, senza condannare a carriere intermittenti.
Criticità: rischio di cristallizzare disparità se la riduzione oraria si traduce in salari più bassi e pensioni magre; difficoltà operative per le microimprese; pericolo di “fare finta” di tagliare le ore e poi rientrare dalla finestra con straordinari informali. Da non sottovalutare la cultura del lavoro: in molti contesti italiani, la presenza lunga è ancora percepita come segnale di dedizione. Servirà un salto verso la misurazione per risultati.
Allora: funziona?
Sì, ma perché è un sistema e non un semplice taglio lineare delle ore. Nei Paesi Bassi l’architettura regge grazie a un mix di part-time diffuso, organizzazioni snelle, obiettivi chiari e servizi che rendono praticabile la scelta di lavorare meno ore a settimana. Gli indicatori disponibili — occupazione elevata, buona produttività e un’età effettiva di pensionamento alta — suggeriscono che il modello sia coerente e sostenibile.
In Italia può funzionare se viene costruito con pazienza e responsabilità: sperimentazioni mirate, correzioni per evitare penalità su salari e pensioni, investimenti organizzativi e un patto chiaro tra imprese e lavoratori. La settimana corta non è una bacchetta magica, ma può essere un volano per fare ciò che serve comunque: ripensare processi, ridurre burocrazia inutile, puntare su qualità, tecnologia e formazione. In un paese che vuole crescere senza bruciare le persone, vale la pena provarci — evitando slogan e misurando, con serietà, ciò che davvero cambia.
The post Il modello olandese con la settimana lavorativa corta funziona davvero? appeared first on lentepubblica.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0

/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/09/wp_drafter_181208.jpg)
/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/09/wp_drafter_181210.jpg)






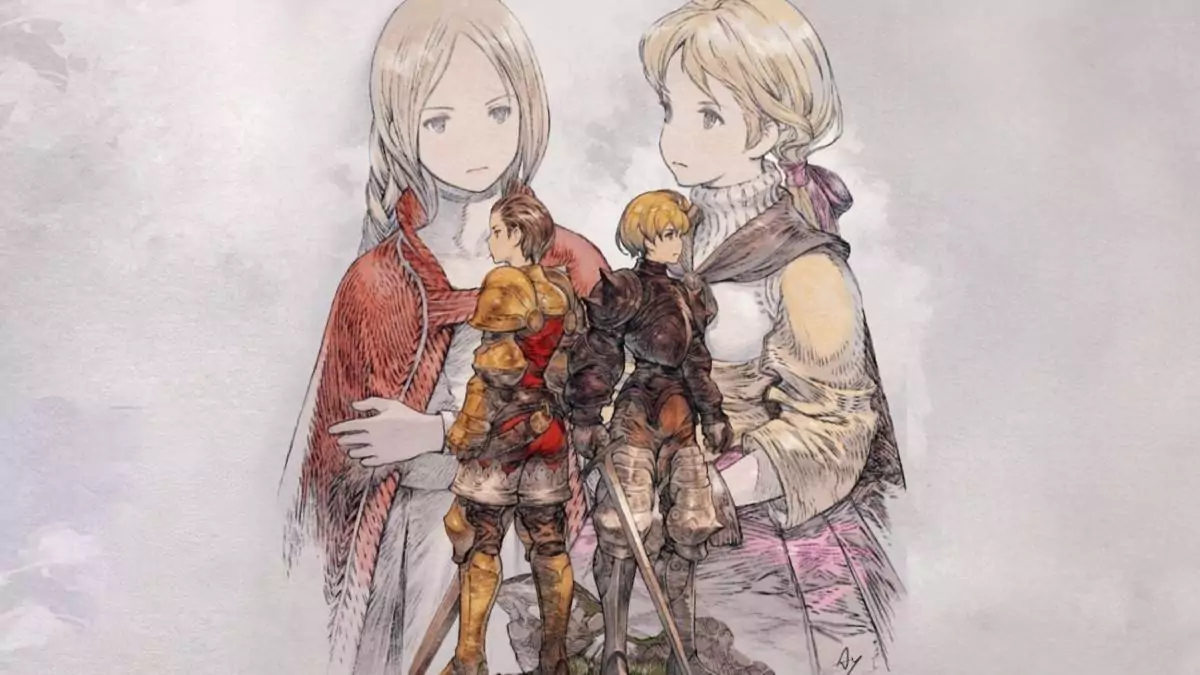





































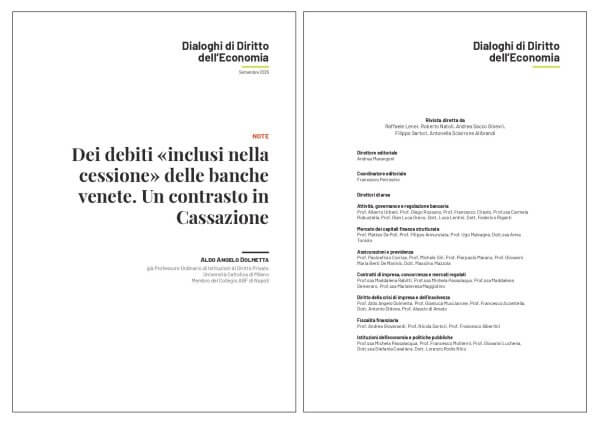
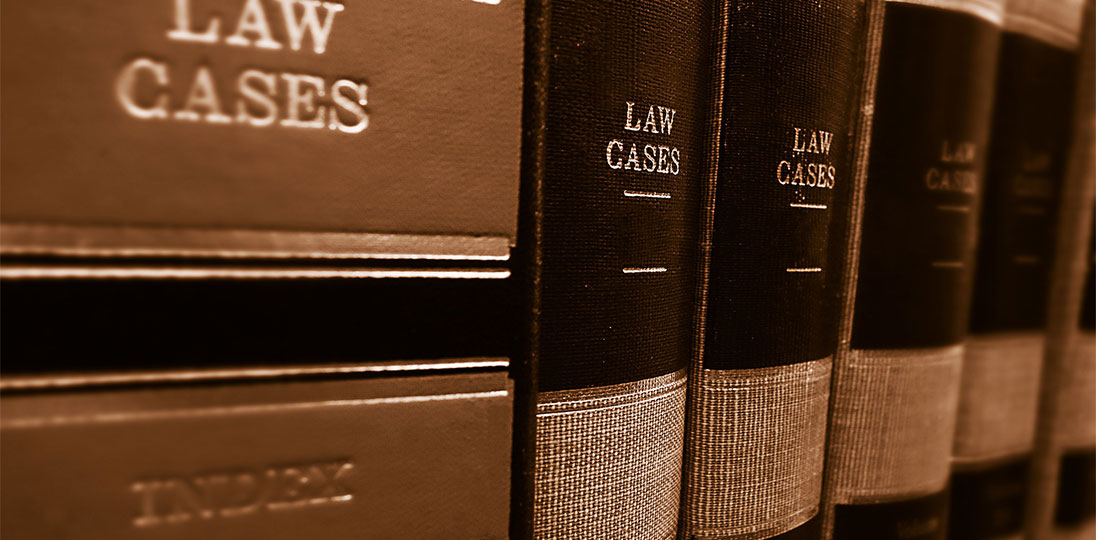












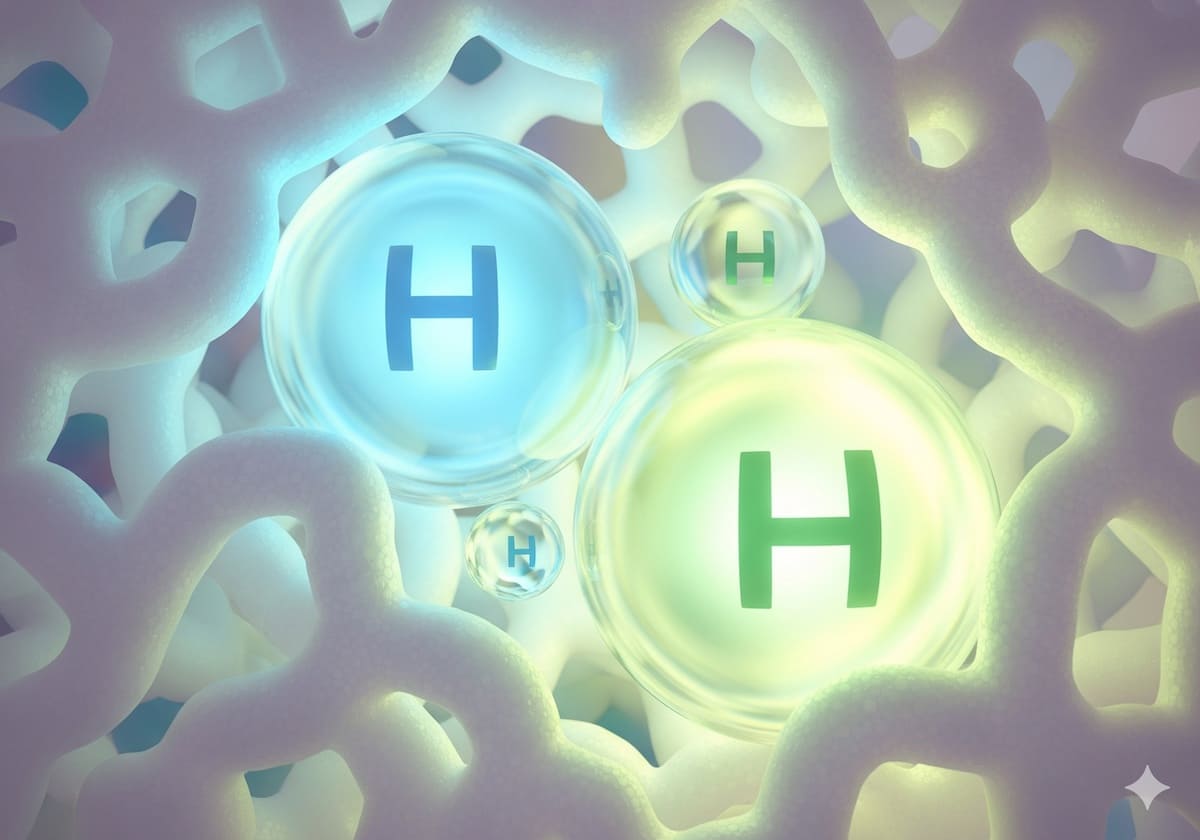



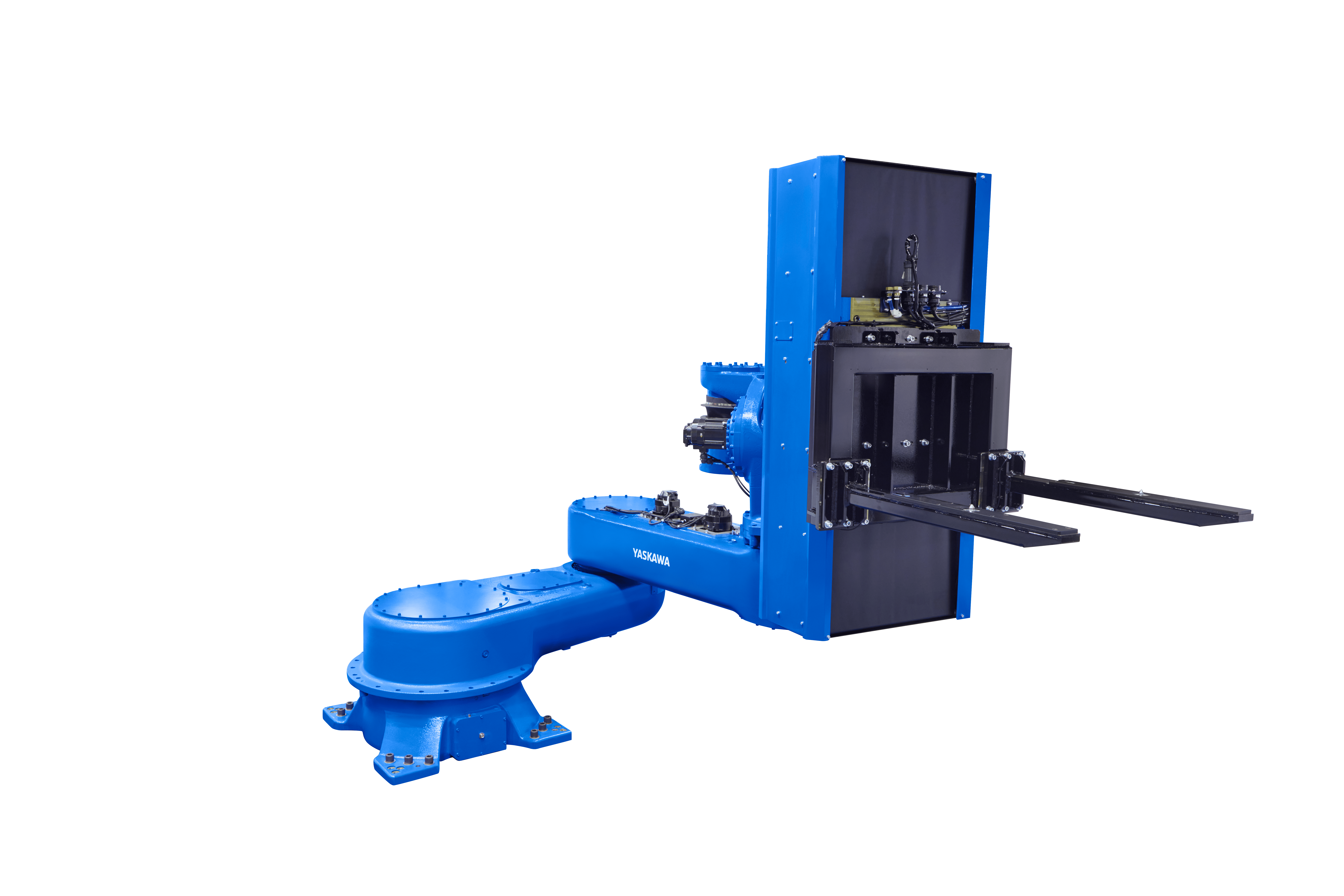





















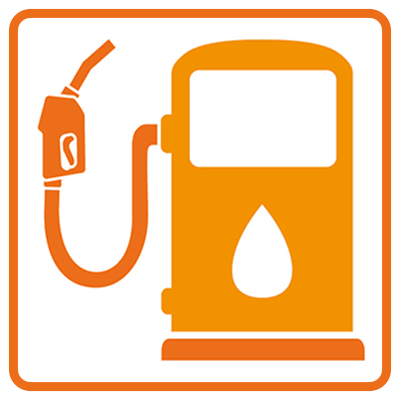
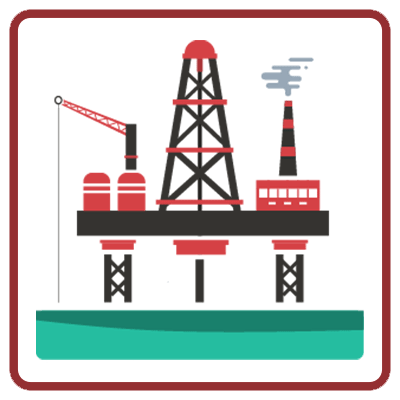

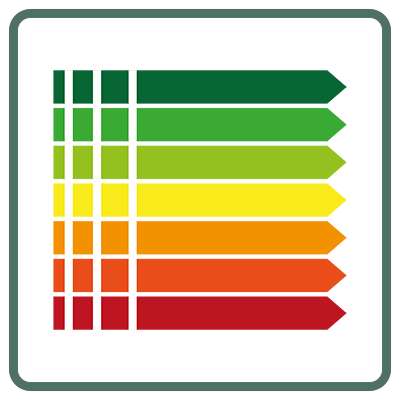


































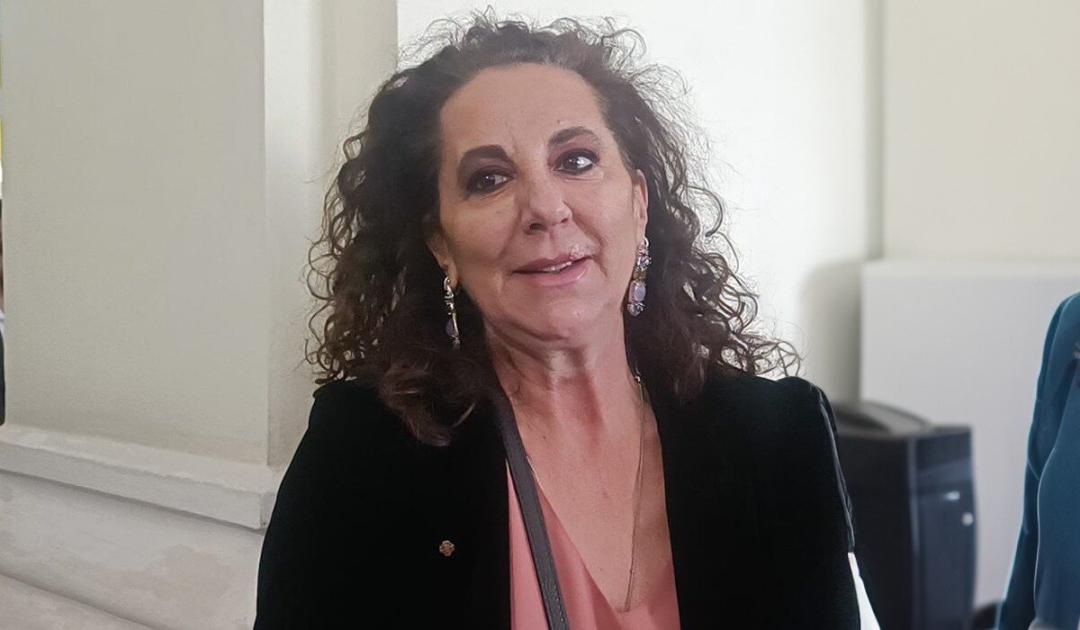






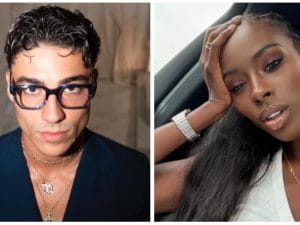
















































%20Carole%20Bethuel.jpg)













-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)