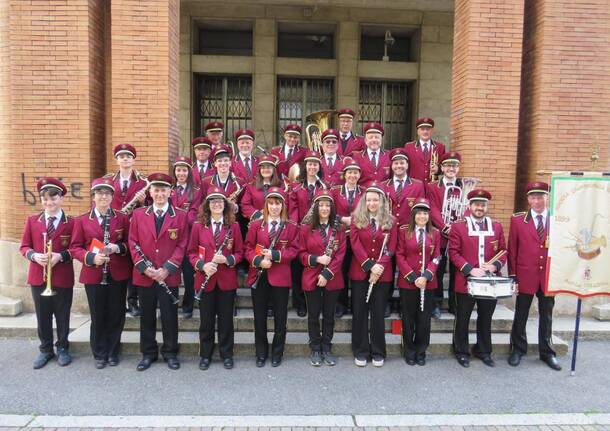C’erano una volta il corpo e la materia


Il ricordo più significativo che ho del mondo in cui sono nato, a Milano, riguarda le scarpe. C’era sempre bisogno di scarpe nuove, ma non solo perché crescevo: si consumavano, si rompevano, si distruggevano. Era un mondo fisico, dove ogni giorno facevi chilometri e chilometri senza mai allontanarti molto, sempre in giro, sempre fuori. Il mio corpo da ragazzino lo portava scritto addosso: le ginocchia erano un campo di battaglia, piene di croste, graffi, sbucciature. Oggi, se non fosse per mio figlio che gioca a calcio nel Gavirate, non credo che si sbuccerebbe mai.
Oggi consumiamo più i polpastrelli. Era anche un mondo di pratica religiosa cattolica, o di appartenenza di partito, che stavano nel quotidiano come l’aria. La nonna Elisa ascoltava “Ascolta, si fa sera” ogni giorno, andava a messa tutte le sere. Io facevo il chierichetto, coi turni il sabato e la domenica, e si organizzavano gite al seminario di Venegono per capire se qualcuno di noi avesse la vocazione. Alla sera, prima di spegnere la luce, si dicevano le preghiere, sempre le stesse, tutti i santi giorni.
Giocavo a basket nella squadra dell’oratorio di via Bonvesin de la Riva, quella che oggi è diventata l’Urania Milano, perfino famosa. Quando ero bambino, a Milano in via Arconati, tutto ciò che possedevo stava in tre ripiani di uno sportello nel retro del negozio di salumeria dei miei genitori. Uno io, uno mia sorella, uno condiviso. I vestiti erano di sopra, in camera: due cassetti poco profondi ma larghi, e finiva lì il nostro mondo materiale. Non ci mancava nulla.
Il negozio aveva un solo elettrodomestico moderno: la cella frigorifera per salumi e formaggi. Niente lavastoviglie, neppure di quelle professionali, solo un grande forno per i polli. Per scaldarci c’era una stufa a kerosene. Il telefono era appeso al muro, uno solo, e per sapere i numeri si usavano le pagine bianche e gialle. Poi c’erano i giornali: mio padre comprava tutti i giorni il Corriere e la Gazzetta, e così cominciava la giornata.
Di plastica, quasi nulla. Tutto era carta, cartone, lattine, vetro che si riportava per farlo riempire di nuovo. Non c’era raccolta differenziata: c’erano meno scarti, e basta. I soldi erano solo contanti. Li contavo io nel cassetto a fine giornata. Oggi, stanno nel telefono, con conto in bitcoin.
Il quartiere era un piccolo mondo: su cento metri di via Arconati c’erano un negozio di mobili, due latterie, una drogheria, il fruttivendolo, la lavanderia, la panetteria, un bar per ogni angolo e, ovviamente, la nostra salumeria. Tutti si conoscevano. Oggi ci sono rimasti un minimarket cingalese, un negozio di cornici, due bar, una pizzeria e “Il Libraccio”. I tram, allora gialli come i taxi, oggi sembrano un Frecciarossa. E nel cortile non si può più giocare: i bambini danno fastidio. Come allora, del resto. Solo che noi giocavamo lo stesso.
Sono nato nell’anno del picco del baby boom: un milione di bambini. Oggi ne nascono appena trecento settantamila, anche grazie agli immigrati e qualche famiglia di CL. Da piccolo, la domenica mi mettevo la polo Lacoste e per giocare a basket avevo le Converse rosse basse: le metto ancora, un po’ per malinconia. La Nike non esisteva, Apple nemmeno, e tutti i brand tech di oggi neppure. La mia bici da cross aveva la sella lunga, poteva portare un amico o un’amica: era il mio cavallo. Tifavo Milan e Atalanta, leggevo Topolino e Tex Willer. Oggi VareseNews, il Guardian, LinkedIn. E non tocco quasi più carta.
Allora le lettere arrivavano col postino, piene di francobolli che si raccoglievano negli album. Si scrivevano cartoline ad amici e nonne ogni volta che si andava in vacanza. E quando eravamo a Milano Marittima si faceva la fila dopo il gelato per chiamare da una cabina a gettoni, una telefonata al giorno. Oggi arrivano i corrieri di Amazon e Glovo, e i messaggi non si fermano mai, vanno ovunque, non si toccano, e nessuno li raccoglie più.
Il negozio parlava due lingue: l’italiano e il dialetto milanese. Gli stranieri? Uno solo: un operaio inglese sposato con una del Sud, non parlava quasi italiano. Mia madre ci mandava da lui a fare conversazione, sul suo divano, con due stanze in tutto per quattro persone. Ci mostrava Londra, ci parlava in inglese. I miei primi rudimenti. Oggi vivo in una casa su vari piani, tanti bagni e stipata di armadi. Ci sono sette computer, tablet, cinque telefoni, orologi smart, bilance connesse, Alexa. Con il telefono lavoro, faccio video, registro interviste, accedo a ogni informazione. Ma i dati non sono più miei: chissà dove vanno, chi li compra, chi li incrocia. Le lingue sembra che non servano più. Tutto traducibile con un click.
Il tempo dei ragazzi, e degli adulti, è diventato compresso. Per trovare libertà dormo meno: mi ritaglio l’alba e la notte. Mio figlio dorme tantissimo, ma solo al fine settimana. Io allora tutti i giorni, a nanna dopo Carosello. E facevo pure il pisolino, fino a 10 anni.
Oggi la mia giornata si stende sul mondo intero. Potrei lavorare 24 ore su 24, passando dall’Asia all’Europa alle Americhe con un click o una call. All’alba i colleghi di Shanghai e Mumbai, poi il Medio Oriente, l’Europa, e quando qui cala il buio si svegliano in Ohio o a Monterrey. Per fortuna la mia azienda ha la testa in Europa: le riunioni globali le facciamo all’una, prima che i cinesi vadano a dormire e mentre gli americani fanno colazione. Noi sacrifichiamo il pranzo, loro la quiete del mattino. Si parla inglese. Ironia della sorte: è la materia in cui a scuola ho sempre fatto più fatica. Ma è diventata pane quotidiano.
Qualche giorno fa ho visto un filmato della festa annuale dei miei colleghi indiani: centinaia di giovani ingegneri e operatori. La festa è iniziata con tuffi in piscina, poi giochi, premi, e infine balli sfrenati in discoteca: un bagno di energia vitale. Ho pensato a quando, un anno fa, sono andato da loro e hanno piantato un albero per me, scambiandomi per un pezzo grosso. Si saranno sbagliati, ma resta la gentilezza. Un mondo in movimento, pieno di sogni, ideali, contraddizioni, caste e tecnologia. Diversissimo dalla nostra Italia degli anni Sessanta, eppure con la stessa fame di futuro.
Quello della mia Milano era un mondo fatto di abnegazione, lavoro, sacrificio, con un’idea chiara: restituire alle nuove generazioni un futuro meno faticoso. Un’Italia che aveva ancora fresca e viva la memoria del ventennio, della guerra, della sconfitta, ma anche una voglia enorme di emergere, di affermarsi, di allontanarsi il più possibile dallo spettro della fame, della povertà, della miseria. Mio padre me lo diceva sempre: «Io non voglio che tu faccia il mio lavoro. Studia.»
Oggi questo senso di destino, di missione, non c’è più. E non mi sembra che riusciamo a trasferire ai nostri figli, alle nuove generazioni, una vera visione del mondo, della storia, dei valori.
«Ho imparato che il corpo sa delle cose che la mente non sa,
e le dice piano, con la pazienza dei fiori che sbocciano.
Bisogna stare fermi, farsi accanto, sentire.
Il corpo è il nostro eremo,
lì dimora un sapere antico, la memoria dei semi.»
Chandra Livia Candiani
L'articolo Protestano a Malpensa contro il rimpatrio di uno straniero irregolare, quattro donne denunciate sembra essere il primo su VareseNews.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0

































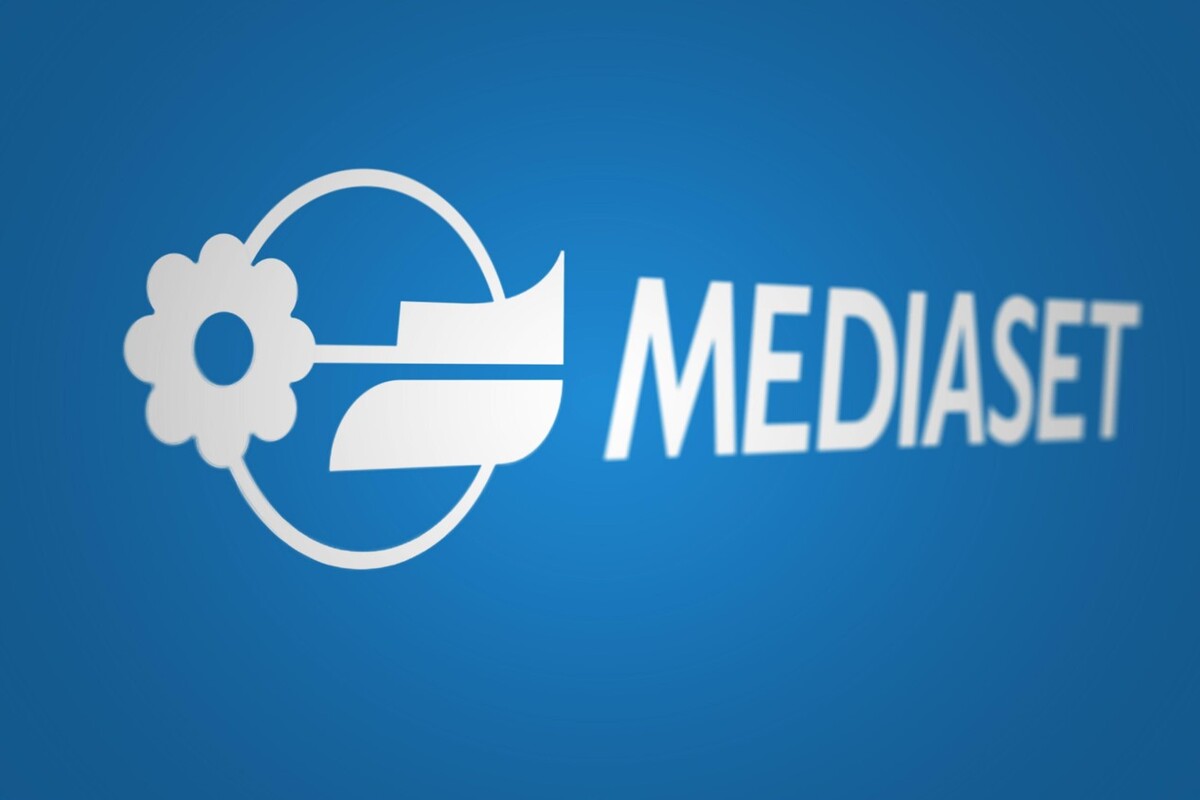




















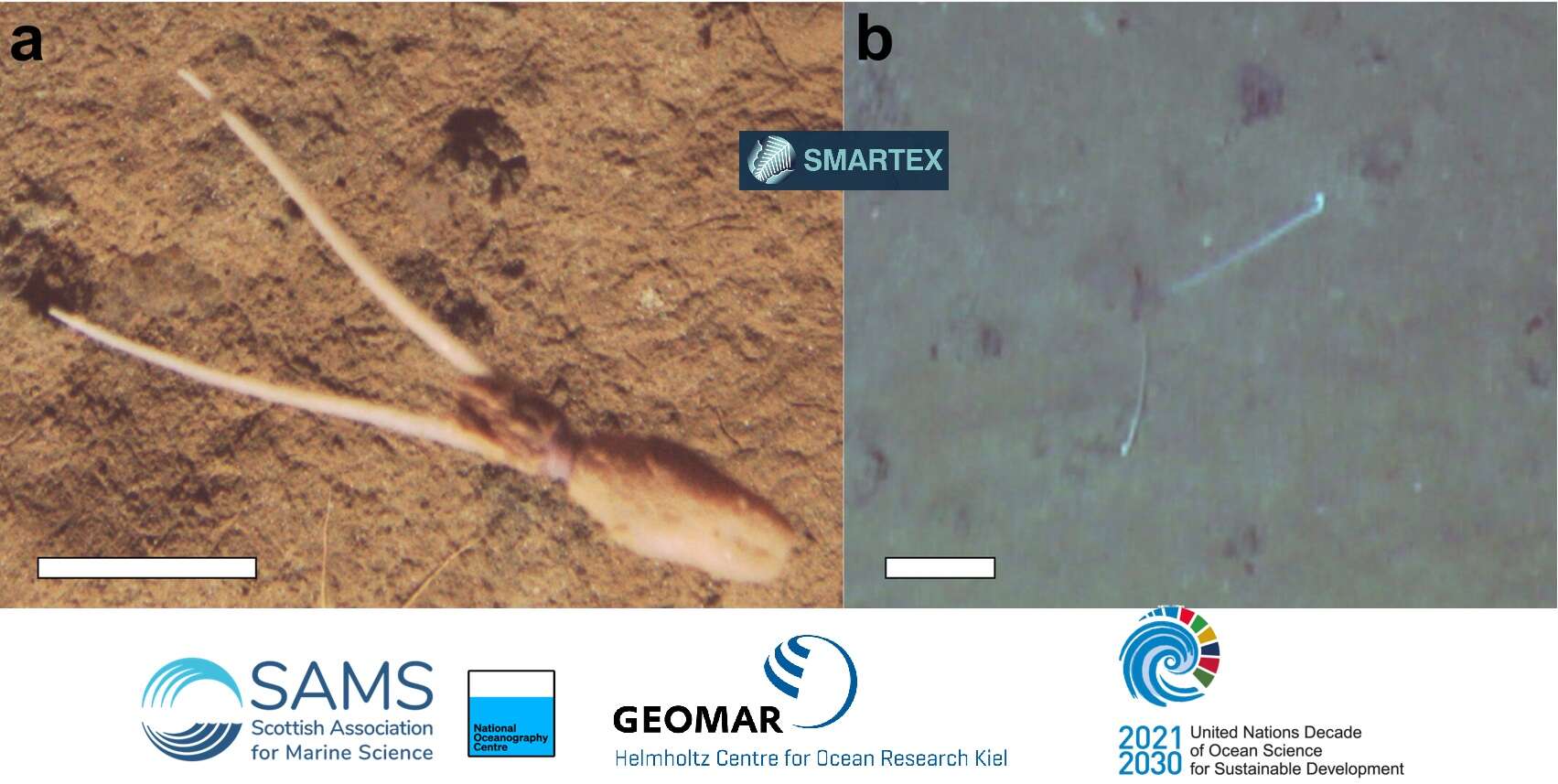







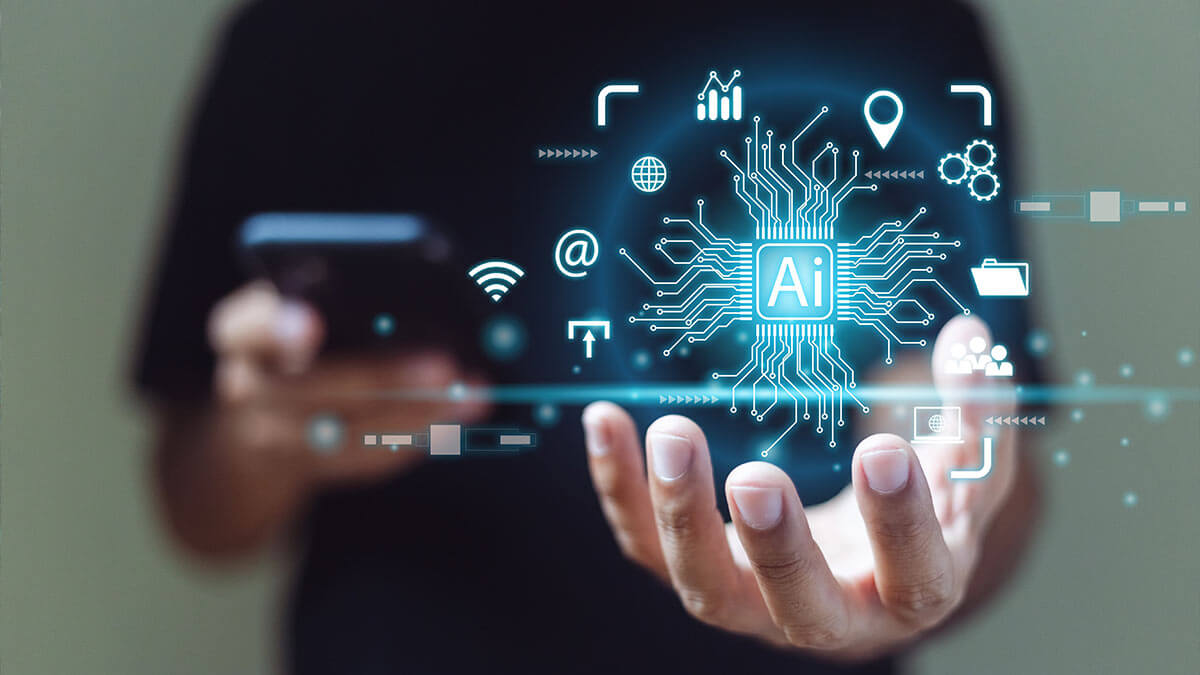
























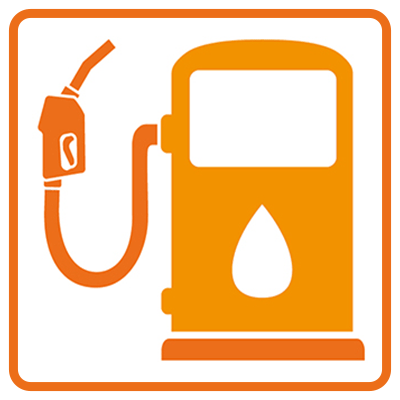

































































































_(50)-1765960548246.jpg--tamponamento_tra_due_auto_sulla_provinciale_che_collega_castellamonte_a_cuorgne__grande_spavento_e_lievi_contusioni_per_i_conducenti.jpg?1765960548409#)






-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)