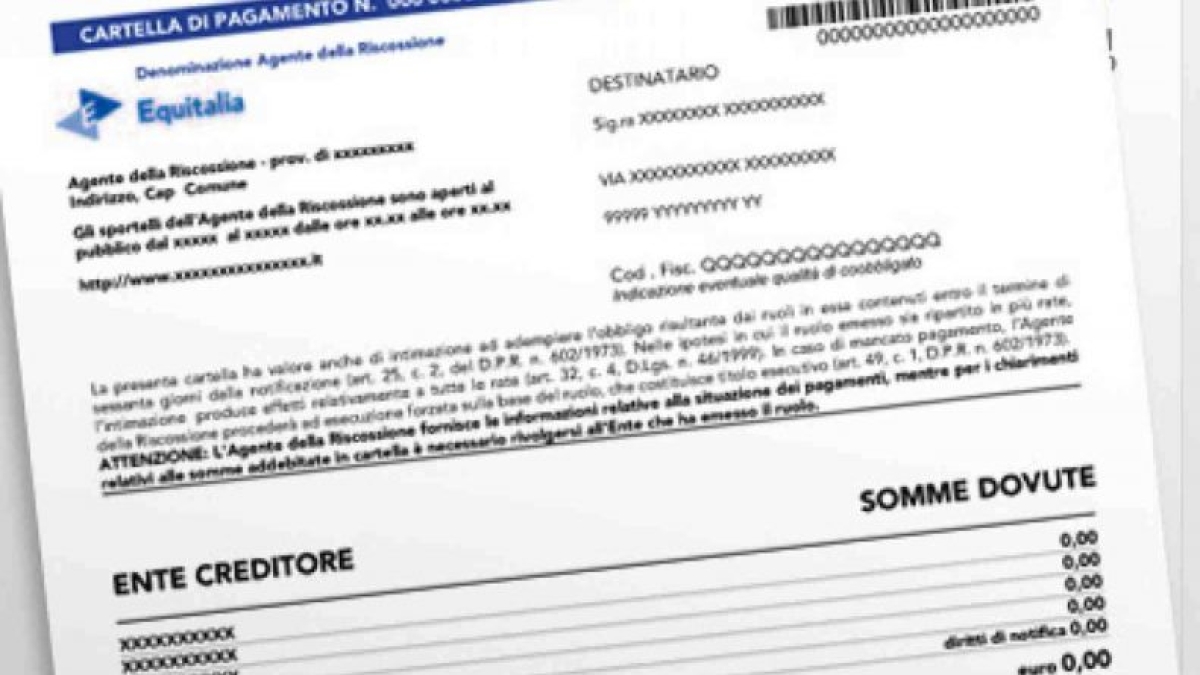Perché l’automazione può aumentare o ridurre salari e occupazione: lo studio di David Autor e Neil Thompson

AUTOMAZIONE E OCCUPAZIONE
Perché l’automazione può aumentare o ridurre salari e occupazione: lo studio di David Autor e Neil Thompson
Perché l’automazione a volte fa salire i salari e altre li riduce? Un nuovo studio degli economisti del MIT Autor e Thompson offre una risposta che si focalizza sul ruolo dell’expertise: l’impatto dell’automazione cambia radicalmente a seconda che, in una professione, vengano eliminati task a bassa o alta specializzazione. Se vengono automatizzati i compiti più semplici, l’expertise richiesta aumenta, spingendo i salari verso l’alto ma riducendo l’occupazione. Se invece vengono automatizzati i compiti più complessi, la professione si “dequalifica”, portando a salari più bassi ma a un aumento dei posti di lavoro…

Il dibattito sugli effetti dell’automazione sul mondo del lavoro oscilla – ormai da decenni – tra visioni tecnofobe che vedono un futuro prossimo di disoccupazione di massa e narrazioni iperottimistiche di una ineluttabile transizione verso nuove e migliori opportunità. Malgrado l’abbondanza di studi, la letteratura economica non ha ancora fornito risposte definitive a una domanda fondamentale: perché, in alcuni casi, l’automazione sembra deprimere i salari e l’occupazione, mentre in altri pare accadere l’esatto contrario? La questione si è fatta ancora più pressante con l’avvento dell’intelligenza artificiale generativa, che promette di automatizzare compiti cognitivi un tempo considerati al riparo dalle macchine.
Proprio di questi temi si occupa un nuovo e importante lavoro di ricerca pubblicato dal National Bureau of Economic Research (NBER), intitolato semplicemente – e significativamente – “Expertise”. Gli autori sono due economisti del Massachusetts Institute of Technology (MIT): Neil Thompson e David Autor, una delle voci più autorevoli a livello mondiale sul rapporto tra tecnologia e mercato del lavoro. Gli studi di Autor sul tema sono ormai delle pietre miliari per chi studia questi argomenti. Recentemente Autor ha esteso le sue analisi al campo dell’intelligenza artificiale, sostenendo che questa tecnologia potrebbe offrire nuove opportunità alla classe media proprio perché agisce sul valore dell’expertise umana.
Il nuovo studio prosegue e approfondisce questa linea di pensiero, offrendo un quadro concettuale inedito per interpretare le dinamiche apparentemente contraddittorie dell’automazione.
Superare i modelli tradizionali
I limiti dei modelli economici convenzionali emergono con chiarezza quando si tratta di spiegare la varietà degli esiti osservati. L’approccio basato sul capitale umano, ad esempio, suggerisce che la riduzione della domanda di una determinata “abilità” (skill) dovrebbe avere effetti simili su tutte le professioni che la utilizzano. Anche i più moderni “task models”, sviluppati dallo stesso Autor, pur offrendo una visione più granulare, tendono a prevedere impatti omogenei per i lavoratori i cui compiti vengono automatizzati. Ma la realtà evidenzia un quadro decisamente più variegato.
Per superare questi limiti, Autor e Thompson propongono un “framework dell’expertise”. La loro idea è tanto semplice quanto potente: l’impatto dell’automazione non dipende solo da quali e quanti compiti vengono automatizzati, ma dal livello di competenza (expertise) di quei compiti in relazione a tutti gli altri che compongono una specifica professione. L’automazione – spiegano gli autori – non è un processo monolitico, ma un intervento selettivo che può innalzare o abbassare l’asticella delle competenze richieste per svolgere un determinato lavoro.
L’expertise come fattore discriminante
Il modello proposto si fonda su due concetti chiave. Il primo è l’expertise, definita come la capacità di un lavoratore di svolgere compiti specifici che richiedono conoscenza e formazione. L’expertise non è solo un’abilità, ma funge anche da barriera all’ingresso: solo chi la possiede può accedere a determinate professioni.
Il secondo concetto è quello di “task bundling“, ovvero l’idea che le professioni non sono costituite da un singolo compito, ma da un “pacchetto” di attività con diversi livelli di competenza. Un lavoratore, per essere impiegato in una certa occupazione, deve possedere l’expertise necessaria a svolgere il compito più complesso di quel pacchetto.
L’automazione non si limita a sostituire il lavoro umano, ma rimuove di fatto la necessità di possedere l’expertise associata a quel compito. È qui che si manifestano gli effetti divergenti. Se l’automazione elimina un compito a basso contenuto di expertise, il livello medio di competenza richiesto per la professione aumenta. Se invece ad essere automatizzato è il compito più complesso, la professione diventa accessibile a una platea più ampia di lavoratori meno specializzati.
L’esempio degli impiegati contabili e degli addetti all’inventario
Per rendere concreta la loro teoria gli autori analizzano l’evoluzione di due professioni profondamente trasformate dall’informatizzazione negli ultimi quarant’anni: gli impiegati contabili e gli addetti all’inventario.
Nel caso degli impiegati contabili, l’automazione ha assorbito principalmente compiti di routine e a basso valore aggiunto, come la registrazione di transazioni o la riconciliazione di estratti conto. I compiti rimasti in capo all’essere umano sono quelli che richiedono maggiore capacità decisionale e di problem-solving. Di conseguenza il livello di expertise richiesto è aumentato. L’esito, documentato dai dati empirici, è stato un aumento dei salari, spinto dalla maggiore scarsità delle competenze richieste, accompagnato però da una riduzione dell’occupazione, perché meno persone erano qualificate per svolgere il nuovo ruolo.
Per gli addetti all’inventario è accaduto invece il contrario. Qui, l’automazione ha sostituito attività che, per quella professione, erano relativamente complesse, come la verifica della conformità dei prodotti a specifiche tecniche. I compiti residui, come contare, pesare o immagazzinare la merce, sono diventati più semplici. La richiesta di expertise è diminuita, aprendo la professione a lavoratori con minori competenze. Il risultato è stato un aumento dell’occupazione, accompagnato però da una riduzione dei salari relativi.
La verifica empirica e i risultati
Autor e Thompson non si fermano alla teoria. Hanno testato il loro modello analizzando i dati su 303 professioni statunitensi tra il 1977 e il 2018. Per farlo, hanno sviluppato una metodologia innovativa per misurare l’expertise in modo oggettivo. Hanno analizzato i testi dei mansionari ufficiali partendo da un’idea precisa: una parola è “esperta” se è rara nel linguaggio comune ma, allo stesso tempo, fortemente legata a un campo specifico. Per esempio, il termine “ammortamento” è poco usato in una conversazione quotidiana, ma quando compare è quasi certamente in un contesto economico-aziendale, segnalando quindi un alto livello di expertise.
I risultati empirici confermano le previsioni del modello, dimostrando che esiste un legame diretto e misurabile tra il cambiamento del livello di expertise di una professione e l’andamento dei suoi salari.
E si spiega la dinamica, apparentemente controintuitiva, dell’occupazione: a un aumento dell’expertise richiesta corrisponde un calo dell’impiego, mentre una diminuzione dell’expertise è associata a una crescita dell’occupazione. Queste dinamiche sono l’esatto contrario di ciò che accade quando si considera solo la “quantità” di compiti: nelle professioni con un maggior numero di attività tendono infatti a crescere sia l’occupazione sia le retribuzioni.
Una nuova luce sul “puzzle” dei lavori di routine
Il framework dell’expertise offre anche una spiegazione convincente a un “puzzle” che da tempo interroga gli economisti: perché i salari nelle professioni ad alta intensità di compiti di routine non sono crollati uniformemente, nonostante la drastica riduzione dell’occupazione?
La risposta, secondo Autor e Thompson, è che la categoria “routine” non è omogenea. L’automazione di questi compiti ha avuto un effetto di biforcazione. Nelle professioni dove i compiti di routine erano relativamente più qualificati (come per gli addetti all’inventario), la loro eliminazione ha abbassato il livello di expertise e, di conseguenza, i salari. Nelle professioni dove i compiti di routine erano di supporto e relativamente poco qualificati (come per i contabili), la loro automazione ha innalzato il profilo professionale, spingendo i salari verso l’alto.
Lo studio di Autor e Thompson sposta quindi il focus dell’analisi: per comprendere il futuro del lavoro non basta più concentrarsi sulle mansioni che verranno sostituite, ma bisogna analizzare la qualità e il contenuto di expertise dei compiti che compongono le professioni. L’automazione e l’intelligenza artificiale – questo è il messaggio degli autori – non agiscono in modo uniforme su tutte le occupazioni o su tutti i lavoratori, ma come in maniera selettiva, ridisegnando il valore dell’expertise umana, premiando alcune forme di expertise e rendendone obsolete altre, con effetti contrastanti su salari e occupazione a seconda delle specifiche dinamiche dell’expertise all’interno di ciascuna professione. Una lezione fondamentale per chiunque si occupi di disegnare politiche per il lavoro e per l’innovazione.
L'articolo Perché l’automazione può aumentare o ridurre salari e occupazione: lo studio di David Autor e Neil Thompson proviene da Innovation Post.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0














































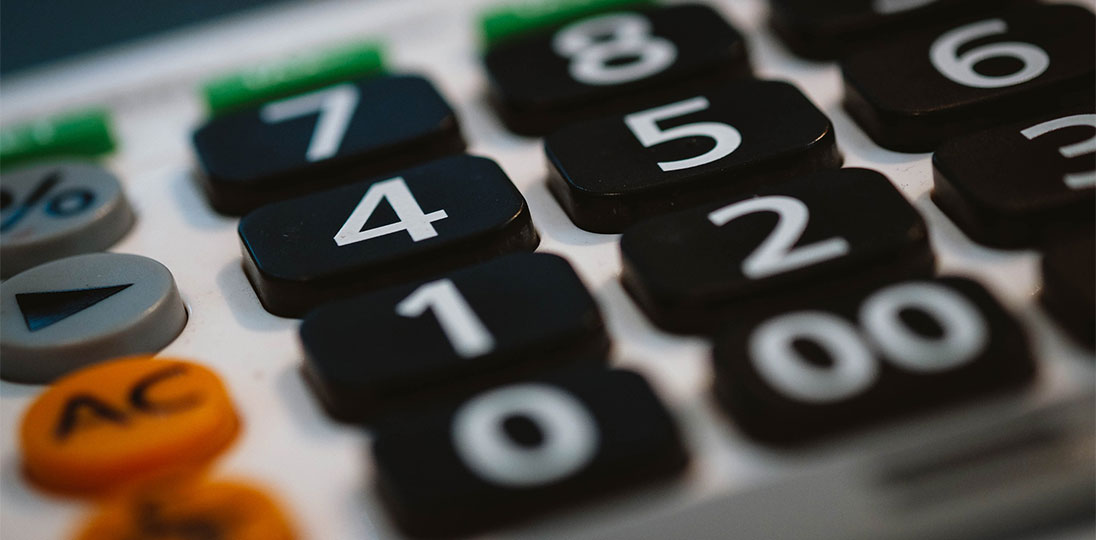







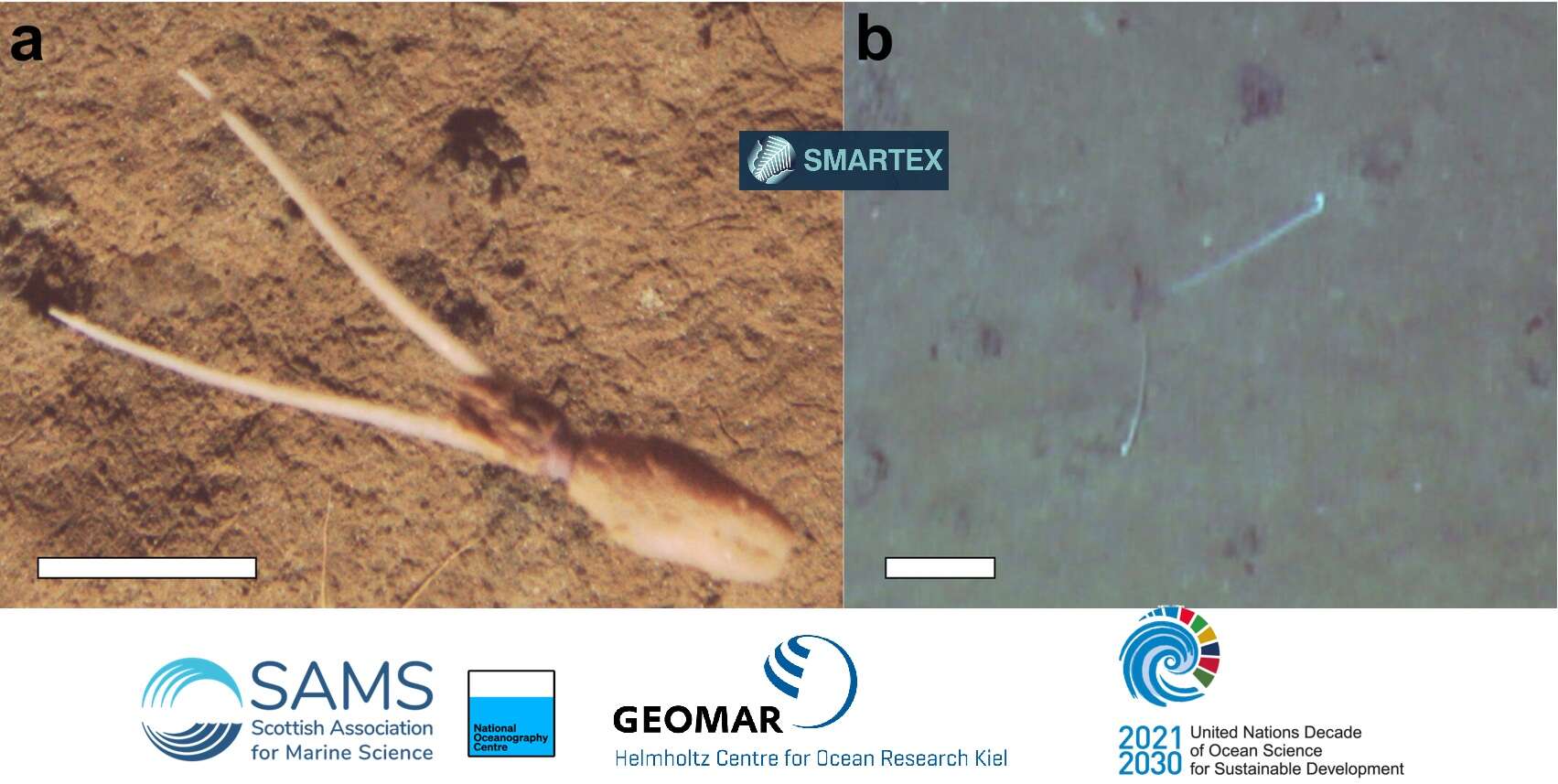







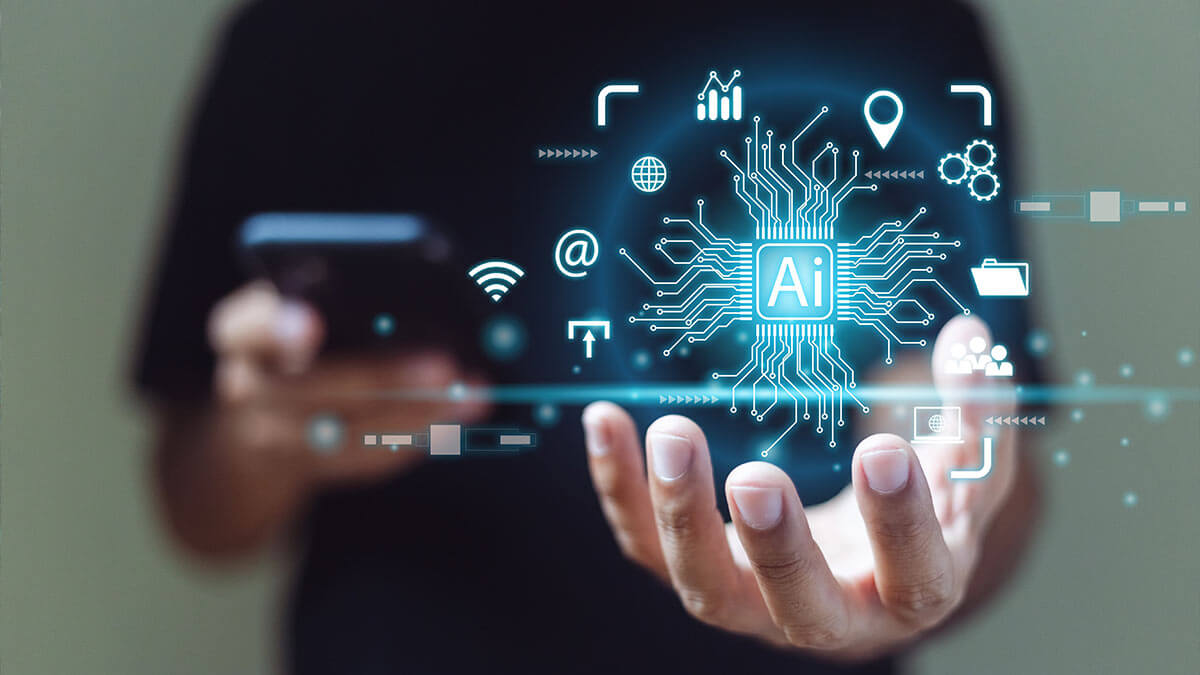


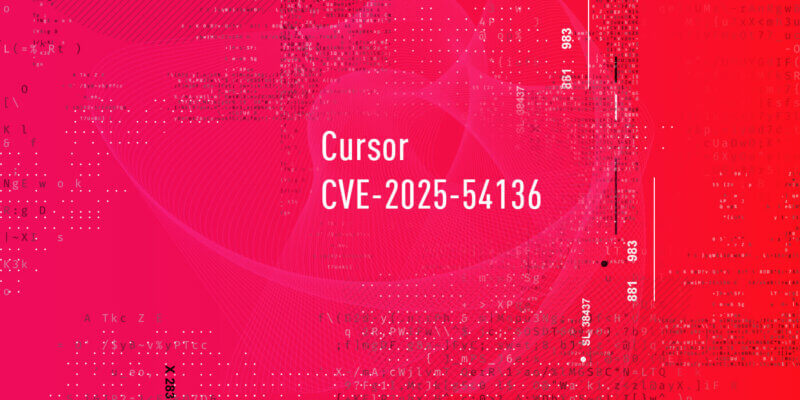















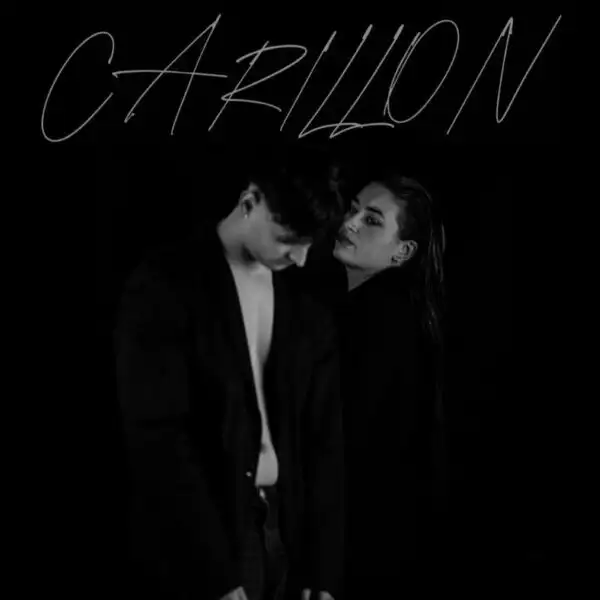





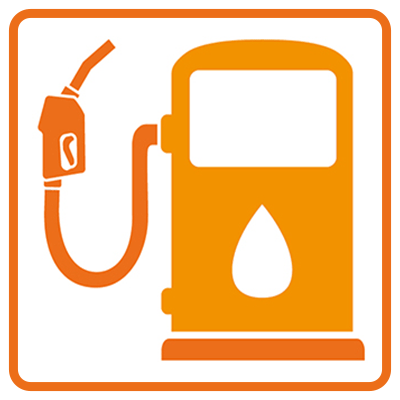




























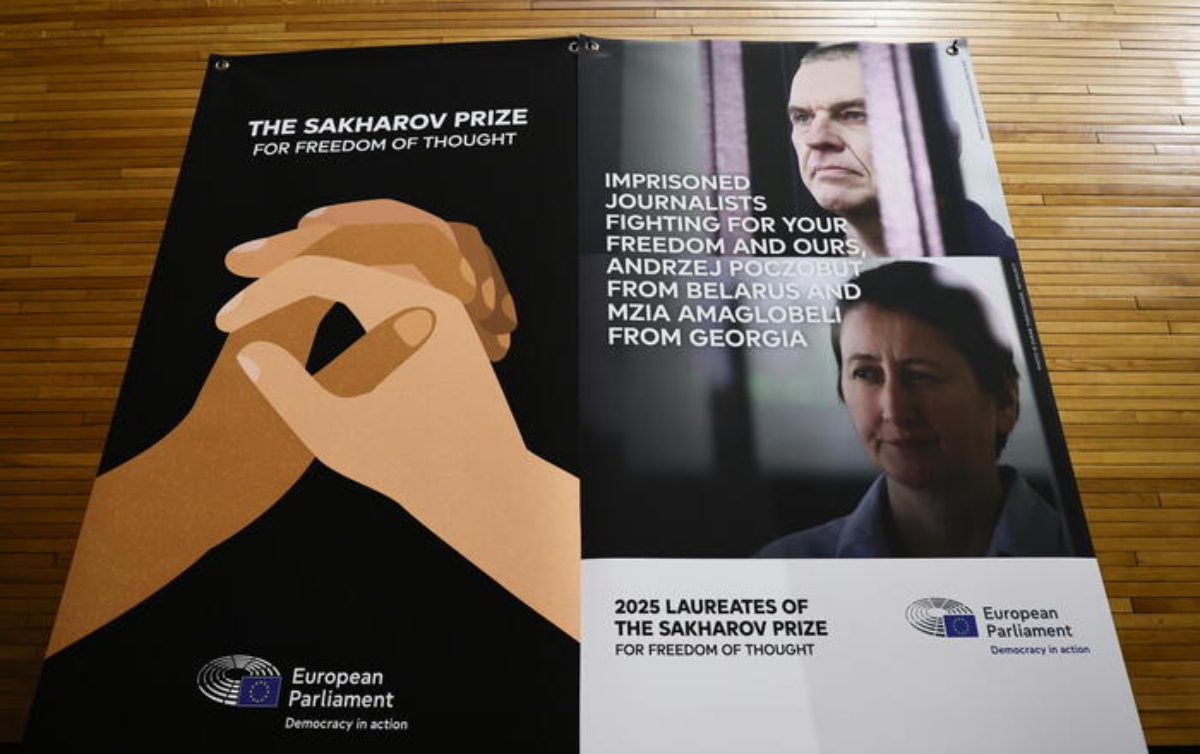




































































_(50)-1765960548246.jpg--tamponamento_tra_due_auto_sulla_provinciale_che_collega_castellamonte_a_cuorgne__grande_spavento_e_lievi_contusioni_per_i_conducenti.jpg?1765960548409#)






-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)