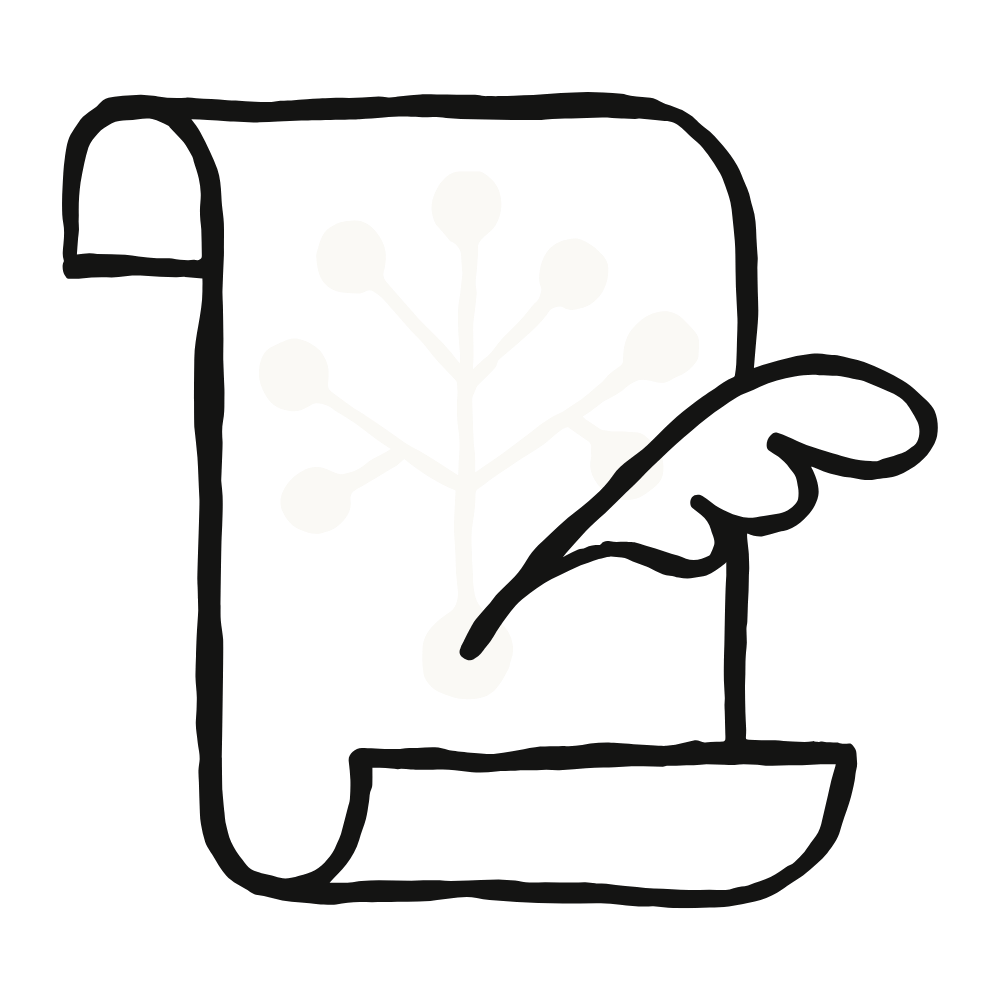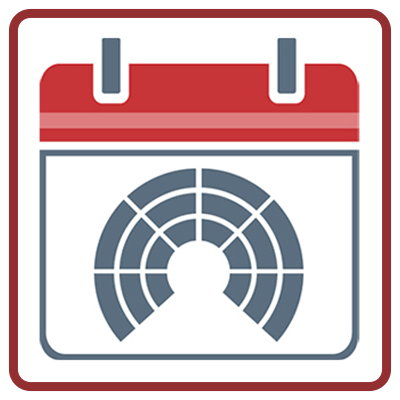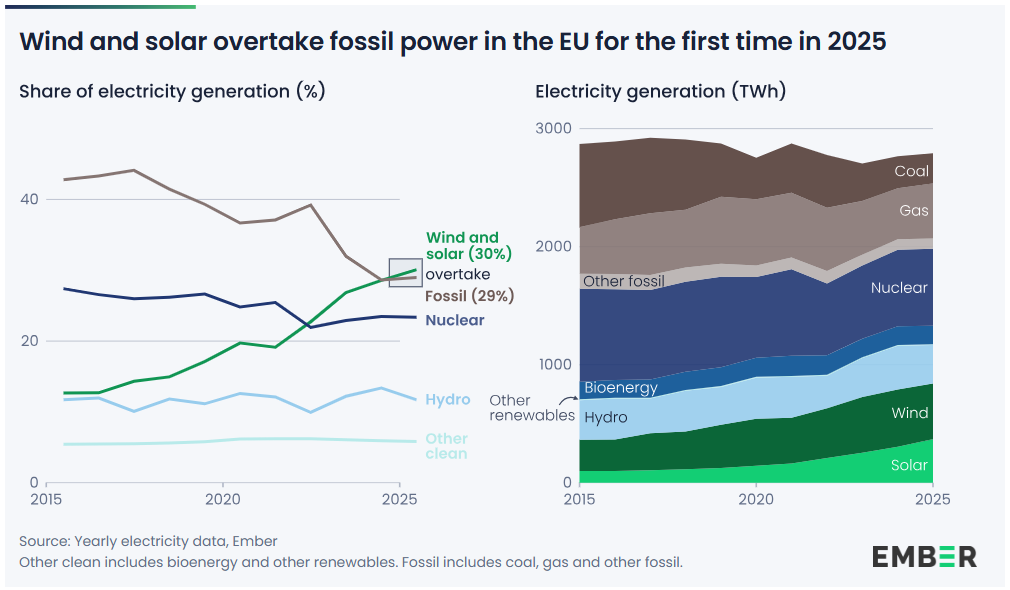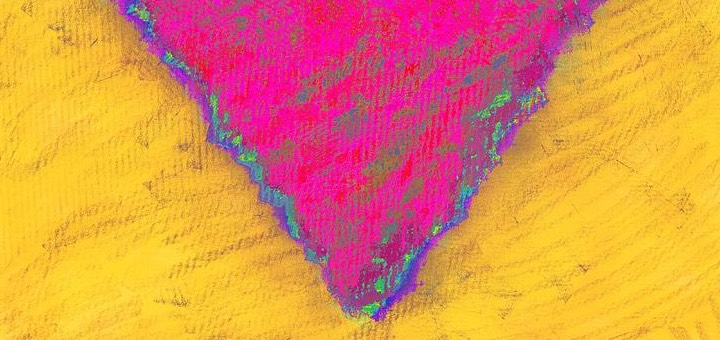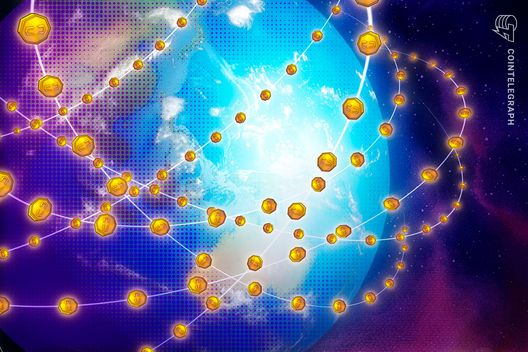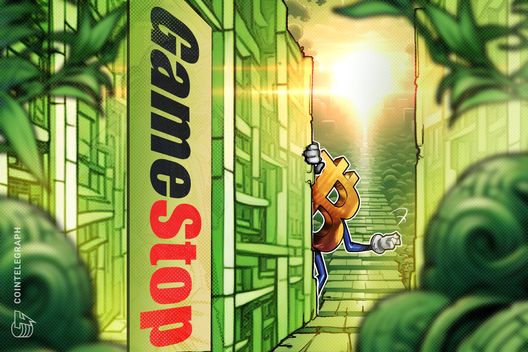L’islamismo radicale recluta l’Occidente con profili fake, Telegram e fondi illeciti


Nora Bussigny la incontro alla stazione di Gare du Midi, a Bruxelles. Ha appena concluso un ciclo di presentazioni del suo libro in Belgio e sta per tornare a Parigi. È una giornalista d’inchiesta come non ne fanno più, almeno dalle nostre parti. Zero vanità personali e molta passione per le storie che ha attraversato – rischiando in prima persona – per comprendere che cosa è saltato nella società francese e in quella occidentale dopo il 7 ottobre. Lei è una figlia della Francia laica e umanista, con radici marocchine e sguardo proteso verso il futuro; si è infiltrata dentro i movimenti pro-Hamas, ha compreso le linee rosse della propaganda e dell’odio contro gli ebrei e contro Israele. Ci sediamo in un caffè che si chiama Bogart, come il protagonista di Casablanca. Nora Bussigny deve spiegare che l’amore per la propria patria passa per molti sacrifici personali.
All’inizio della tua inchiesta dici che hai commesso errori. Che tipo di errori?
All’inizio è stato complicato perché mi muovevo troppo «da esterna». Per esempio, usavo parole che in quei contesti non si usano: dicevo «Israele» negli incontri, nelle manifestazioni, nei gruppi di parola. Ho persino detto «Tsaal». Ma loro non dicono «Tsaal»: dicono «l’esercito genocida». E al posto di Israele usano «entità sionista». Ho capito presto che il linguaggio, lì dentro, non è un dettaglio: è una porta d’ingresso o un muro.
Quando hai capito che dovevi mirare ai gruppi giusti?
Quando ho visto che certi ambienti funzionano per cerchi concentrici: se non entri nei canali giusti, resti fuori dalla parte operativa. Per questo ho iniziato a seguire Samidoun, che è molto presente anche in Italia e, in Belgio, è un problema enorme. È attiva in Francia e in alcuni Paesi è stata vietata. Negli Stati Uniti e in Canada è classificata come organizzazione terroristica.
Come ti sei avvicinata a questi ambienti senza essere respinta subito?
All’inizio non sapevo come avvicinarli. La soluzione pratica è stata costruire identità online fittizie: profili falsi ma credibili, con molti follower e con una presenza costante su contenuti pro-Palestina. Questo fa scattare fiducia: ti leggono come «militante esperta», ti attribuiscono una storia e così ti fanno entrare dove conta davvero.
Dove «conta davvero»?
Nei gruppi Telegram. Sono il cuore dell’organizzazione: lì trovi gli appuntamenti, i luoghi, le convocazioni, le indicazioni pratiche, le immagini più violente che vengono rilanciate e, soprattutto, il senso di comunità e disciplina. Entrando in tante chat ho potuto sapere dove si ritrovavano, seguirli, passare tempo con loro e capire le dinamiche.
Nel tuo libro sostieni che dietro questi movimenti ci siano filiere riconducibili a organizzazioni armate. Che cosa hai visto?
Quello che emerge, e che si sente ripetere in quei circuiti, è che molti gruppi si richiamano o sono collegati a Hamas, Hezbollah, Fplp, Jihad islamica. E c’è un elemento che, nel mio lavoro, torna spesso: la Repubblica islamica dell’Iran come motore di una parte di queste reti. Parlo anche di agenti d’influenza, persone molto attive sui social, capaci di spingere narrazioni a favore dell’«Asse della resistenza». Alcuni hanno numeri enormi di follower.
C’è anche il tema del denaro. Come funziona?
Molti collettivi organizzano raccolte fondi e campagne di donazione con slogan umanitari («sostenete Gaza, sostenete i palestinesi»), ma il punto è che i flussi non sono controllati come l’opinione pubblica immagina. Nel mio lavoro cito un caso in Francia: un’associazione su cui si indaga per finanziamento di organizzazione terroristica e associazione a delinquere con finalità terroristica. Parliamo di somme molto alte raccolte sul territorio europeo.
In Italia si parla di arresti e inchieste su invii di denaro e materiali. In Francia esiste una struttura unica simile?
Non ho seguito in dettaglio quanto è emerso in Italia. In Francia, da quello che ho visto, non c’è una sola struttura centralizzata identica. Ci sono invece molte sigle che raccolgono fondi e fanno appelli, spesso in rete tra loro e in ambienti collegati. Nel mio libro e nelle mie ricerche ricorrono nomi di collettivi e campagne che si coordinano, anche se non sempre in modo formalmente unitario.
Tu hai origini marocchine. Questo ha influito sulla tua infiltrazione e sulla reazione dei gruppi?
Sì, ha influito. Io non sono ebrea, non sono mai stata in Israele e non sono musulmana, ma nella mia famiglia ci sono persone musulmane. In quei contesti la mia posizione viene letta con sospetto e spesso con categorie brutali: «traditrice». C’è anche una retorica politica più ampia: il Marocco viene accusato di «tradimento» per i suoi rapporti con Israele e circolano slogan che riflettono anche rivalità regionali, come Algeria-Marocco.
Nel libro insisti sul fatto che questi movimenti non sono «pro-palestinesi», ma «anti-israeliani». Perché?
Perché partecipando e osservando ho notato una cosa costante: non parlano di pace. Non dicono «pace», non dicono «soluzione», non dicono «protezione dei civili» come asse centrale. Il focus emotivo e politico è spesso contro Israele, non per i palestinesi. È un’impostazione che cambia il senso della mobilitazione.
Parli anche della partecipazione LGBTQ+ ai movimenti. Lo presenti come un cortocircuito. Qual è la tua spiegazione?
È un cortocircuito enorme. La spiegazione che ricostruisco nel libro passa dall’intersezionalità: l’idea che tutte le lotte debbano muoversi insieme (LGBTQ+, femminismo, antirazzismo). In teoria è un principio inclusivo. In pratica, in certi ambienti, diventa una griglia binaria: oppressore/oppresso, colonizzatore/colonizzato. In quel sistema Israele viene collocato automaticamente come «colonizzatore», quindi tutto il resto passa in secondo piano, anche le contraddizioni culturali e politiche.
Citi anche l’uso della parola «islamofobia» come strumento di pressione.
Sì. Nel libro ricordo come alcune figure abbiano spinto da anni l’idea che qualsiasi critica verso elementi dell’islam politico, del velo o di dinamiche interne venga riscritta come «islamofobia». Questo produce un effetto: molti attivisti, soprattutto nei circuiti progressisti, preferiscono non esporsi per non essere etichettati come «di destra» o «fascisti». E quindi si crea una specie di immunità politica.
Dopo il 7 ottobre, che cosa hai visto nei social e nei movimenti?
Ho visto, anche riportato nel libro, reazioni inquietanti: celebrazioni della violenza presentata come «rivolta del colonizzato». E ho visto anche tentativi di riscrivere o negare fatti scomodi, perfino su temi come gli stupri: negazione, minimizzazione o spostamento del discorso su categorie astratte («non antisemitismo, ma patriarcato»). In alcuni ambienti tutto viene assorbito dalla lettura «decoloniale», come se quella chiave interpretativa autorizzasse tutto.
Nel tuo libro parli di «entrismo» anche in contesti istituzionali europei. Che cosa intendi?
Intendo l’ingresso e la legittimazione di collettivi e figure militanti in sedi istituzionali, con un effetto di sdoganamento. Nel mio lavoro racconto episodi e inviti che mostrano come certe reti cerchino spazi dentro istituzioni europee, costruendo credibilità e contatti.
Quali sono oggi, secondo la tua inchiesta e il tuo ultimo libro, i principali movimenti politici infiltrati in Francia da queste reti filo-islamiste?
Nel mio lavoro emerge con chiarezza che una parte significativa di questi ambienti ha trovato sponda politica soprattutto nella France Insoumise. È lì che si concentrano le principali complicità, sia sul piano del linguaggio sia su quello della legittimazione pubblica dei collettivi radicali. Figure come Rima Hassan sono centrali in questo dispositivo: invitano organizzazioni legate ai Fratelli musulmani nelle istituzioni europee, partecipano a iniziative con collettivi radicali e contribuiscono a normalizzare una retorica apertamente anti-israeliana che, nei fatti, finisce per coprire e giustificare organizzazioni collegate a Hamas e all’asse iraniano. Non si tratta di singole deviazioni personali, ma di un ecosistema politico che ha scelto di fare dell’anti-sionismo radicale una piattaforma, accettando come alleati soggetti che altrove vengono classificati come estremisti o terroristici.
La tua inchiesta ti è costata anche sul piano personale. Hai ricevuto minacce?
Sì. Quando il libro è uscito ho ricevuto molte minacce di morte. Durante conferenze e incontri serviva protezione. In alcuni momenti la pressione è salita: sono stata presa di mira pubblicamente e ho avuto protezione anche davanti a casa. Da allora sono più prudente: non annuncio mai dove sarò, non espongo i dettagli logistici.
Nel libro insisti molto sull’uso di un lessico «da Seconda guerra mondiale». Perché è così importante?
Perché è uno strumento potentissimo. «Genocidio», «nazisti», «campo di concentramento», «SS»: è un lessico che sposta tutto sul piano morale assoluto e rende impossibile qualunque sfumatura. Serve anche a un’operazione simbolica: nazificare gli ebrei e rovesciare la memoria storica. E funziona sui giovani: li aggancia con l’idea che anche i resistenti erano chiamati terroristi, quindi oggi il terrorismo verrebbe riscritto come resistenza.
C’è anche un punto sul lavoro giornalistico: isolamento, pressioni, solitudine. In Francia è uguale?
In Francia c’è stata una spaccatura, sì, ma molti media hanno sostenuto indagini come la mia, anche perché il Paese ha una memoria traumatica del terrorismo e il tema tocca nervi scoperti. Detto questo, una parte di giovani giornalisti tende a liquidare chi indaga su islamismo e reti radicali come «estrema destra». È una dinamica che ho vissuto: è rumorosa, pesa, ma non è l’unica voce.
Chiudi con un passaggio sull’Italia: perché, secondo te, è un nodo rilevante?
Perché alcune figure e correnti francesi hanno investito anche sull’Italia, costruendo reti, contatti, tour e sponde locali. Nel mio lavoro cito due nomi: Houria Bouteldja e Louisa Yousfi. Yousfi ha avuto una residenza a Roma, a Villa Medici, e da lì sono state costruite occasioni e connessioni con l’attivismo locale. Il punto, per me, è sempre lo stesso: non è una mobilitazione per la pace o per i palestinesi in senso pieno. È un dispositivo politico che spesso si struttura contro Israele e che cerca alleanze, canali, legittimazioni.
L'articolo L’islamismo radicale recluta l’Occidente con profili fake, Telegram e fondi illeciti proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0