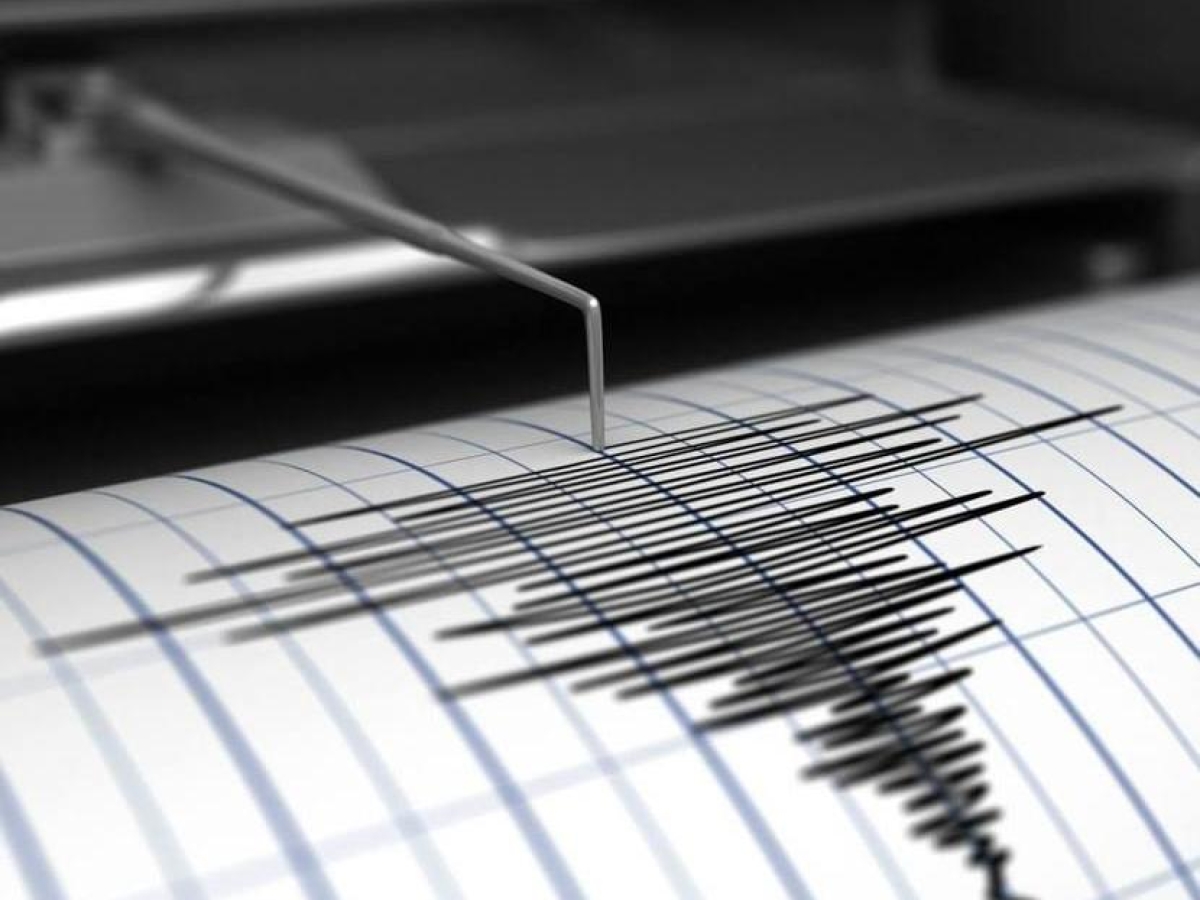Lo sdegno malato dei social e quello sano delle Franca Viola


L’Oxford Institute ha eletto la sua parola dell’anno: rage bait, che in italiano potremmo tradurre come “suscitare rabbia”. È l’algoritmo che si fa psicanalista tossico, il meccanismo subdolo e ormai scoperto, che ci spinge a urlare sui social per guadagnare click, visibilità e, in definitiva, denaro. In sostanza, un gigantesco call center emotivo dove tutti siamo chiamati a battere il pugno sulla scrivania e a insultare il prossimo.
Ed eccola, l’ultima utopia tradita: il sogno di Internet come luogo di ritrovo e di comprensione. La verità è che non stiamo sui social per il piacere di rivederci o per chiederci «Ciao, come stai?», ma per la risposta più seducente e più falsa possibile alla domanda: «Ciao, come sto?». E se qualcuno non ci ripete ogni giorno che siamo dalla parte della ragione, allora il mondo complotta contro di noi e la guerra ha inizio.
Siamo malati di un virus, e il virus è questa rabbia, che si alimenta di notizie false e messaggi subdoli. Parlo per esperienza, in una terra dove chi ti definisce un giornalista libero è lo stesso che poi ti disprezza e ti rende nemico appena tocchi i suoi interessi. Il linguaggio è esasperato, siamo in una guerra di tutti contro tutti. Non solo a parole: l’assalto alla redazione del quotidiano La Stampa, pochi giorni fa, è l’ultimo saggio di un clima che non rifiuta più neanche l’idea della violenza fisica per «dare una lezione» a chi non la pensa allo stesso modo. E la Sicilia, in questo, è un laboratorio di furia urbana. Come abbiamo raccontato su Linkiesta, a Palermo i turisti rischiano la randellata, gli assessori si ritrovano contusi per una banale lite in un bar, chiunque può essere aggredito, la movida si trasforma in letale sparatoria.
In questa società perennemente in guerra con il mondo, chi ci perde è proprio il sentimento più nobile: la rabbia sana. Quella che una volta era un sentimento luminoso, che dava coraggio agli uomini. Quella con cui, ancora ragazzi in Sicilia, di fronte all’orrore delle stragi di mafia, decidemmo di scendere in piazza, protestare, dire basta alla violenza mafiosa.
La soluzione, forse, è proprio quella che sembra essere la più anacronistica: recuperare la rabbia sana. Cinquantacinque anni fa, nell’aula di Sala d’Ercole, sede del parlamento regionale, la Sicilia visse un momento di questa sana furia collettiva. Era il 30 novembre del 1970 e all’ordine del giorno c’era il progetto di una mega-raffineria, sette milioni di tonnellate di greggio l’anno, da costruire tra San Vito Lo Capo e Custonaci, nel cuore del golfo di Macari. Erano promessi cinquanta miliardi di lire e trecento posti di lavoro, con l’obiettivo di trasformare quel tratto di costa in una nuova Taranto. I dossier parlavano di sviluppo, ma dietro c’era un fiume di denaro in tangenti per piegare la Sicilia agli interessi petroliferi.
Al centro di quella che fu la prima grande battaglia ambientalista vinta sull’isola furono giovani, volontari, donne, professori, pescatori (tantissimi), sindaci che fecero rete e affidarono le loro speranze a Vincenzo Occhipinti, assessore regionale allo Sviluppo economico, democristiano di Trapani. Fu lui a tessere un fronte composito fatto di comitati civici, scienziati, agricoltori. Un mosaico di competenze e passioni che introdusse un linguaggio nuovo, parlando di paesaggio come diritto e territorio come bene comune per la prima volta.
Il 30 novembre di quell’anno, Occhipinti entrò in aula e pronunciò una frase che divenne un manifesto: «Abbiamo un patrimonio inestimabile. Non possiamo accettare il marchio di un’infamia». Va detto per inciso, che, in quel singolare dibattito, spuntò fuori pure un documento che definiva i trapanesi «una popolazione con scarsa volontà di lavorare». Quella frase, più di qualsiasi perizia tecnica, fece scattare la dignità collettiva.
Democristiani, comunisti, missini e socialisti si ritrovarono per la prima, e forse ultima, volta dalla stessa parte. Il progetto sfumò con un voto unanime. Occhipinti pagò un prezzo politico altissimo, perdendo il seggio per aver messo in crisi «equilibri, affari e consorterie. Ma il seme era piantato: dieci anni dopo sarebbe arrivata la Riserva dello Zingaro, la prima area protetta dell’isola.
Oggi, quel tratto di costa è una delle cartoline più note del Mediterraneo. Macari sarebbe potuta diventare una cicatrice industriale. Invece, quel giorno, la sana rabbia dei siciliani dimostrò che la vera ricchezza non stava nel consumo di suolo, ma nella luce del mare. E che il futuro, a volte, dipende dal coraggio di dire no al futuro sbagliato.
Se la battaglia per la costa di San Vito Lo Capo fu un trionfo della rabbia collettiva e ambientalista, fu il «no» di una singola donna, pochi anni prima, a segnare uno spartiacque nella storia civile del Paese.
Nel 1966, l’Italia stava cambiando, ma a velocità diverse. Franca Viola, una ragazza di campagna di Alcamo, in provincia di Trapani, prossima ai diciotto anni, stava per dare un colpo tremendo alla società siciliana. Rapita il 26 dicembre 1965 da Filippo Melodia e dodici complici, la giovane fu segregata e subì una violenza che, per le consuetudini del tempo, e persino per il Codice Penale, poteva essere «cancellata» con un matrimonio.
Il matrimonio riparatore era la via d’uscita, una convenzione sociale e legale. Bastava un sì per farla tornare «donna onorata» e per far sì che l’uomo che l’aveva rapita e stuprata «estinguesse il reato». L’articolo 544 del Codice Rocco prevedeva che le nozze con la persona offesa estinguessero il reato di ratto o di violenza sessuale, e «se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali». La violenza, infatti, era considerata un «delitto contro la moralità pubblica» e non un reato contro la persona, tutelando il buon costume e non la libertà individuale della donna.
Eppure, dopo essere stata liberata dai carabinieri il 2 gennaio 1966, Franca, la cui famiglia aveva finto di accettare la «paciata» (la pace tra le famiglie) con i parenti di Melodia, si comportò in modo diverso. Denunciò. La sua frase divenne un manifesto di rabbia civile e dignità personale: «Io non sono proprietà di nessuno» e «l’onore lo perde chi le fa certe cose non chi le subisce. Non era mai successo che una donna «disonorata» rifiutasse di sposare il suo stupratore. La sua ribellione smascherò la doppia violenza delle nozze riparatrici.
Il processo, celebrato a Trapani nel dicembre 1966, divenne un caso nazionale. La difesa di Melodia, nipote di un mafioso locale, fu accanita, cercando di screditare la ragazza e sostenendo che fosse consenziente, puntando sul «ratto a scopo di matrimonio» anziché a «scopo di libidine». La linea difensiva si basava sull’idea che «Filippo avrà anche rapito Franca però è quasi sicuro che Franca ci stava».
Al termine del processo, Melodia fu condannato a undici anni per violenza carnale, ratto a scopo di matrimonio e altre imputazioni. La sentenza fu uno spartiacque e portò ad un cambiamento radicale: il matrimonio riparatore fu abolito dal Codice Penale italiano. La storia della giovane Franca fu una potente lezione di rabbia civile, una rabbia che non punta a distruggere, ma a ricostruire la dignità.
Sia nel «no» urlato da Franca Viola al Codice Rocco e alla sopraffazione maschile, sia nel «no» corale detto ai miliardi delle raffinerie, la Sicilia ha dimostrato che la rabbia – quella sana, non quella tossica dell’algoritmo – può essere motore di audacia e di cambiamento radicale. La vera rivoluzione, insomma, non si fa con un click sui social per rage bait, ma con il coraggio di chi si rifiuta di essere una tessera in un mosaico di ingiustizia e dice no, con coraggio, a un futuro sbagliato.
L'articolo Lo sdegno malato dei social e quello sano delle Franca Viola proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0





























































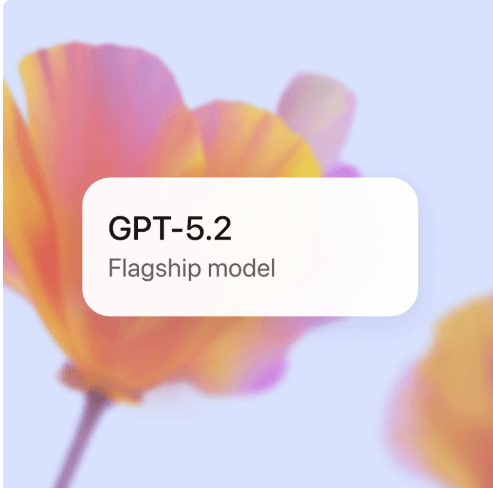
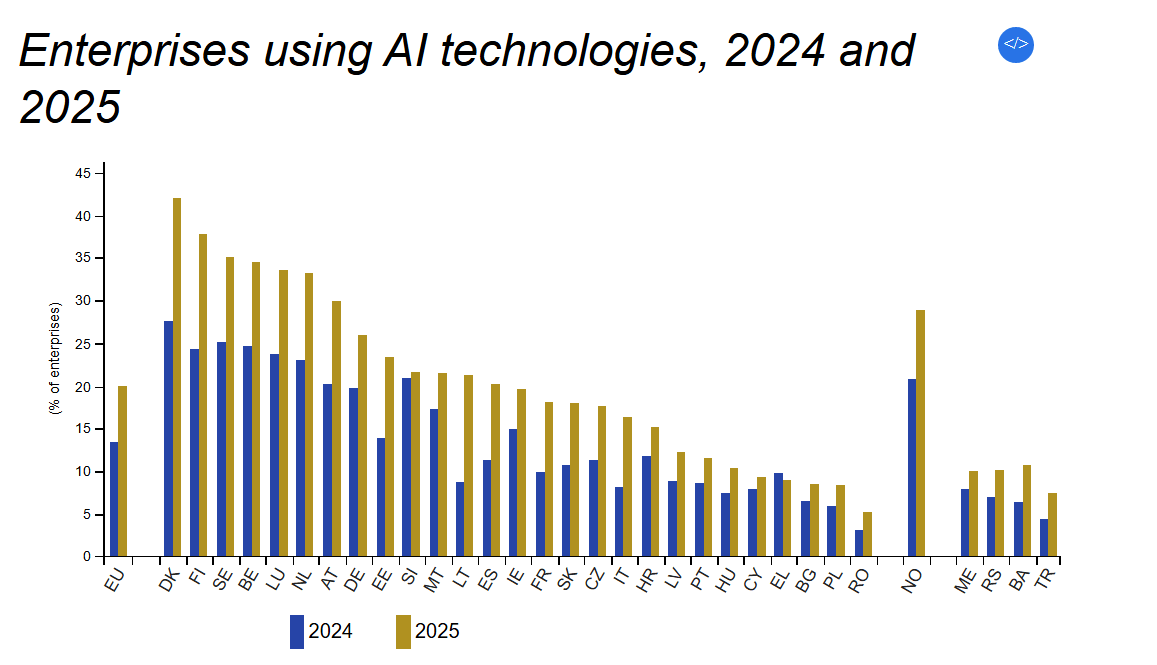

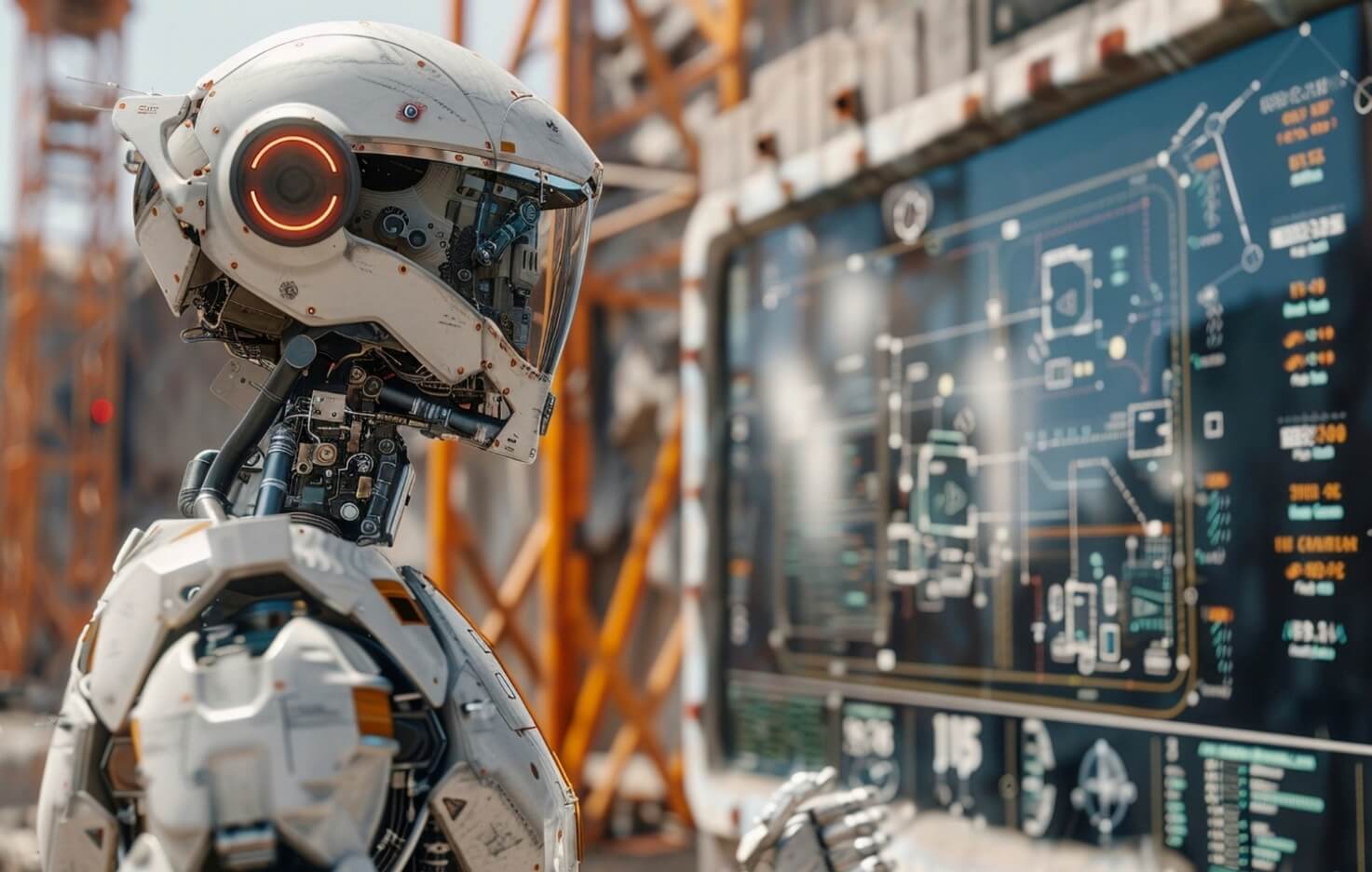




















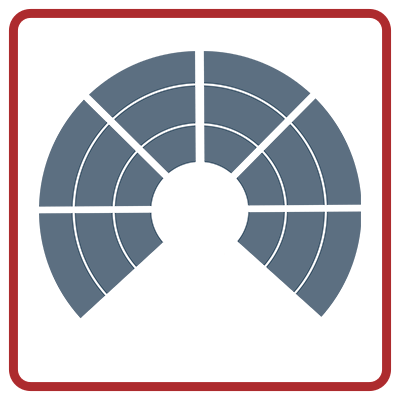


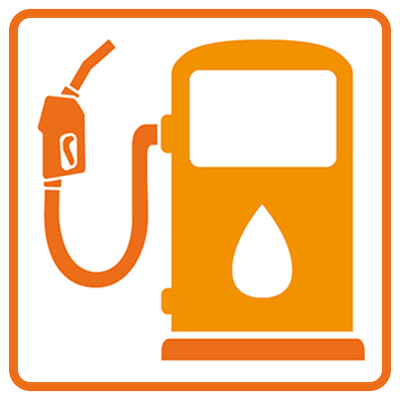






















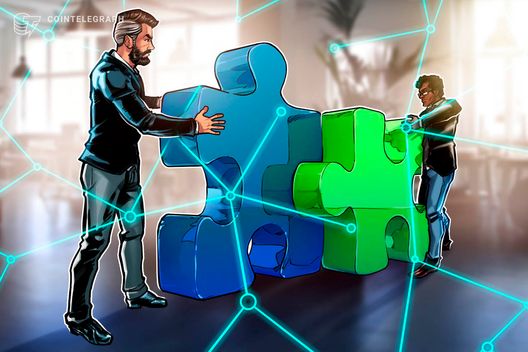
























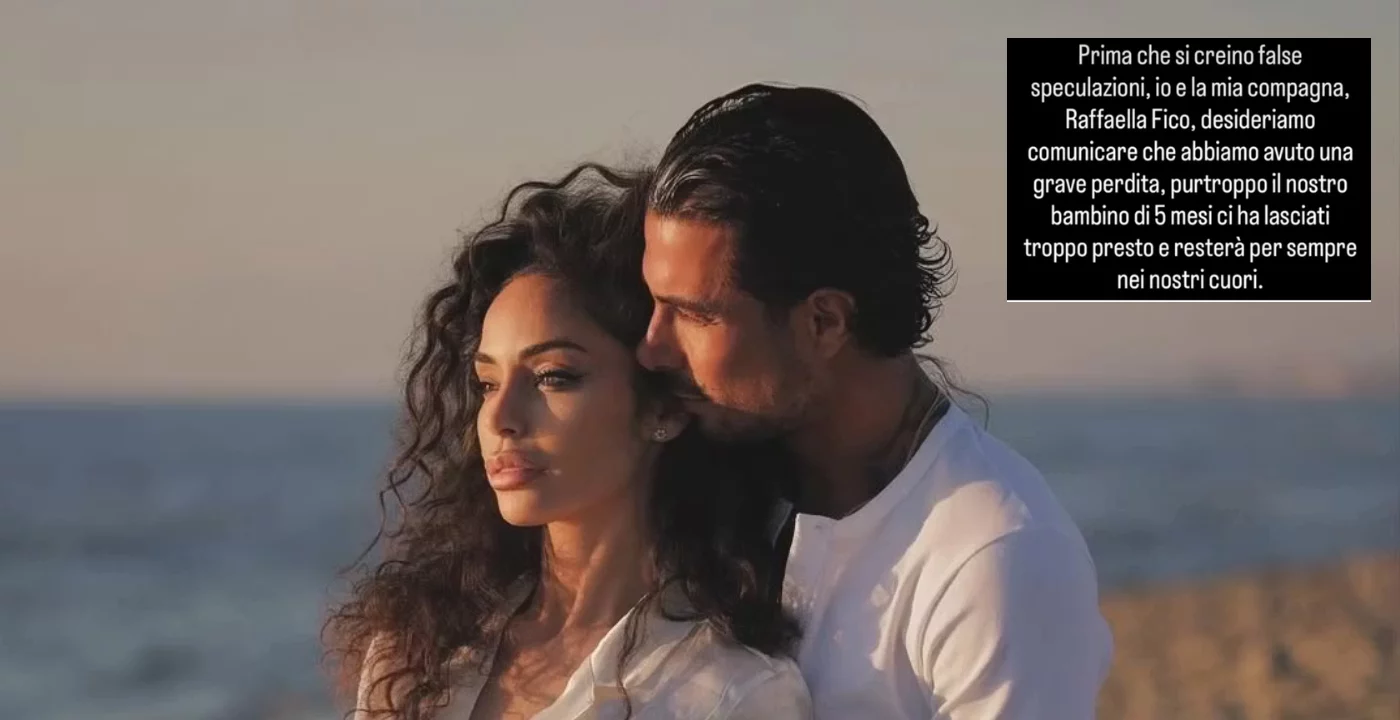































































-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)