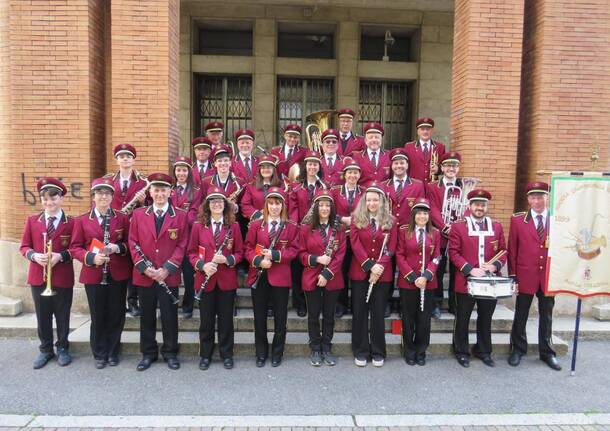Assolto dopo 15 anni rubati al 41 bis: il mio calvario

Era inizio giugno del 2010. A Brescia l’estate sembrava essere precipitata sulla città direttamente dall’inverno. Le scuole si apprestavano a chiudere, ma all’università era tempo di esami. Ci ero andato appena qualche giorno prima a ritirare il diploma di laurea in Giurisprudenza e ora sulla targhetta del citofono campeggiava la scritta “dottore” davanti al mio nome. Dietro quella semplice parola c’era molto di più del raggiungimento di un traguardo: c’erano tutti i sogni di un ragazzino che per tragedie più grandi di lui si era visto costretto a lasciare il liceo. C’era tutto il dolore dell’adolescenza e della giovinezza perdute. C’erano le tante rinunce che erano altrettanti furti di vita. C’era la caparbietà di un uomo che non si era voluto piegare ad un destino che altri pensavano di poter scrivere per lui. C’erano il riscatto, la speranza, l’orgoglio e la dignità conservata nonostante ogni violenza subita.
Era, per me, come le parole magiche che spezzano anche il più malefico degli incantesimi. Il mio era fatto di tutte le mie vecchie paure. Avevano, quelle paure, l’odore e i rumori del carcere. Si manifestavano spesso nel buio della notte. Imperlavano di sudore la mia fronte. Mi agitavano il cuore e impedivano agli occhi di chiudersi su bei pensieri per il domani. E da quel momento, finalmente, potevo liberarmene per lasciare spazio solo ai sogni e alle nuove speranze. Ma nessuna alba di speranza mi attendeva quel giorno di giugno 2010…Il dito premuto insistentemente dal poliziotto sul pulsante del campanello squarciò la notte e inghiottì in un abisso infernale l’illusione di ogni sogno: il risveglio non aveva il calore di un abbraccio, ma il freddo della morsa metallica delle manette strette intorno ai miei polsi. La mia vita non trovava vigore nel profumo di un caffè mattutino, ma agonizzava nell’acre odore del mio sangue versato sullo squallido pavimento di una cella.
Prima di accompagnarmi nel vecchio carcere bresciano di Canton Mombello, mi consegnarono il provvedimento di custodia cautelare: una montagna di fascicoli, migliaia di pagine in un giuridichese capace di svilire anche il più fiducioso e preparato dei lettori. Ed io di fiducia non ne avevo ormai più. La cella era spoglia: una branda con un materasso di spugna consunta dal tempo e dal sudore delle vite passate di lì, uno sgabello malfermo e un piccolo tavolino occupato quasi interamente da quella montagna di carte. Non le ho degnate neanche di uno sguardo. Steso sulla branda, gli occhi fissi sul soffitto scrostato, la sua ombra pesava più della mia vita: quella passata era ormai annientata, quella futura puzzava di morte. La fredda lama di un rasoio bic gettò una sinistra luce nei miei pensieri. Un attimo, e si fece strada sulla mia carne, affondò nella mia gola, scomparve nella pozza di sangue sgorgata dalle mie vene. Il caso volle che sopravvivessi ed io ho raccolto l’ultimo anelito di vita rimasto, mi sono sollevato dal cumulo di macerie lasciato dalla devastazione di quella notte e ho attraversato l’inferno, affrontato i demoni, lottato con la forza della verità dei fatti contrapposta agli artifici dialettici sostanziati di venefica menzogna.
In stretta sinergia con il mio difensore di Brescia, ho spicconato e scalato pagina dopo pagina la montagna del teorema accusatorio che mi voleva capo di un’associazione mafiosa. Avevamo appena dieci giorni per presentare il riesame e non potevamo trascurare nessun elemento. Il giorno dell’udienza, l’avvocato partì alla volta di Reggio Calabria. Io, invece, fui impacchettato nella soffocante celletta di un furgone e spedito nel carcere di Badu e Carros, anticamera del 41 bis che mi venne applicato a qualche settimana di distanza. L’udienza al Tribunale del riesame si concluse con un rigetto e ci vollero poco più di otto mesi per la discussione del ricorso in Cassazione. A parlare per primo in quella sede fu il PG e la sua richiesta sorprese tutti: accoglimento del ricorso e annullamento senza rinvio del provvedimento di custodia cautelare per assoluta mancanza di gravi indizi di colpevolezza.
E così, in una fredda sera di metà febbraio, lasciai la cella del 41 bis di Rebibbia per far ritorno a Brescia. Tutto finito? Certo non per l’Ufficio di Procura di Reggio Calabria, che a pochi giorni dal Natale 2011, riproponendo quell’identico quadro indiziario censurato dalla Cassazione, avrebbe ottenuto dal GIP l’emissione di una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere. Cinque anni di dura galera al 41 bis di una gelida Cuneo accompagnarono le più importanti fasi del processo. Il GUP, un giudice civile applicato per l’occasione alla funzione penale, supino al teorema accusatorio, trasformò in sentenza la “velina” con la richiesta di condanna del PM: trent’anni di reclusione, ridotti a venti per la scelta del rito abbreviato. Andò leggermente meglio nel giudizio d’appello: caduta l’accusa di essere capo dell’associazione, la condanna si ridusse a dodici anni per il ruolo di partecipe. Ma la Cassazione, come già nel 2011, ribadì l’assenza di un grave quadro indiziario, annullò la sentenza di condanna ed ordinò un nuovo giudizio d’Appello, che avrei dovuto attendere sempre in stato di detenzione al 41 bis.
L’udienza si celebrò nel marzo del 2016. Il giudice del rinvio confermò la condanna e ridusse la pena a poco più di quattro anni. Di anni in carcere ne avevo intanto passati quasi cinque e venni dunque scarcerato. Ovviamente i miei difensori impugnarono la sentenza di condanna e la Cassazione pronunciò il terzo annullamento. Nuovo giudizio nel novembre del 2021, nuova condanna, ennesimo annullamento della Cassazione nella primavera del 2023. Nei giorni scorsi, dopo ben 15 anni dalla notte del mio arresto a Brescia, la celebrazione del quarto giudizio d’appello e, finalmente, la piena assoluzione con la formula “per non aver commesso il fatto”.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0




































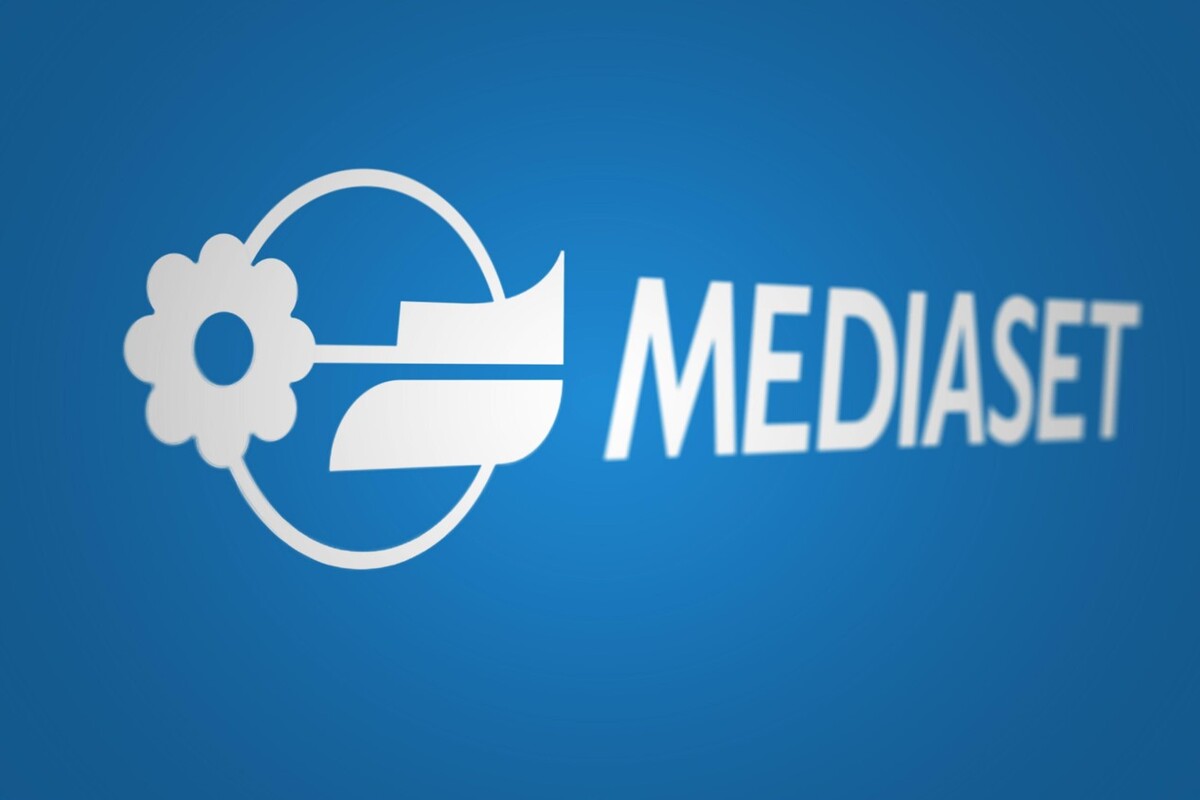




















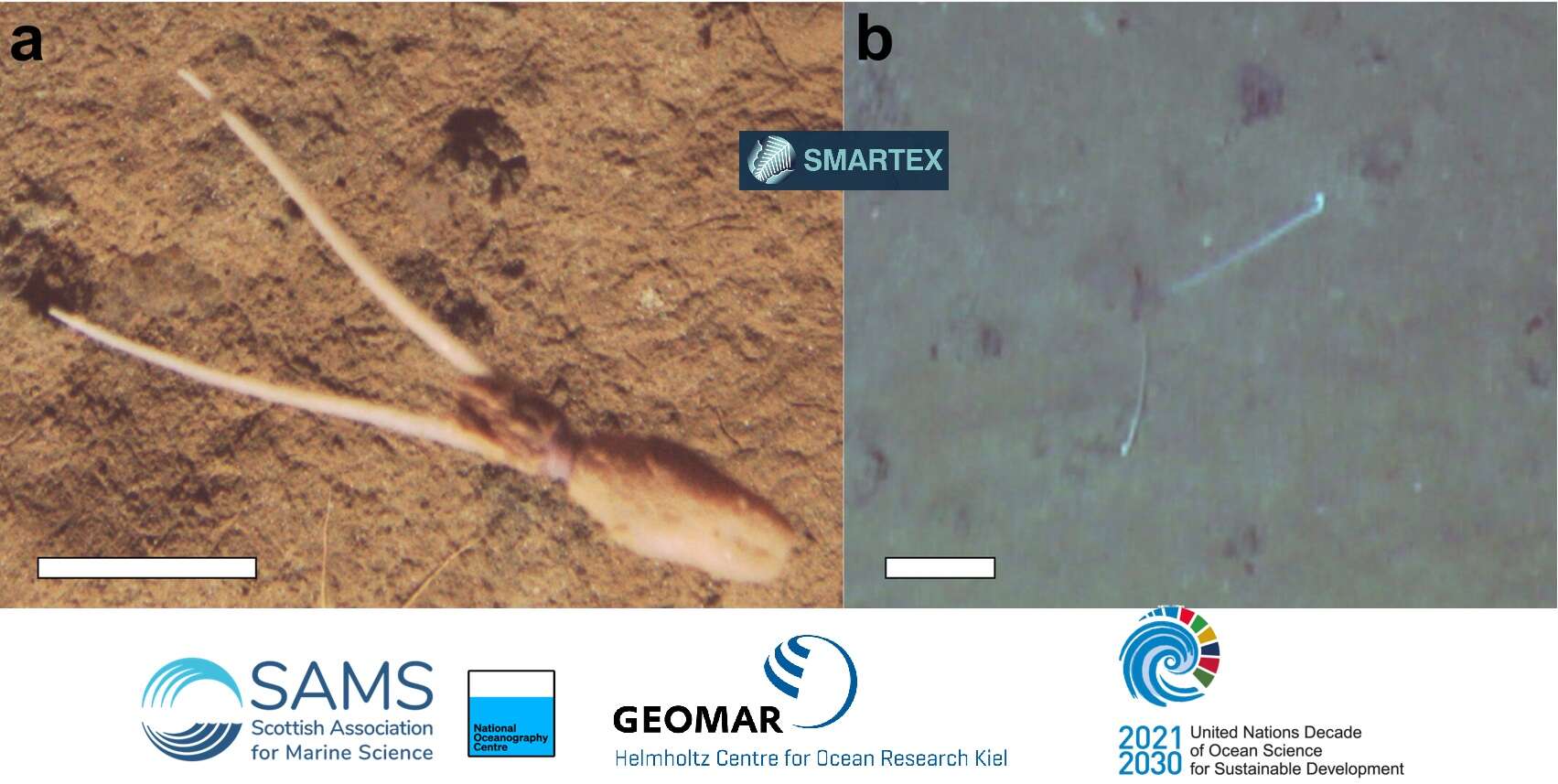







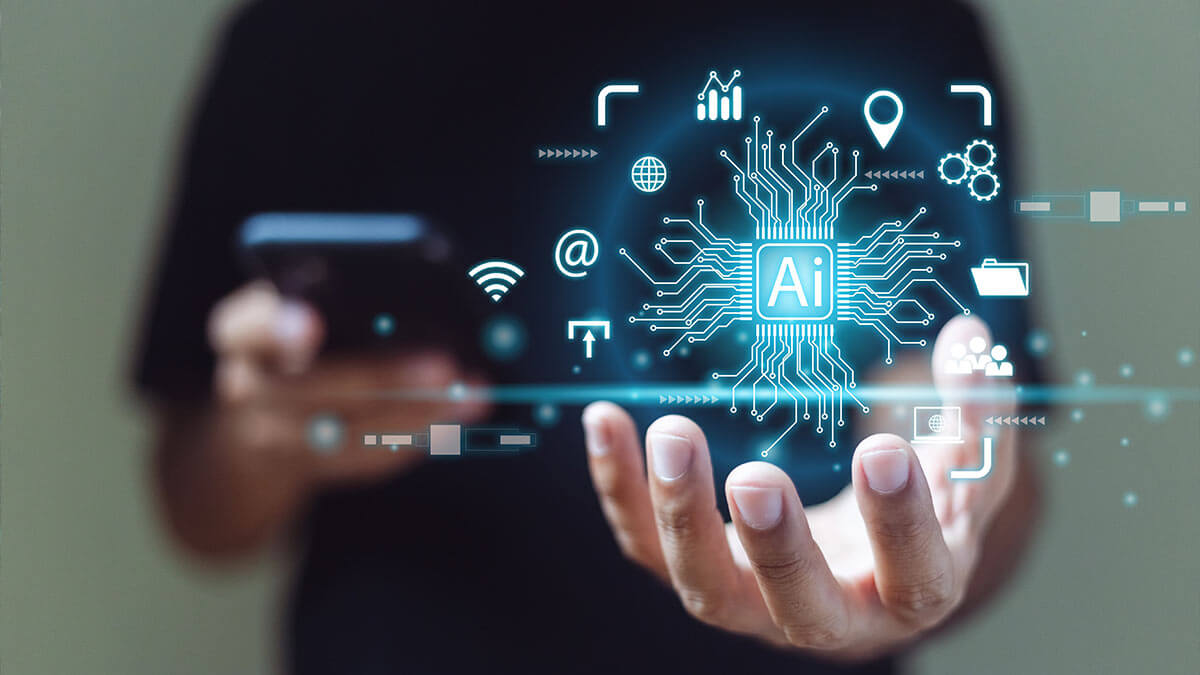





















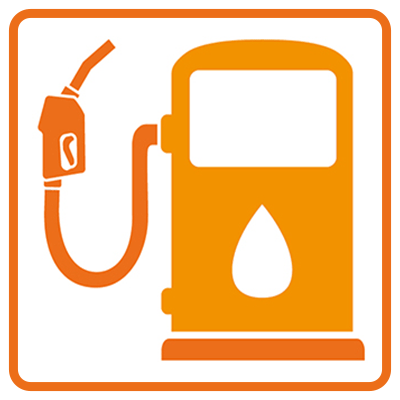

































































































_(50)-1765960548246.jpg--tamponamento_tra_due_auto_sulla_provinciale_che_collega_castellamonte_a_cuorgne__grande_spavento_e_lievi_contusioni_per_i_conducenti.jpg?1765960548409#)






-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)