ll fast fashion teme la spada di Damocle dei dazi: rincari o una nuova supply chain?

Temporaneamente congelati – tra un turbinio di richieste di negoziati, minacce di ritorsioni e il tonfo delle Borse – i dazi di Trump spaventano trasversalmente tutto il mondo della moda, dal lusso al fast fashion. Quest’ultimo, in particolar modo, ha visibilmente sussultato di fronte allo spettro di un regime tariffario che rischierebbe, al termine dei 90 giorni di stand-by che scatteranno il 9 luglio ormai alle porte, di sparigliare le carte di un’intera filiera che dei prezzi contenuti e di una supply chain geograficamente strategica ha fatto il proprio marchio di fabbrica.
“Se i dazi verranno effettivamente reintrodotti – ha spiegato a Pambianco Magazine Claudia Lotti, senior managing director di Fti Consulting – anche il settore del fast fashion ne risentirà, coinvolgendo sia i grandi gruppi occidentali sia quelli asiatici. Le aziende si trovano di fronte a due possibili risposte: aumentare i prezzi per il consumatore finale o riorganizzare la propria supply chain per aggirare i nuovi ostacoli commerciali”. Due vie che in realtà non si escludono a vicenda e rischiano, invece, di coesistere. In qualsiasi scenario, ad ogni modo, “i costi tenderanno a salire, almeno nel breve periodo, con una probabile ricaduta sui prezzi finali”, mette in guarda l’analista.
La conferma del trend ascendente che sta già interessando i prezzi del fast fashion è arrivata innanzitutto dai colossi asiatici, Shein e Temu. I due player della moda – e non solo – a basso costo hanno infatti annunciato come dal 25 aprile, in seguito ai “recenti cambiamenti di regole e tariffe commerciali globali”, le loro spese operative siano aumentate al punto da giustificare degli “aggiustamenti di prezzo” per la clientela americana. Intanto, anche la Cina è stata, in seconda battuta, inclusa nella parentesi di distensione che ha messo i dazi in pausa, con un conseguente abbassamento temporaneo delle tariffe per i beni importati dall’ex Celeste Impero dal 145% al 30%; ma la mossa di Shein e Temu arriva primariamente in risposta all’eliminazione della ‘esenzione de minimis’ sulle spedizioni dalla Cina verso gli Stati Uniti per un valore inferiore agli 800 dollari, manovra diventata operativa dal 2 maggio. Una stangata non da poco per i due dragoni, che avevano finora beneficiato di tale escamotage e su cui ora pesa una tariffa del 54% (prima addirittura del 120% e in seguito ridotta all’indomani della tregua sul fronte dazi) con una tariffa fissa di 100 dollari. Se l’ultra fast fashion asiatico starebbe già pagando pegno, lo scenario non appare confortante neanche per la moda low cost occidentale. È stato H&M, i cui dati relativi al primo trimestre 2025 sono usciti alla fine di marzo, il primo a esprimersi sul tema: per il direttore finanziario Adam Karlsson, il player potrebbe infatti dover aumentare i prezzi negli Usa proprio per mitigare l’impatto delle nuove tariffe. Ma, sebbene la più immediata, quella dei rincari non è l’unica via percorribile.
Al bivio tra rItocchi e rimodellamento della supply chain
Attualmente, la strada alternativa di un ripensamento, geografico e strategico della propria supply chain appare complessa, anche in funzione dell’incertezza sulla politica americana, con la possibilità che determinate misure economiche vengano in un secondo momento cancellate o fortemente ridimensionate. Basti pensare alla sentenza dell’Us Court of International Trade (tribunale federale statunitense che si occupa di controversie riguardanti il commercio internazionale, ndr) che ha dichiarato “illegali” molte delle misure tariffarie in arrivo, ma già impugnata dall’amministrazione Trump. “I margini di manovra sono limitati – conferma ancora Lotti –. Le competenze produttive, l’accesso alle materie prime e il basso costo del lavoro sono concentrati in specifiche aree. Riorientare la produzione richiede tempo e risorse, e spesso comporta un calo dell’efficienza. Per questo è più probabile che i brand decidano di spostare solo una parte marginale della produzione o che accettino una temporanea compressione dei margini”.
Lavorare sul prezzo, dunque, a discapito del consumatore finale o della propria marginalità in prima battuta, sembra essere la via più facilmente percorribile. Di questo avviso, infatti, sembra essere anche la spagnola Mango, che starebbe “prendendo le misure con i dazi imposti dall’amministrazione Trump sulle importazioni dalla Cina” – aveva affermato il CEO Toni Ruiz in un’intervista congiunta a Reuters e il quotidiano francese Les Echos – riconsiderando la tipologia di offerta proposta oltreoceano senza, per il momento, prevedere impatti sul prezzo finale. Del resto, il player aveva già pianificato un potenziamento della propria presenza negli Usa, suo quinto mercato, attraverso un upgrade della label verso un posizionamento premium. Si tratta, comunque, di “una strategia ambiziosa – osserva Lotti – soprattutto in un contesto di rallentamento economico e incertezza nei mercati del fashion e del lusso”. Aggiungendo: “È plausibile che l’azienda possa rivedere il ritmo di espansione o adottare un approccio più selettivo. Il riposizionamento verso una fascia di prezzo più alta richiede coerenza tra comunicazione, pricing e qualità percepita: un processo complesso che necessita di tempo”.
Sebbene resti ancora da capire, dunque, come si evolverà la strategia dei dazi messa in atto dagli Usa di Trump, al momento, guardando ai player del fast fashion, è difficile immaginare uno spostamento sensibile nelle tratte produttive del comparto, che sono lunghe, frammentate e geograficamente incentrate proprio su Cina e Sud-est asiatico, per ragioni economiche e politiche. Anche la società di consulenza Bernstein, in una nota redatta al riguardo, ha evidenziato come “sebbene l’imminente sofferenza dei dazi doganali diffusi renderà le catene di approvvigionamento globali più costose, gli ingenti costi e le interruzioni richieste per la produzione nearshore non valgono ancora la pena di essere implementati su larga scala”.
Questo non sta impedendo, tuttavia, agli attori del panorama del fast fashion di apportare alla mappa della propria produzione delle deviazioni o modifiche che consentano loro di schivare i colpi più prevedibili della strategia trumpiana, pur nell’inevitabilità di una supply chain che orienta il proprio baricentro a Oriente, tra Sud-est asiatico e Cina. Shein, ancora una volta, ha compiuto una prima mossa in questa direzione, aprendo un proprio magazzino in Vietnam volto a limitare la propria esposizione, sul fronte logistico, alle ripercussioni delle tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Repubblica Popolare. Ma la partita resta aperta e le evoluzioni possibili del risiko delle supply chain ancora in divenire.
Il fast fashion ci pensa, lo sportswear è già sul piede di guerra
E mentre il fast fashion si dimostra più attendista, soprattutto sul fronte della supply chain, l’universo dello sportswear sembra avere già preso una posizione più netta. Il primo a levare il proprio appello ufficiale è stato il mondo delle calzature che, all’indomani dell’infausto annuncio sui dazi, si è rivolto alla Casa Bianca attraverso la Footwear Distributors and Retailers of America (Fdra), con una lettera firmata da 76 brand, tra cui Nike, Adidas, Skechers e Under Armour.
A spaventare i colossi di abbigliamento sportivo e sneakers non sono tanto e non solo le sorti della Cina ma soprattutto quelle di Vietnam e Cambogia. Il primo, in particolare, è cruciale nella supply chain di Nike, il quale produce lì il 50% delle sue calzature e il 28% del suo abbigliamento, stando ai dati del 2024. La sua rivale Adidas è lievemente meno esposta alle ripercussioni sul Vietnam ma pur sempre interessata, con il 39% e il 18% rispettivamente di calzature e abbigliamento prodotti nel Paese. Non meno preoccupante, in particolare per il marchio dello swoosh, il tema della marginalità, che rischia di subire un duro colpo nel pieno del suo processo di rilancio in seguito al declino delle vendite riscontrato nel recente periodo. Ma Nike sembra determinata a non farsi trovare impreparata: è già operativa, infatti, la sua “pianificazione stagionale”, che ha visto i prezzi di alcuni dei suoi prodotti distribuiti negli Stati Uniti aumentare in vista del temutissimo 9 luglio. Una data non esplicitamente menzionata dal colosso sportivo ma difficile da escludere dall’equazione che ha portato al rialzo i prezzi d’oltreoceano su tutte le categorie merceologiche, dalle scarpe all’abbigliamento, al di sopra dei 100 dollari (circa 88 euro).
Invariati solo, a fronte dell’avvicinarsi della stagione del rientro a scuola, i prezzi dei prodotti per bambini, ma anche in generale gli articoli che costino meno di 100 dollari, le scarpe da ginnastica Air Force 1 e gli articoli Jordan che non siano scarpe. Una mossa che non stupisce, anche perché preceduta dall’intenzione dichiarata dalla competitor Adidas di rincarare il prezzo delle sue sneakers più popolari, ‘Gazelle’ e ‘Samba’, proprio in vista dei dazi. Prossima a intraprendere la stessa via è Under Armour che – ha spiegato il CFO David Bergman in occasione degli ultimi risultati finanziari – ha allo studio ora aumenti mirati dei prezzi e una diversificazione della sua catena di approvvigionamento nei Paesi che si trovano ad affrontare imposte relativamente inferiori sotto l’amministrazione Trump. Attualmente l’azienda si rifornisce di circa il 30% del suo volume complessivo di merci dal Vietnam, circa il 20% dalla Giordania e del 15% dall’Indonesia. Anche il colosso francese specializzato in abbigliamento e attrezzature sportive Decathlon sta rivedendo la propria mappa produttiva alla luce dello spettro di Trump. Il player, che già concentra circa il 6% della sua supply chain in India, con un volume di produzione di 100 milioni di articoli, ora prevede di salire a un peso del 15%, nell’ambito di un possibile rinnovo dell’accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e il Paese asiatico.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0





















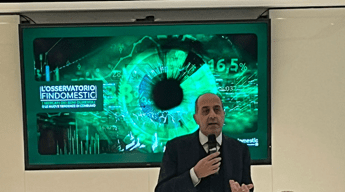








































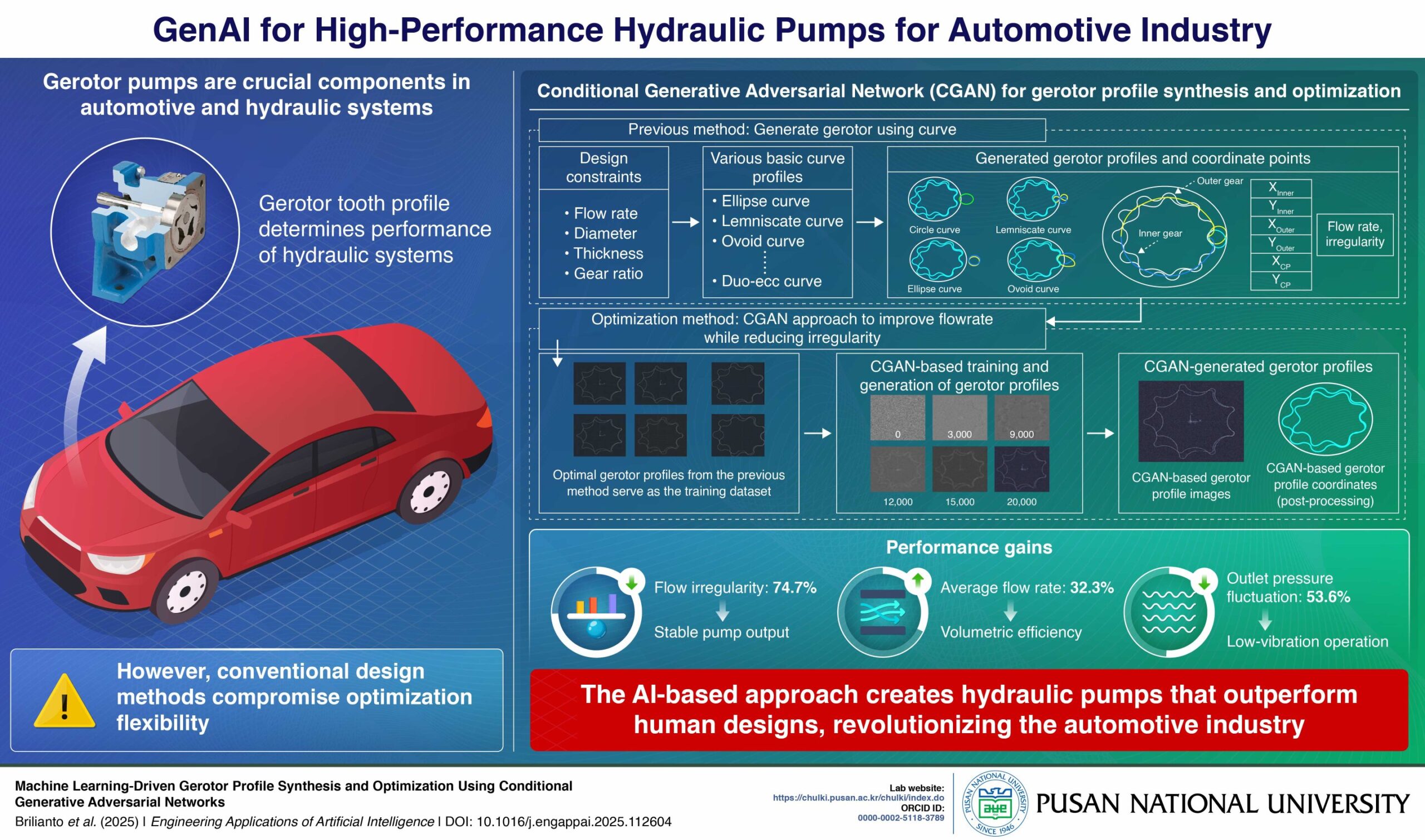


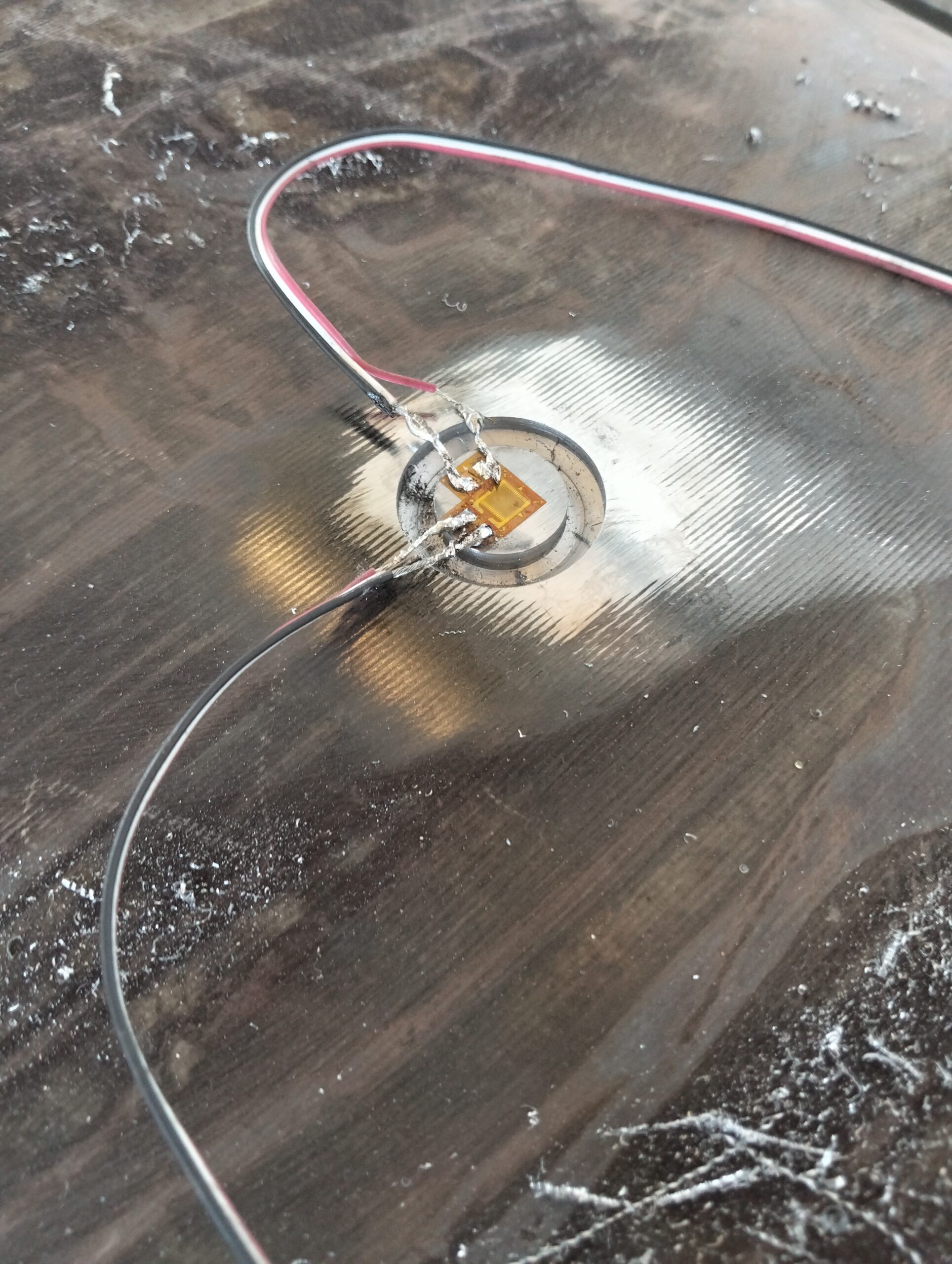
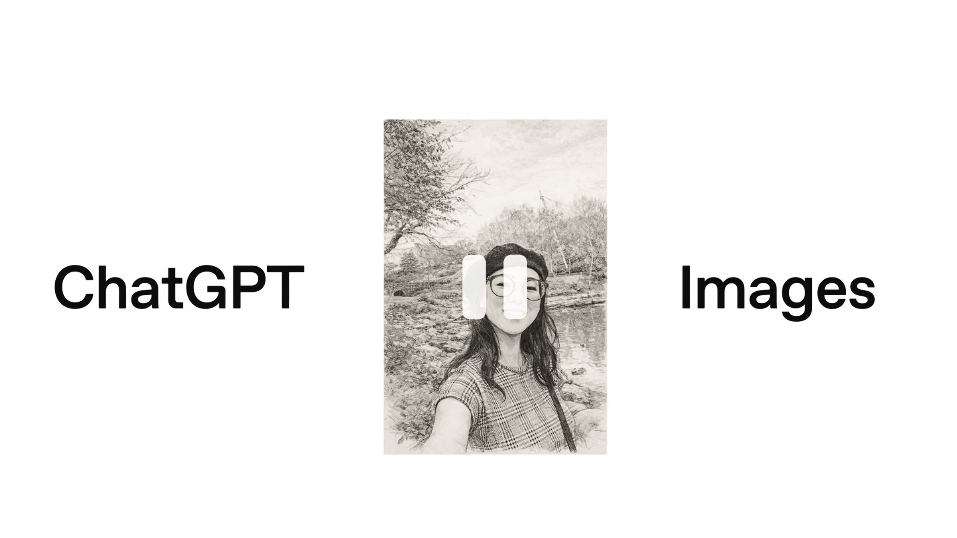


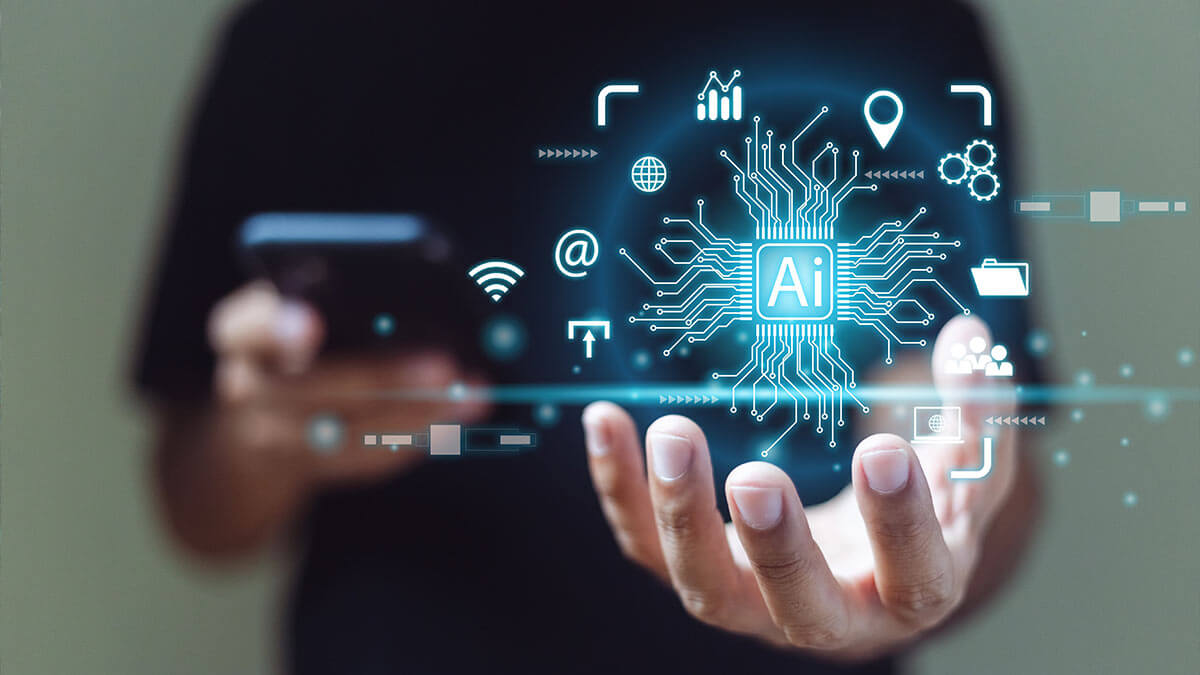





















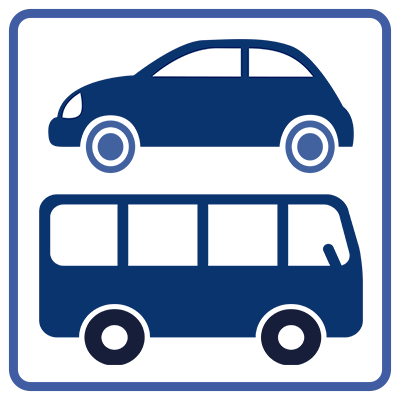
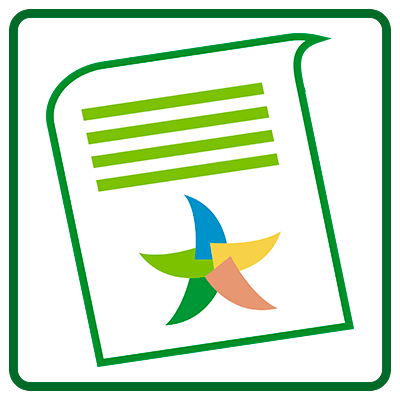
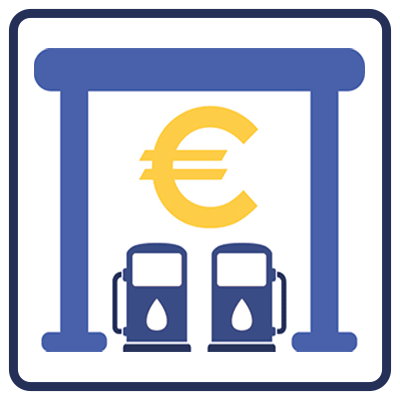



























































































_(54)-1765966536088.jpg--polenta__spezzatino_e_solidarieta__a_cossano_belbo__alla_cena_della_protezione_civile__consegnata_una_nuova_borsa_medica.jpg?1765966536232#)









-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)





















































