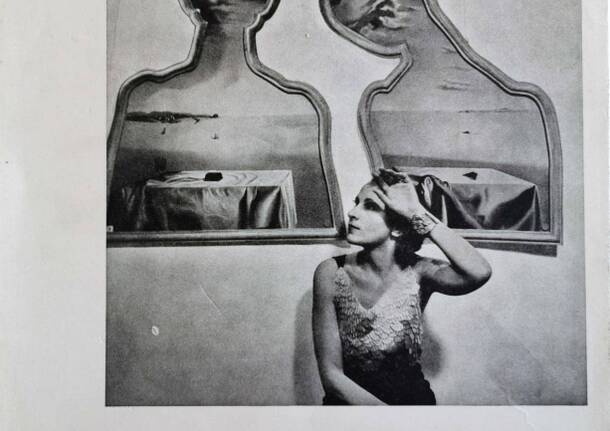Dietro le celle c’è l’ipocrisia dello Stato, il carcere secondo Sciacia: “La più terribile, inumana e inutile delle pene”

Infine, in piazza Vetra, fu costruita una baltresca, e Caterina, “carnosa ma di ciera diabolica”, venne torturata con tenaglie arroventate, strangolata, e i suoi resti gettati nel fuoco. È la giustizia dei vendicativi pensieri – che coarta a confessioni insincere e anela a premi mortiferi – della quale Leonardo da Racalmuto, perché la Sicilia è metafora di un intero paese, si occupò tutta la vita. Di questa ingiustizia di regime, il carcere è la massima espressione, l’acme.
Per dirla con lo Sciascia de La corda pazza: “la più terribile, la più inumana delle pene; e nello stesso tempo la più inutile”. La galera non è mai un semplice edificio con mura e sbarre. È un simbolo, un prisma attraverso cui osservare il rapporto tra verità, potere e giustizia. Lo aveva compreso tanti anni fa Marco Pannella: guai a distrarsi un solo secondo dal carcere, perché la giustizia è la più grande questione sociale del nostro tempo! Dietro le celle sciasciane non ci sono soltanto detenuti, ma le ombre della società, le ipocrisie dello Stato, i silenzi della coscienza: ciò che Foucault definiva “lo splendore dei supplizi”. Già nelle Favole della dittatura (1950), la sua prima raccolta, la prigione si presentava in forma allegorica. Non esistono sbarre visibili, ma il mutismo imposto dal potere: “E chi non si lasciava convincere / lo convincevano a non parlare più”. Il carcere è quindi una condizione interiore: la voce costretta al silenzio, il dissenso annullato, la cella invisibile che i regimi costruiscono intorno all’anima degli uomini.
Con Il giorno della civetta, il carcere assurge persino a destino sociale. Gli uomini di bassa manovalanza possono finire dietro le sbarre, ma i veri registi del potere restano immuni. La prigione diventa in fondo il luogo dei poveri e dei deboli, degli inermi e dei derelitti, mentre i potenti non vi entrano quasi mai. È una giustizia di classe, che punisce chi non ha protezione e assolve chi gode di complicità e silenzi.
Nel Contesto, romanzo che tanto scandalizzò la magistratura del tempo, la cella si trasforma in un ingranaggio del grande labirinto giudiziario. Non è la verità a condurre alla condanna, ma la convenienza politica. Le prigioni diventano stanze di un edificio paradossale, dove la legge non cerca la giustizia ma preserva gli equilibri del potere. La detenzione appare come una recita, una scenografia necessaria a confermare l’autorità dello Stato, mentre la sostanza della giustizia resta corrotta e inaccessibile.
Con Todo modo, il convento in cui i potenti si rinchiudono per gli esercizi spirituali si trasforma in una sorta di carcere dorato, una clausura in cui il potere si autoalimenta isolandosi dal mondo esterno. Non ci sono sbarre, ma c’è la segregazione di un’élite che si imprigiona da sé, pur credendo di detenere la libertà. Il tema della prigionia diventa centrale anche in L’affaire Moro. Moro è prigioniero delle Brigate Rosse, ma anche dello Stato che sceglie di non trattare. La sua cella diventa simbolo di una doppia cattività: quella fisica, imposta dai brigatisti, e quella politica, determinata dall’intransigenza delle istituzioni. In quelle lettere scritte dal carcere del popolo, Sciascia vede la voce di un uomo che dialoga con il Paese, e al tempo stesso la sordità di uno Stato violento e incapace di ascoltare.
Il carcere riaffiora ancora in Nero su nero, dove egli osserva la realtà concreta delle prigioni siciliane e italiane. Ne descrive il degrado, il sovraffollamento, la condizione dei reclusi come specchio dell’abbandono civile. La cella diventa qui non solo simbolo politico, ma misura di civiltà: da come uno Stato tratta i suoi detenuti si comprende il grado della sua umanità. Con Cruciverba, Sciascia arriva ad affermare che il carcere è la vera cartina di tornasole della democrazia. Vi coglie non solo la pena inflitta, ma l’intero assetto sociale che la produce. La cella non è mai uguale per tutti: pesa di più sul povero, quasi nulla sul potente. Ancora una volta, il carcere diventa emblema della disparità, specchio di una società che usa la legge non come strumento di equità, ma come arma selettiva.
Ma il carcere, per Sciascia, non è soltanto istituzione penale. È anche destino intellettuale. Dire la verità significa spesso chiudersi in una cella invisibile, fatta di solitudine e sospetto: “Dire la verità è utile a chi la dice e dannoso a chi l’ascolta”. È la condizione dell’intellettuale che rifiuta il compromesso e resta solo, separato, quasi imprigionato nella sua stessa coerenza. Così, dalle Favole della dittatura a Cruciverba, passando per Il giorno della civetta, Il contesto, Todo modo, L’affaire Moro e Nero su nero, il tema del carcere percorre tutta l’opera sciasciana, con buona pace di coloro che hanno voluto oscurare, ostracizzare o dimenticare questo aspetto.
In questi anni, in tanti hanno esercitato la memoria di Sciascia intorno ai temi della giustizia e del processo. Taluni lo hanno elevato perfino a vate della “certezza della pena”. Altri hanno ripreso lo scrittore dei “professionisti dell’antimafia”. Oggi forse sarebbe il caso di meditare su cosa avrebbe scritto di questo carcere, impastato di sordi, storpi, ciechi, diavoli innocenti, irriducibili disgraziati. A futura memoria. A noi di Nessuno tocchi Caino – che pannellianamente abbiamo aderito al suo programma – piace pensare che egli continui, nella compresenza capitiniana dei morti e dei vivi, ad andare alla ricerca di qualcosa di meglio: di meglio della violenza, della sopraffazione, dell’ossessione spasmodica di giudicare a ogni costo, della ricerca diabolica di una verità che non è di questa terra. Di meglio di un mondo di gabbie nelle quali sono rinchiusi gli uomini. Di meglio del diritto penale.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0











































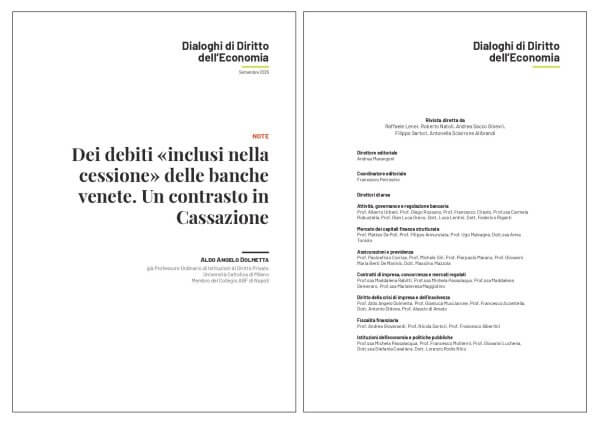
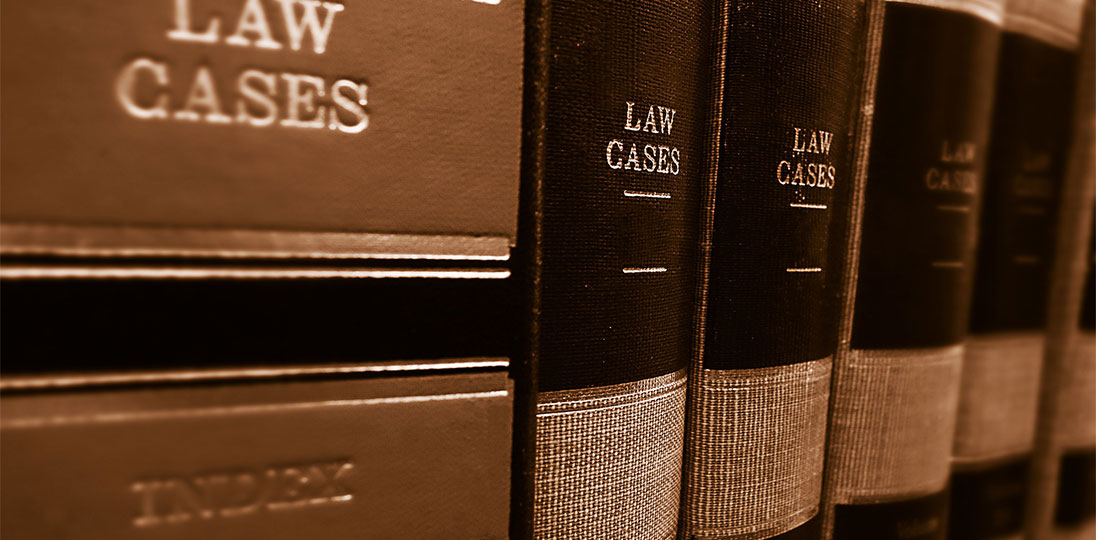



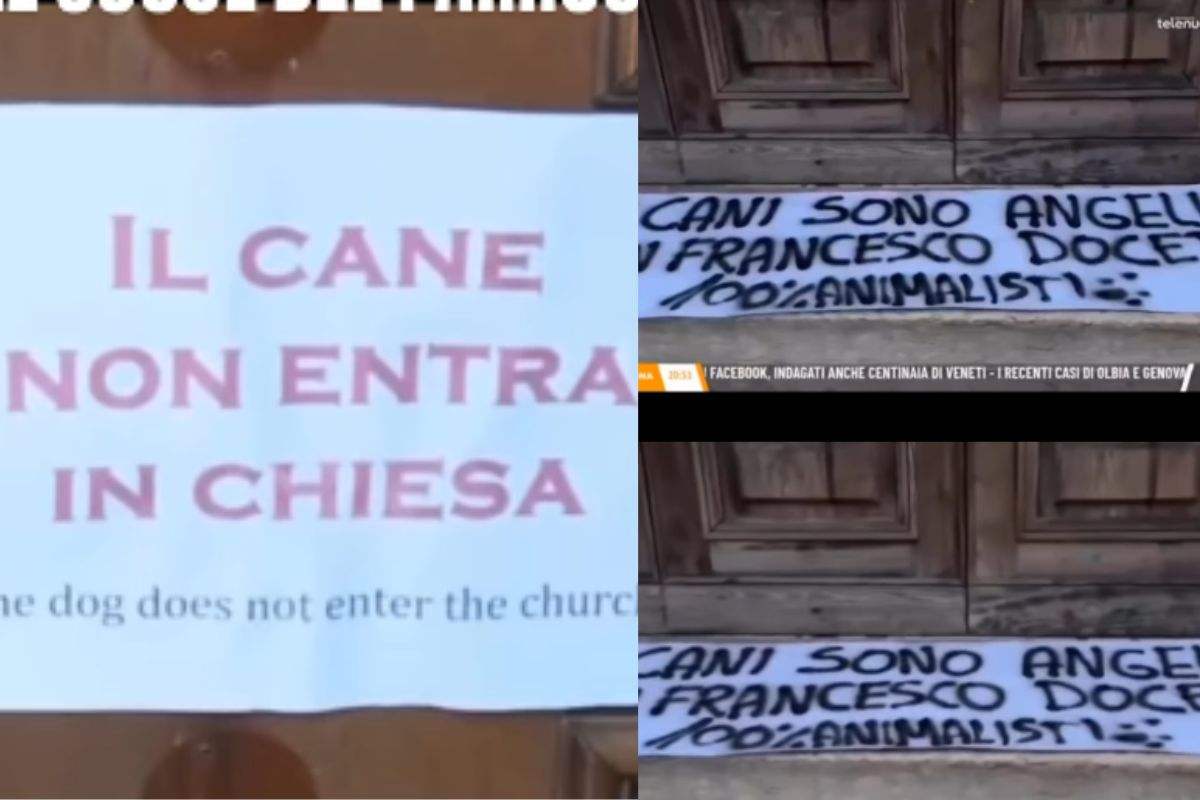





































/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/09/wp_drafter_181208.jpg)
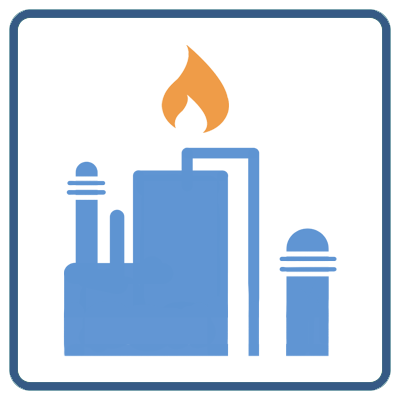


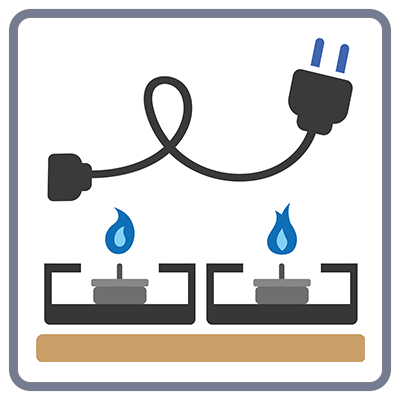


























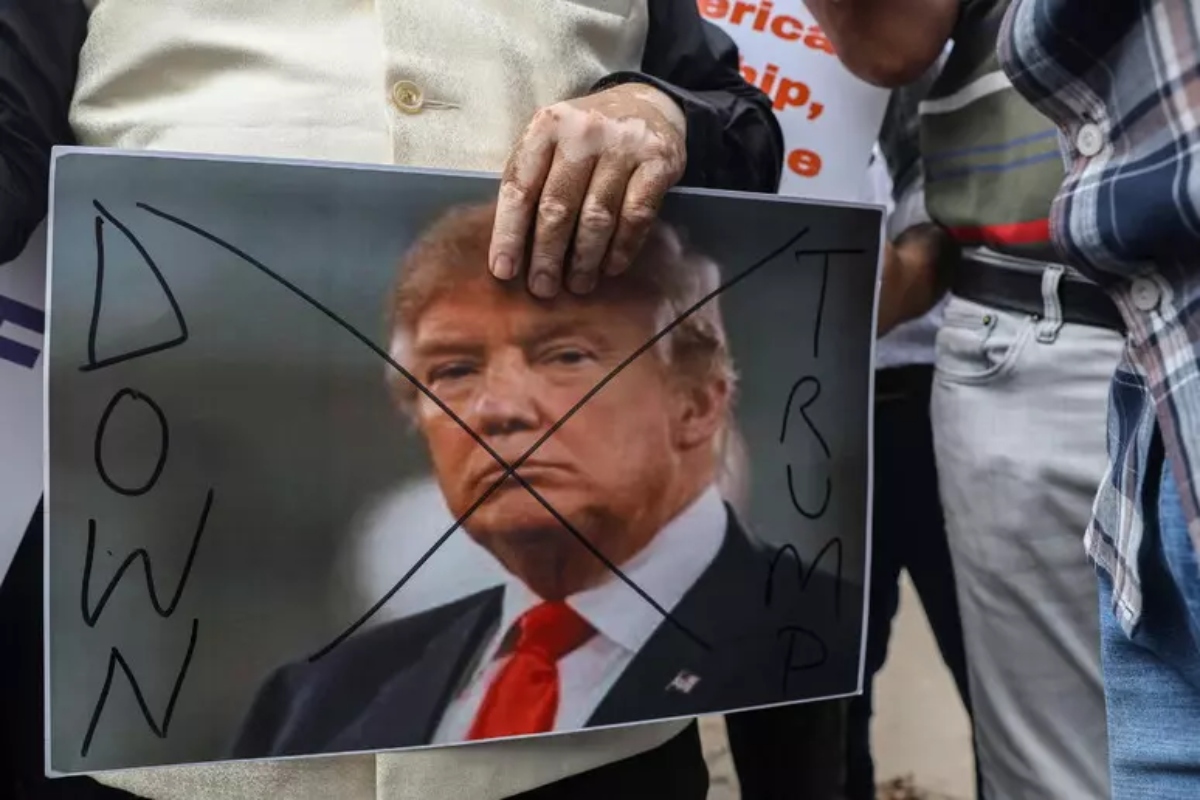





















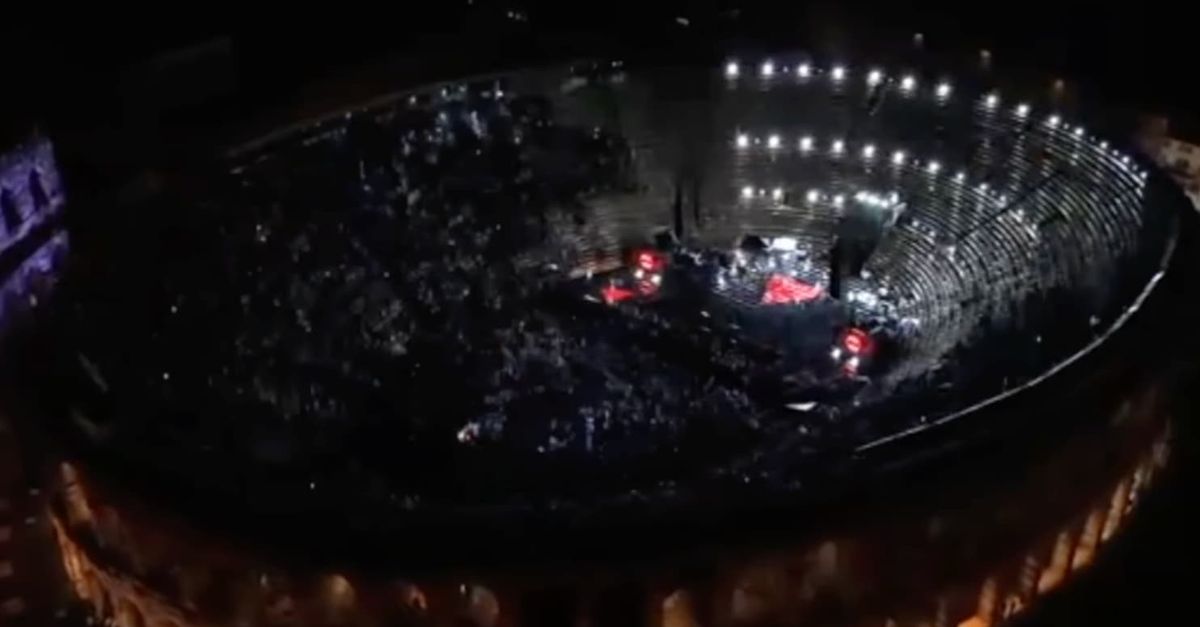

























![[SPOILER] La Forza di una Donna: anticipazioni mercoledì 3 settembre! Sirin teme il peggio](https://images.everyeye.it/img-notizie/-spoiler-donna-anticipazioni-mercoledi-3-settembre-sirin-teme-peggio-v4-825173-800x600.webp?#)












%20Carole%20Bethuel.jpg)













-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)