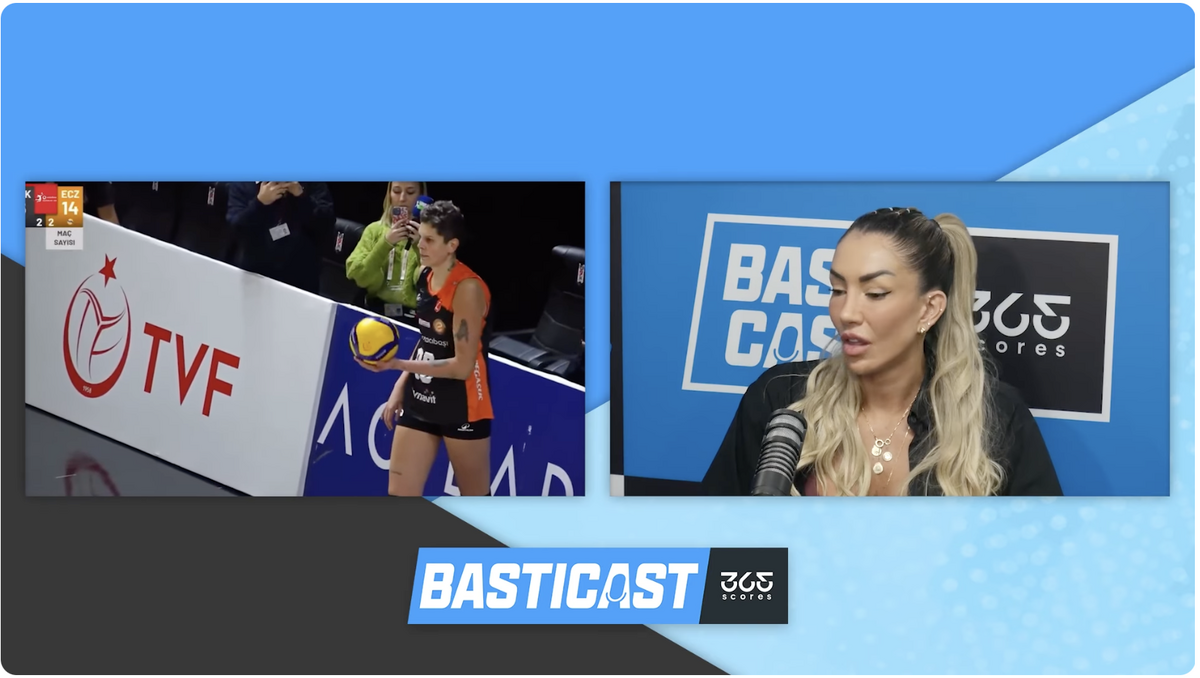Il documentario su Corona dice più sui documentaristi scarsi che su Corona


La cosa più bella del documentario su Corona è un foglio scritto in Word e stampato e appiccicato a una parete del sotterraneo in cui Corona dà la sua parte di intervista. Si vede, se state molto attenti e mettete in pausa, a qualche secondo dalla fine, perché Corona è in piedi e si sta muovendo e sta bisticciando con gli autori, vai a sapere quanto per far scena e quanto davvero.
Su quel foglio A4 c’è scritto, tutto maiuscolo, «FABRIZIO STAI DIRITTO». E sotto, tra parentesi, «risulti + FIGO». È una cosa un po’ tenera e un po’ straziante. Molto dello strazio è dato dall’aver gli autori lasciato seminascosta quella crepa da cui entra la luce, forse per far sentire segugio chi la nota.
Il guaio principale di “Fabrizio Corona: io sono notizia”, il documentario di Netflix con grafica che più tamarra non potrebbe essere, ospiti che più inadeguati non potrebbero essere, ambizione di raccontare un pezzo della storia d’Italia che più zoppicante non potrebbe essere, il guaio sono gli altri.
A parte Lele Mora, e capite bene che quando metti lì degli opinionisti con mansioni culturali, giornalisti, scrittori, e ti ritrovi con quattro ore in cui le cose più lucide le dicono Fabrizio Corona e Lele Mora, beh, hai un problema.
E a parte Platinette, che racconta questo momento stupendo in cui va a trovare Lele Mora in carcere e un secondino chiede «Come posso fare a diventare Fabrizio Corona?», e ho perso il conto di quante volte, a quel punto, Corona fosse già andato in carcere, e non da secondino o da visitatore.
La parte più interessante sono gli avvocati. Sembra di capire che Fabrizio Corona abbia neuroni specchio molto ben funzionanti, e quindi scelga sempre avvocati mitomani quanto e più di lui, istrionici quanto e più di lui, pezzi – quanto e più di lui – di una commedia che qualcuno dovrebbe scrivere.
Uno in particolare ha il suo bravo sottopancia «avvocato civilista», e a un certo punto si fa arrestare per andare a vedere come sta Corona a Opera. La richiesta di sospensione dell’incredulità è altissima (come faceva a essere sicuro di finire nello stesso carcere?), ma nessuno gli chiede niente, di quelli che lo intervistano per il documentario. Corona gli presenta tutti i galeotti, che diventano suoi clienti. Ma è un civilista, cosa se ne fa un carcerato? Nessuno glielo domanda, perché documentari senza curiosità ne ho visti, ma questo ne batte molti.
A un certo punto ci sono delle immagini di repertorio in cui i tg chiedono a Corona come mai non esistano foto delle feste che dava Berlusconi con signorine assai più giovani di lui, e Corona, con quel suo istrionismo travestito da sprezzo, con lo sguardo di chi crede d’essere Steve McQueen, si volta, dà un tiro di sigaretta, si gira di nuovo verso la telecamera, dice: «Mi domando come tutti voi, giornalisti italiani, siete così impreparati e non sapete fare il vostro lavoro». La sintassi è quella che è, ma ha ragione.
Fabrizio Corona dice di aver lanciato mutande dalla finestra nella piazza più importante di Milano. Le lanciò in largo La Foppa, per chi non è di Milano: non una delle prime dieci piazze che vengano in mente. Nessuno lo contraddice, chissà se perché nessuno sa fare il proprio lavoro o perché per fare un documentario su Corona devi avere il senso labile della verità che ha Corona.
Nelle immagini di quando stava con la Moric, Corona ha un’altra faccia. Sembra di vedere la Parietti in “Sapore di mare”, per quant’è vertiginosa la differenza tra com’era e com’è. Per quanta chirurgia plastica è passato, Corona? Non glielo chiede nessuno: non vorranno essere screanzati.
Nina Moric dice «ho ucciso due bambini» (intende che ha abortito due gemelli), Corona dice «non l’ho mai raccontato a nessuno»: sta nella sua autobiografia del 2016, forse anche altrove (Corona ha pubblicato più volumi autobiografici di Philip Roth), ma sicuramente lì c’è. Di nuovo, nessuno lo contraddice. Eccetera.
Marco Travaglio dice che Berlusconi non è né di destra né di sinistra, e gli autori di questa occasione perduta non hanno la prontezza di montare il primo che lo disse, e prendendosi meno sul serio di Travaglio: Corrado Guzzanti nell’imitazione di Francesco Rutelli, 2001. La fabriziocorona in me guarda lo schermo e borbotta: mi domando come sia possibile che voi, documentaristi italiani, non sappiate fare il vostro lavoro.
Nel documentario su Fabrizio Corona tocca fare tutto a Fabrizio Corona, anche la critica culturale del declino dello star system. Fabrizio racconta Vittorio, il padre, raccontando come con Moda e King inventò uno star system, «Monica Bellucci, mica Alessia Marcuzzi», e loro vanno avanti per le quattro ore successive a venderci lo strapotere di Fabrizio Corona in un mondo il cui star system è Ana Laura Ribas (chiunque ella sia), e non hanno minimamente l’aria di rendersi conto che quello che mostrano non è prova del potere, ma prova del declino.
C’è uno, nel ruolo dell’intellettuale, ripreso davanti a librerie i cui volumi hanno l’aria d’essere tutti romanzi allegati ai quotidiani (parlando di entrambe le categorie da vive), che riesce a dire sia «la storia si ripete due volte, la prima come tragedia e la seconda come farsa», sia «il cattivo è più interessante del buono, perché tocca degli aspetti del nostro animo che facciamo fatica a confessare», sia – giuro, non sto inventando – «un profeta del nulla che fiorisce nel vuoto che si è creato con Mani Pulite e la fine della prima repubblica». Inspiegabilmente assenti le mogli, i buoi, le gatte al lardo.
Deve fare tutto Corona, compreso far presente che lui si sarà pure venduto il funerale del bambino d’un caso di cronaca nera, ma a quel funerale c’erano tutti i tg, che pure stavano lì per vendersi lo strazio del bambino morto. Compreso dire una frase per scrivere la quale Francis Scott Fitzgerald avrebbe dato un rene: «Quante volte ho sognato, in galera, i miei soldi».
Deve fare tutto Corona con l’aiuto di Lele Mora, che, mentre rappresentanti del giornalismo fanno la morale a Corona che tenta di vendersi l’intervista alla trans Patrizia, quella del caso Lapo Elkann, «mentre lui è in rianimazione» (un problema che ci saremmo senz’altro posti se Lapo fosse stato il figlio di nessuno), fa un’egregia sintesi di quale fosse il problema: «Agnelli non bisogna toccarlo. Se lui era furbo, quelle cose di Lapo le portava ad Agnelli e gli consegnava tutto e aveva le porte aperte del mondo. Come con Berlusconi, quando avevi qualcosa gliela portavi poi lui ti era riconoscente: questo è il mio regalo, lo guardi poi mi chiami».
All’altezza del coma di Lapo Elkann, Gianni Agnelli era già morto da due anni. I documentaristi probabilmente non sanno neanche questo (avranno avuto Google rotto), visto che per didascalizzare Mora mettono appunto le immagini di Lapo col nonno. Resta che, imprecisioni a parte, solo Lele Mora, tra tutta questa gente che abbiamo buttato soldi per far studiare, capisce che anche questa, come tutte, è una storia di classi sociali.
Mentre continuo a farmi domande su chi non sa fare il suo lavoro, gente coi tatuaggi sul collo dà lezioni di stile a Fabrizio Corona, e io vorrei capire perché, per esempio, non hanno scritturato quella scrittrice che, avendo fatto da ghostwriter ad almeno una delle quattrocento autobiografie di Corona, ha visto cose incredibili e avrebbe potuto raccontarvi, per esempio, del via vai di ragazzine che andavano a casa Corona con le madri, a farsi dire cosa farsi rifare per fare carriera in tv, e la percentuale sugli interventi estetici la prendeva poi Fabrizio.
O di Corona che presentava Scapagnini come «l’uomo che ha inventato l’aspirina», o un milione d’altri dettagli magnifici, altro che quelli con le librerie dietro e l’eloquio del calendario di Frate Indovino.
E invece ci ritroviamo così, senza cornice, senza contesto, con Nina Moric che galleggia nel vuoto parlando dei feti abortiti, «lui gli ha dato i nomi pur sapendo che stavo per ucciderli e si vantava nei bar», con la madre di Corona che galleggia nel vuoto dicendo «lui ha respirato molta cultura in casa» con la dizione di Eliza Doolittle prima della cura-Higgins, con un tentativo loffissimo di spiegare Corona come prodotto del berlusconismo, con l’idea che sia chic non sapere granché di Corona e accroccare frasette moraliste.
C’è un momento di televisione di una quindicina d’anni fa che cito sempre come esempio di classe dirigente inadeguata. Era una serata televisiva in cui Livia Turco (ve la ricordate?), col piglio di chi si sente superiore, diceva a Luca Telese (non ve lo ricordate) che lei non sapeva chi fosse Fabrizio Corona.
Chissà se non lo sapeva davvero o se era anche lei convinta che fosse un prodotto del berlusconismo da cui prendere le distanze (ogni volta che qualcuno dice che l’Italia sta come sta non perché tutto il mondo sta come stiamo, ma perché abbiamo avuto Berlusconi, io penso che per fortuna ai neuroni non si fanno funerali sennò le pompe funebri dovrebbero fare gli straordinari).
Fatto sta che da quella sera in tv sono passati quindici anni che paiono centocinquanta, e l’unico dei tre di cui ancora c’interessiamo è Corona.
Nel documentario quel pezzetto di tv c’è. Mi sono stupita che avessero avuto la svegliezza di mettercelo, ma non avrei dovuto: probabilmente ce l’hanno messo perché è, Livia Turco, il manifesto programmatico di quelli che fanno i documentari su Corona. Non so chi sia, il presepe, e comunque non mi piace.
L'articolo Il documentario su Corona dice più sui documentaristi scarsi che su Corona proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0































































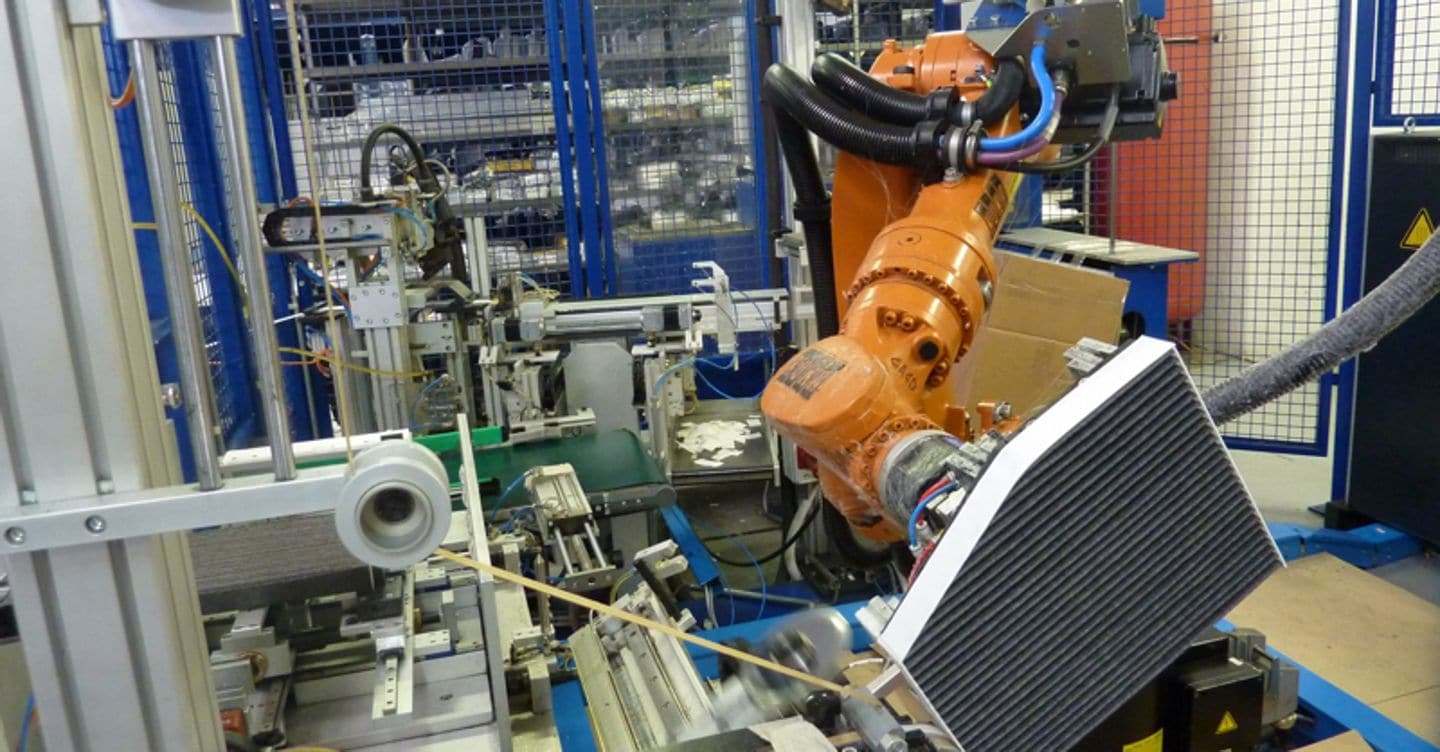
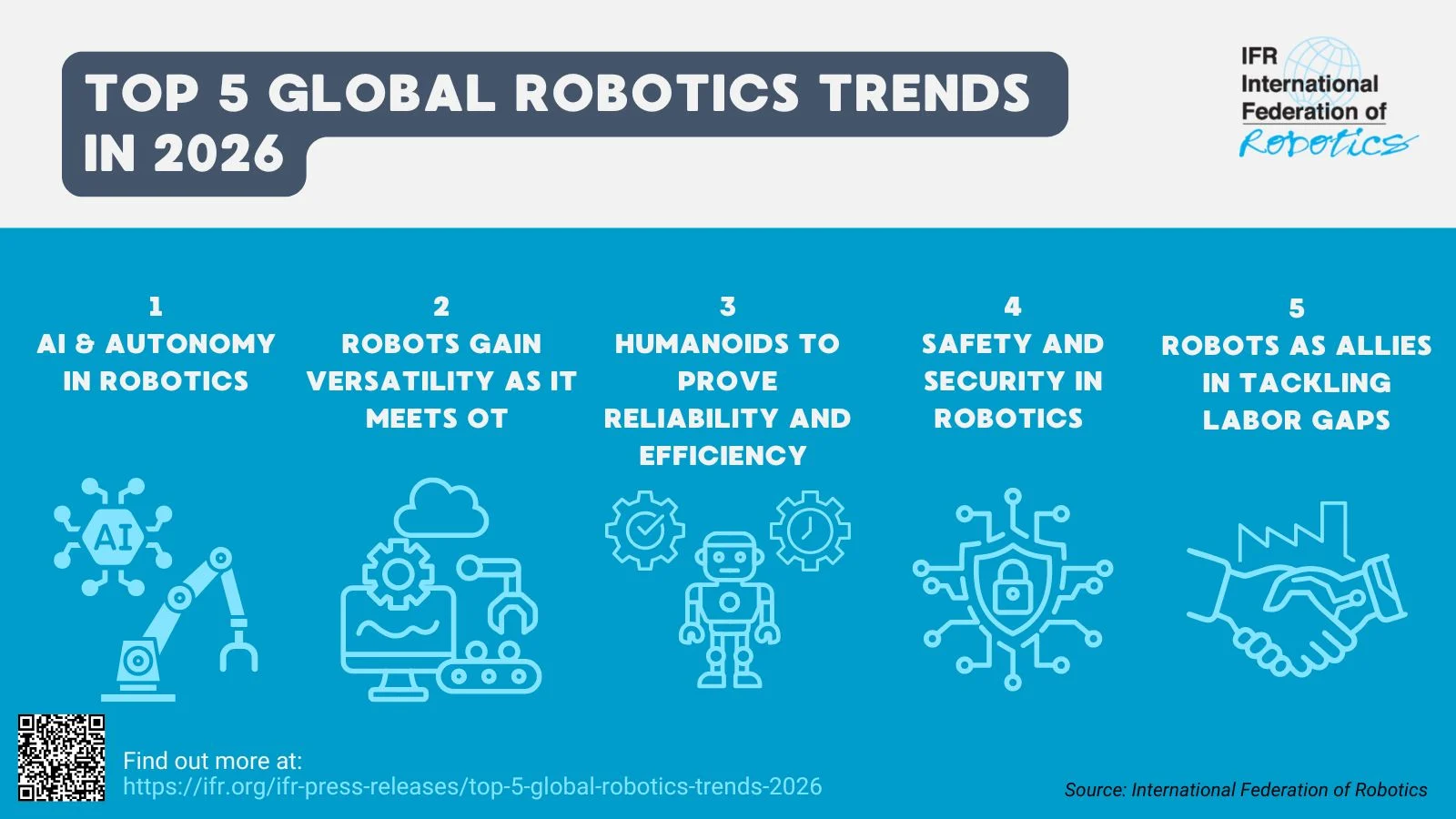



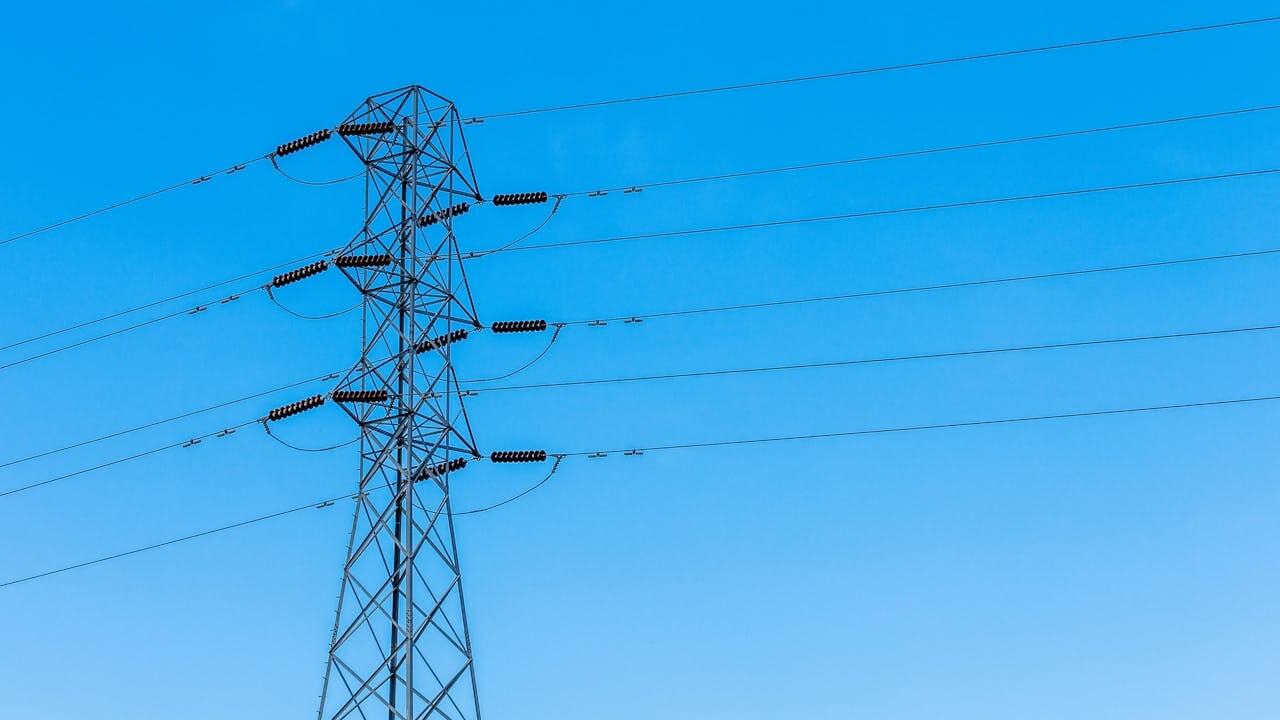




















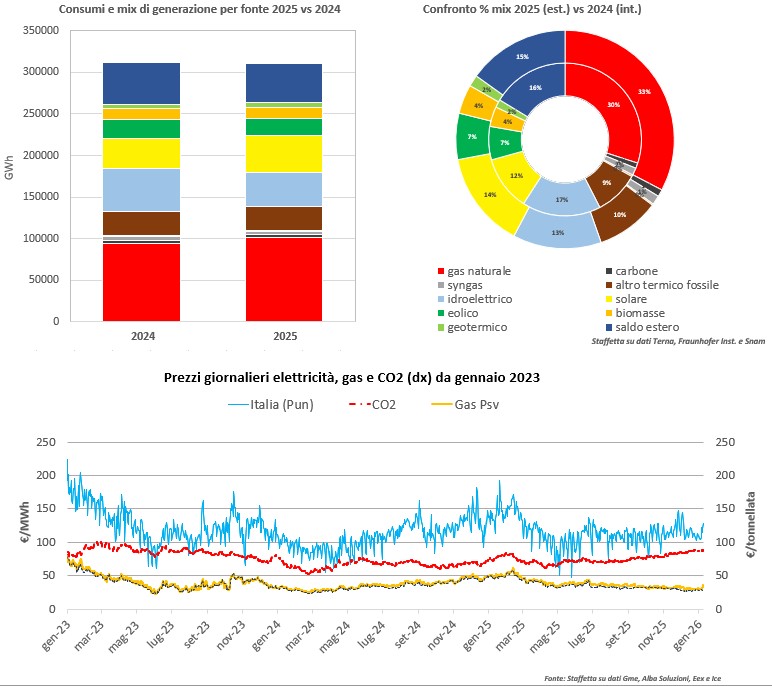


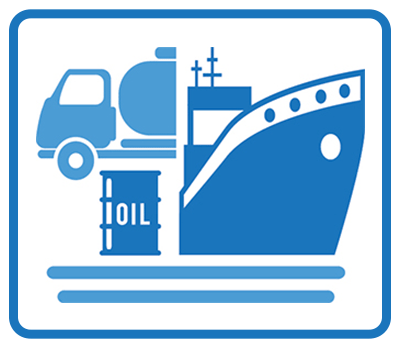








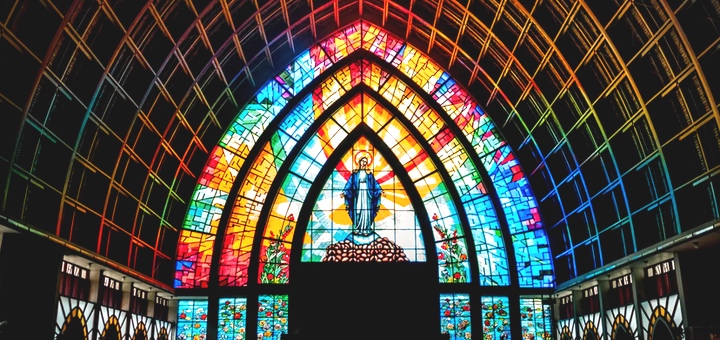

















































































_(20)-1768127423519.jpg--controlli_in_zona_aurora__sequestri_di_droga_e_alimenti_abusivi.jpg?1768127423667#)
_(17)-1768123566628.jpg--fringe_benefit_2026__bonus_confermati_fino_a_2_000_euro__stop_all_agevolazione_per_i_neoassunti.jpg?1768123566762#)
_(21)-1768128936706.jpg--incendio_boschivo_a_condove__fiamme_domate_grazie_all_intervento_coordinato_dei_soccorsi.jpg?1768128936869#)