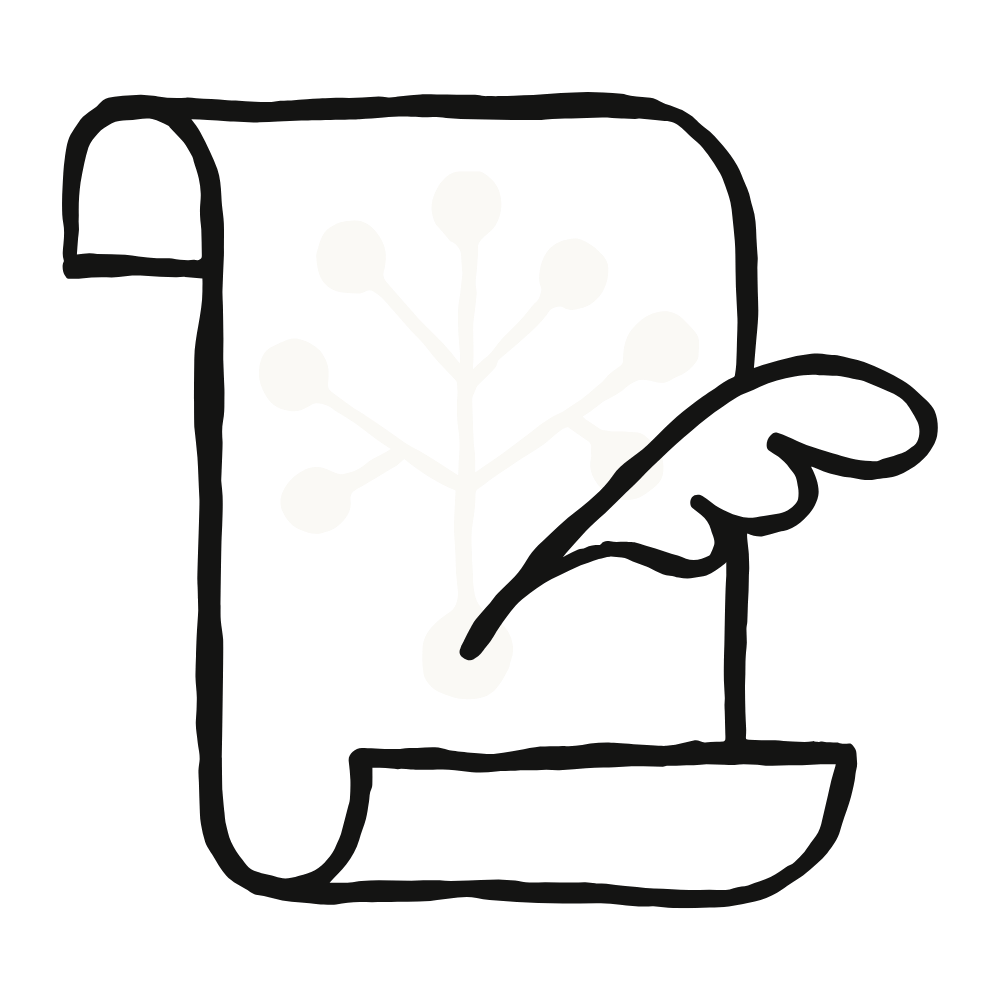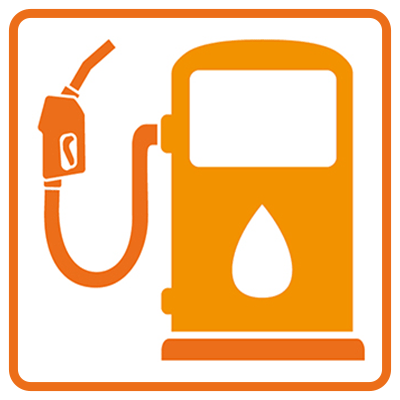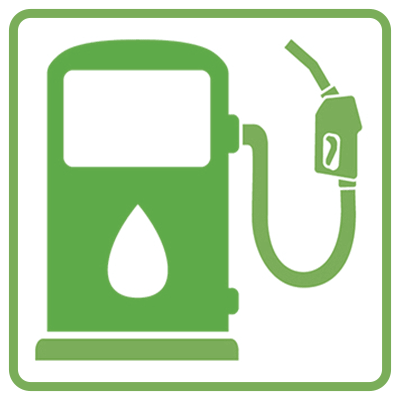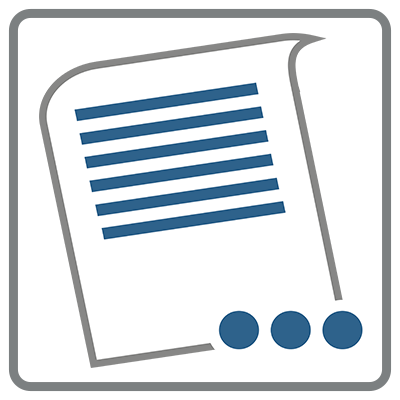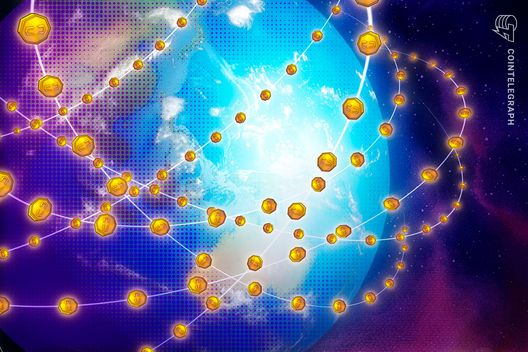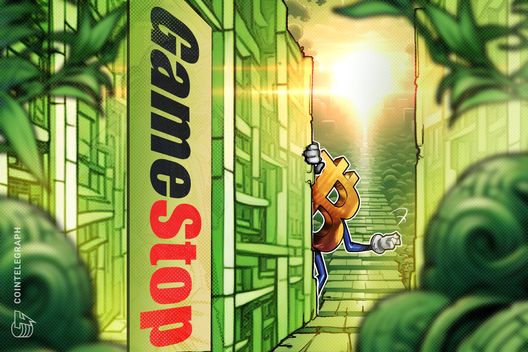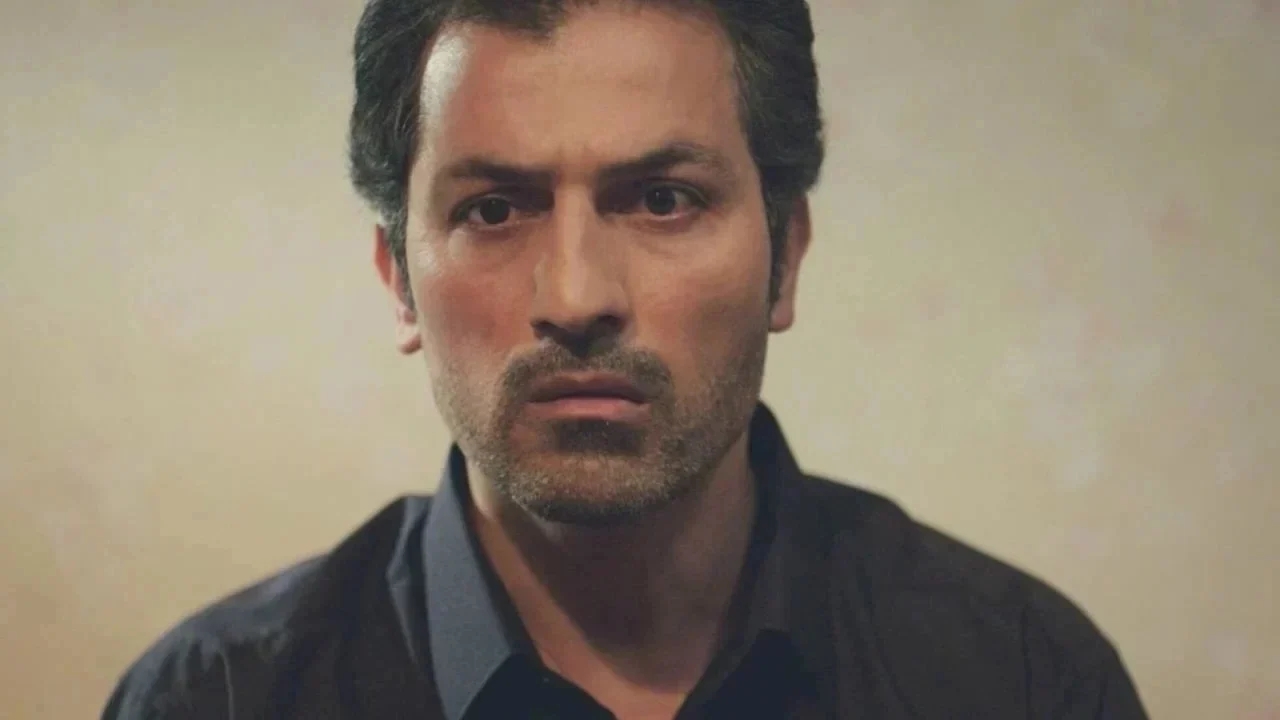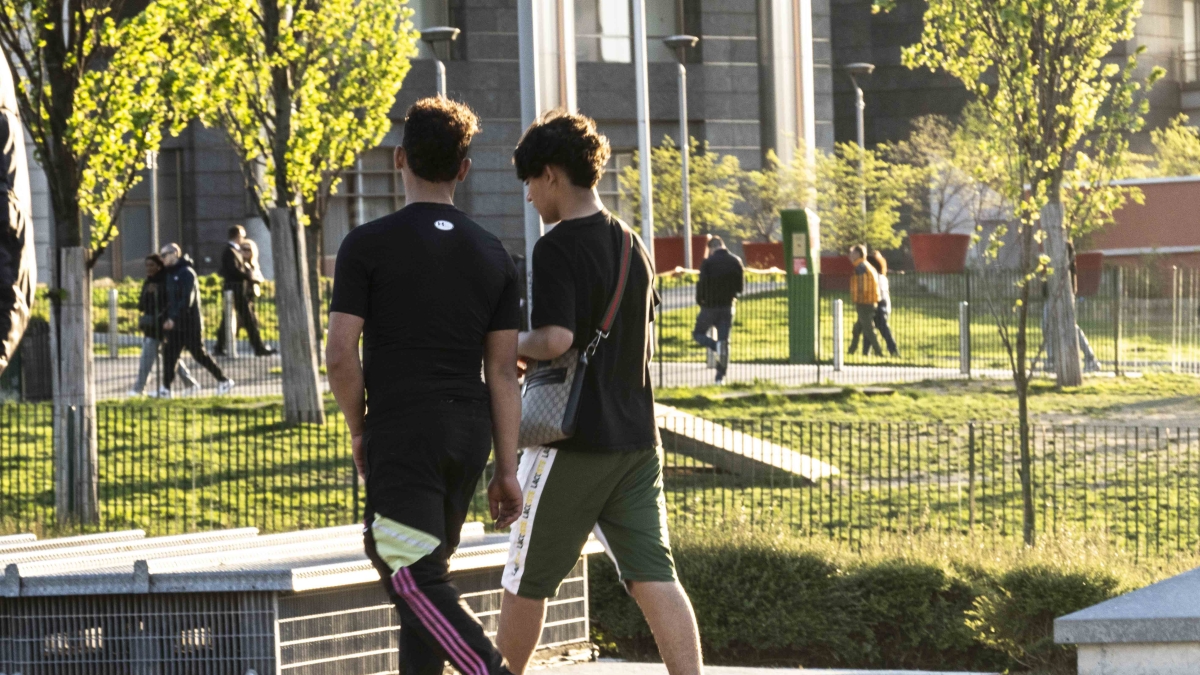Il dramma di Giosuè Chindamo, morto solo come un cane senza cure né pietà

Giosuè veniva sempre ai laboratori di Nessuno tocchi Caino nella cappella del carcere di Secondigliano. Si sedeva sulla panca di legno davanti all’altare: ascoltava, raramente parlava, a volte leggeva una poesia, a suo modo pregava. Pregava il Signore in cui aveva fede. E pregava anche noi in cui credeva, perché ci vedeva, come i Blues Brothers, “in missione per conto del Signore”, sempre in prima linea nell’opera di misericordia corporale del “visitare i carcerati”, l’incarnazione della speranza al di là di ogni speranza.
Negli ultimi anni lo vedevamo raramente nella chiesa dei nostri incontri. L’ultima volta aveva letto una poesia che Argia Di Donato aveva custodito e pubblicato sul suo giornale. Un monologo intenso e malinconico, un appello accorato a una farfalla, “bella dai mille colori” con “ali cromate d’argento”, che un giorno si era fermata nella sua cella. Inizialmente, Giosuè pensa a un segno di speranza che possa portargli fortuna, ma poi la “caccia” via, non per cattiveria, ma per proteggerla dalla desolazione del luogo di sofferenza in cui lui era finito. Una “cella” con “quattro mura”, fatta di “cancelli, cemento e ferro temperato”, intrisa di “lamento e melanconia”. Giosuè desidera che la farfalla “spieghi le ali e voli via” da quel “tunnel di monotonia” per raggiungere un mondo dove “la gente vive in allegria”, un “mondo libero e pieno d’amori”. Il monologo di Giosuè si conclude con un’ultima supplica: “non tornare più in questa valle di dolori.”
La sua era una pena senza speranza, come quella di molti convenuti nella casa del Signore, quasi tutti condannati all’ergastolo: ostativo a ogni beneficio, a un pur blando balsamo di vita per lenire una pena fino alla morte. Ma quello di cui Giosuè aveva urgente bisogno, dopo trentacinque anni di detenzione ininterrotta, non era più un beneficio penitenziario, ma un atto di umana pietà, un gesto d’amore liberatorio. Per almeno cinque anni, dal carcere di Secondigliano, ha ripetuto sempre le stesse parole: “Ho la febbre che non passa”, “Sono troppo stanco”, “Non riesco a mangiare”, “Mi fa male il petto, non respiro bene”. Giosuè Chindamo aveva 64 anni, quasi una vita passata in carcere e un passato di tumore al colon e altre malattie serie. Da tempo, il suo corpo stava lanciando nuovi segnali di allarme. Segnali che, per troppo tempo, sono rimasti senza risposta.
I familiari, i suoi compagni di sventura lo vedevano dimagrire, spegnersi, perdere forze e speranza. Gli esami del sangue, fatti in carcere, erano alterati da anni. Una febbricola che non se ne andava mai, la nausea, il vomito di sangue. Una TAC al torace mostrava linfonodi ingrossati e calcificazioni alle coronarie, campanelli d’allarme importanti. Eppure la diagnosi era arrivata solo quando ormai la situazione era precipitata: leucemia linfatica cronica, una forma di tumore del sangue, già in fase avanzata. Ad agosto era stato visitato dal Dott. Pietro Antonino Oliva, medico legale di parte: «Il Signor Chindamo Giosuè è stato accompagnato nella sala colloqui su una sedia a rotelle … il capo e il tronco erano flessi in avanti … incapace a mantenere la stazione eretta se non per un brevissimo spazio temporale … deambulazione sul piano possibile ma con necessità di appoggio, con passo corto e andatura a base allargata, incerta e claudicante, con affanno dopo un pur breve tragitto … a tratti confuso con turbe dell’attenzione spontanea, della capacità di concentrazione, disturbi della memoria a breve termine e a lungo termine e umore marcatamente depresso con preoccupazione per il proprio stato di salute.»
Non è solo la leucemia. Da tempo Giosuè lamenta un dolore forte e oppressivo al petto, che dura più di venti minuti, si irradia al braccio sinistro e gli toglie il respiro. È un tipo di dolore che, in qualunque pronto soccorso, farebbe scattare subito controlli al cuore. In carcere, secondo quanto riportato nella perizia, nessuno gli ha mai fatto gli esami fondamentali per capire se il suo cuore fosse in pericolo. Eppure la TAC mostrava già calcificazioni alle arterie coronarie. Il rischio di infarto viene definito “elevato”. Nella sua relazione, il medico legale certifica un “iter inadeguato”: troppo tempo passato senza una diagnosi, senza gli specialisti giusti, senza i controlli necessari. Dice chiaramente che il carcere, per Giosuè, è diventato “patogeno”, cioè una causa diretta o indiretta dell’aggravamento della sua malattia. Aggiunge che le sue condizioni sono “gravi e incompatibili con il regime detentivo carcerario” e che il rischio per la sua vita è molto alto. Dietro queste parole tecniche c’è una realtà semplice e terribile: un uomo gravemente malato che, per anni, non ha ricevuto le cure che avrebbe dovuto avere. Un uomo che sta scontando una pena, ma che non dovrebbe per questo essere condannato a una lenta agonia, senza dignità, senza assistenza adeguata, lontano dai propri affetti e da strutture in grado di seguirlo come il suo caso richiede.
La moglie di Giosuè, Carmelina, il suo legale, Veronica Ciardiello, il Garante dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello, chiedevano una cosa semplice e ragionevole: se non la sospensione della pena per gravi motivi di salute, almeno la detenzione domiciliare, per curarsi in un ambiente dove fossero davvero possibili controlli ravvicinati, terapie specialistiche, riabilitazione, protezione dalle infezioni. Non per cancellare la pena, ma per evitare che la pena diventasse qualcosa di molto peggio: una condanna anticipata alla morte. Una volta, ad agosto, Samuele era entrato nella sua cella, si era seduto con lui sul letto. Prima di congedarsi, Giosuè gli aveva regalato il calendario di Nessuno tocchi Caino con i volti e le frasi degli abolizionisti del carcere. C’era anche Filippo Turati: «Noi crediamo di aver abolito la tortura, e i nostri reclusori sono essi stessi un sistema di tortura, la più raffinata; noi ci vantiamo di aver cancellato la pena di morte dal codice penale comune, e la pena di morte che ammanniscono goccia a goccia le nostre galere è meno pietosa di quella che era data per mano dal carnefice.»
Nel dicembre 2024, Giosuè stava ancora in piedi, era in grado di camminare da solo, quando è andato in permesso premio per trascorrere tre giorni presso l’Ufficio Diocesano di Pastorale Carceraria a Napoli. I giudici di sorveglianza che gli hanno concesso il piccolo beneficio hanno riportato nell’ordinanza che «il detenuto aveva ripudiato il sistema criminale nel quale aveva militato, esprimeva consapevolezza per i danni cagionati alla sua famiglia e a se stesso dalla sua scelta di vita criminale, e trovava nello studio una risorsa importante per consolidare quel mutamento che le medesime relazioni comportamentali definiscono “costante” e “senza cedimenti”.». Neanche un anno dopo, novembre 2025, Giosuè si muoveva su una sedia a rotelle in regime di alta sicurezza presso la Casa Circondariale di Secondigliano e, nei momenti di crisi più acuti, presso il Reparto Detenuti dell’Ospedale “Antonio Cardarelli” di Napoli. Aveva il fiato corto anche per pochi passi, non riusciva a stare in piedi a lungo, era estremamente debole, pallido, deperito, con linfonodi ingrossati, momenti di confusione e un umore profondamente depresso.
Ma i giudici di Sorveglianza che gli hanno negato la sospensione della pena e anche la detenzione domiciliare hanno scritto che “non emerge una incompatibilità delle condizioni di salute del prevenuto con il regime carcerario” e che “ogni necessità terapeutica ben può essere soddisfatta in ambiente carcerario e ospedaliero”. Hanno aggiunto che Giosuè Chindamo era ancora un pericolo pubblico: “elemento di spicco della consorteria mafiosa … non è provvisto, neppure, di idoneo domicilio atteso che quello indicato presso la moglie Carmelina e la figlia insiste sul territorio e sul medesimo contesto criminale di appartenenza … non emergendo, peraltro, che il detenuto abbia effettivamente reciso i rapporti con il territorio e con il contesto da cui hanno tratto scaturigine i delitti”.
In nemmeno un anno, lo stesso tribunale ha messo due ordinanze diverse, opposte. Ma l’uomo non era più lo stesso, perché la malattia che poteva essere curata e il carcere che lo doveva proteggere, lo avevano distrutto. La nostra Costituzione dice che il diritto alla salute è un diritto fondamentale, di tutti. Anche di chi è detenuto. Le sentenze dei giudici supremi ricordano che la detenzione non può spingere la vita di una persona “al di sotto della soglia di dignità” e che la mancanza di cure adeguate può diventare un trattamento disumano. È accettabile che un detenuto aspetti cinque anni per scoprire di avere una leucemia, pur mostrando segnali evidenti di malattia? È giusto che chi è nelle mani dello Stato si ritrovi senza tutele costituzionali? Financo di quella minima, la possibilità concreta di curarsi in modo adeguato?
La mattina di sabato scorso, sua moglie Carmelina mi ha chiamato preoccupata. Giosuè era finito al pronto soccorso. Mi sono messo subito a scrivere la mia istanza pubblica di grazia. Non ho fatto in tempo, è il mio cruccio. La sera tardi, Giosuè se n’è andato: solo come un cane, in silenzio, senza disturbare, senza il conforto di un affetto caro. È volato in cielo con la leggerezza di una farfalla. Via dalla “valle di dolori”, fuori da quelle “quattro mura”, lontano da “cancelli, cemento e ferro temperato”. È stato “cacciato dalla cella”. Con cattiveria. Questa non è solo la storia di un uomo, ma uno specchio che ci costringe a guardare come trattiamo chi è più fragile, quando è chiuso dietro le sbarre e non ha altro che lo Stato a cui affidare la propria vita. La storia di Giosuè mina le basi della nostra civiltà e anche le ragioni del nostro dirci “cristiani”, ci interroga sulla fine che ha fatto un Paese un tempo detto la Culla del Diritto.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0