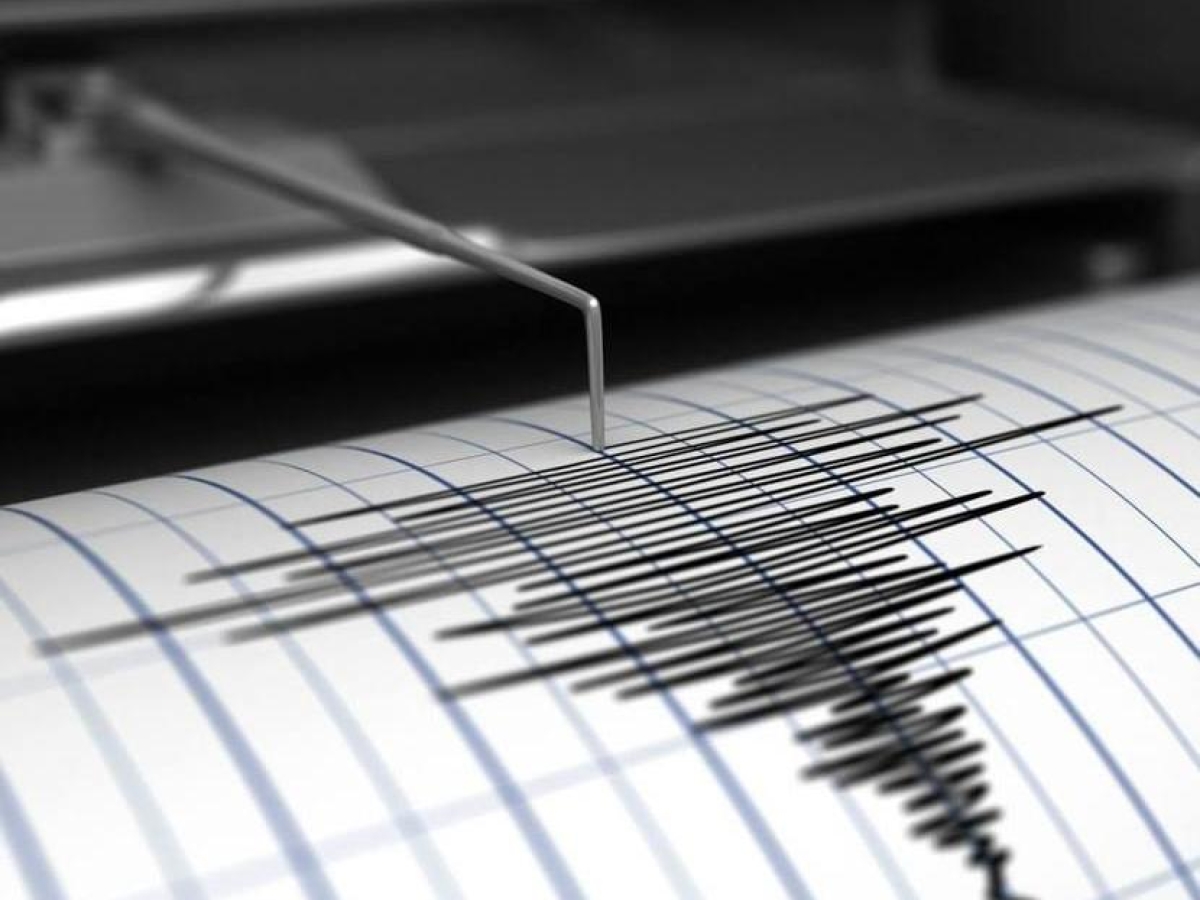La generazione di scemi benestanti il cui unico talento è scialare l’eredità familiare


«Ovviamente me l’hanno data da dirigere perché mio padre, come produttore esecutivo, ha la supervisione di tutto: mica posso negarlo». Francesca Scorsese ha 26 anni, è l’ultima figlia di Martin Scorsese, Variety la intervista perché dirige una puntata delle vite dei santi che suo padre ha voluto realizzare per Fox, e dà l’unica risposta possibile a quel fenomeno che nel secolo scorso chiamavamo «figli di papà» e in questo «nepo baby»: ma giura.
Sono tutti figli di qualcuno. È un problema, ma non nel senso in cui lo vediamo lamentato in generale: io sarei una grande regista ma siccome non sono figlia di Scorsese nessuno mi dà niente da dirigere, tu saresti un grande romanziere ma siccome non sei figlio di Kingsley Amis nessuno ti considera.
È un problema perché Marcello Mastroianni non sarebbe mai diventato Marcello Mastroianni se non avesse avuto il problema della sussistenza. È un problema perché le sfighe – e essere poveri e irrilevanti è una sfiga – sono l’unico carburante per il talento. È un problema perché non c’è mai stato un figlio di famiglia abbastanza benestante da mantenerlo che non sia stato scemo: se non devi usarlo per forza, il cervello si atrofizza (ora arrivano quelli che mi spiegano che il cervello non è un muscolo, e non è neanche detto siano ricchi di famiglia).
Kate Winslet dirige un film in arrivo su Netflix, “Goodbye June”. Fa parte del fascicolo attrici che diventano registe? Forse no. Al Sunday Times dice che non ha mai avuto l’ambizione della regia, «come regista non hai il tempo di respirare e io avevo dei figli da crescere». L’ha infine fatto perché i figli sono cresciuti e ha tempo? Quasi: l’ha fatto perché i figli sono cresciuti e uno ha deciso di fare lo sceneggiatore (un’altra fa l’attrice: ha deciso di condannare sé stessa a una vita di «certo che sua madre alla sua età era più figa»).
Qualcuno avrebbe mai prodotto la sceneggiatura di Joe Anders (nome d’arte, il cognome sarebbe quello del padre, che oltre a essere il secondo marito di Winslet è un regista d’una certa qual fama, Sam Mendes), se non gliel’avesse diretta mammà?
Qualcuno avrebbe mai finanziato l’esordio alla regia del nipote di Arthur Miller se papà, Daniel Day-Lewis, non si fosse offerto di interpretarla? Non è più solo «lo fanno lavorare perché è il figlio di», il che era ottimo perché permetteva a noi figlie di nessuno di consolarci con la convinzione che, se solo avessimo avuto i genitori giusti, il Nobel (o almeno il Telegatto) sarebbe stato nostro.
È un nuovo stato della materia del nepotismo, quello in cui papà ti compra la fabbrica così ti eserciti a fare il dirigente d’azienda, mamma ti dirige il film così puoi metterti in curriculum «sceneggiatore», e in generale l’ultima generazione cresciuta in quel secolo meno scemo si premura di far trovare a figli con la pappa già fattissima la pappa ancora più fatta: vuoi una carriera che non hai abbastanza talento e tigna per procurarti da solo? Eccoci, pronti, ti faccio da garante.
Qualche settimana fa sul magazine del Wall Street Journal c’era la stupendissima storia di Eva Gayer, contabile di David Judelson, già presidente d’una multinazionale, che quando la moglie di lui muore si lega sempre più a Judelson, forse lo plagia, fatto sta che divorzia dal marito e lo sposa e ovviamente i figli pensano che lei l’abbia manipolato.
Tutto ordinaria vicenda di cronaca nera, non fosse che le accuse reciproche – neanche quelle un format inedito – raccontano qualcosa del presente. I figli dicono che lei è un’arrampicatrice che voleva i soldi del padre, sì. Ma lei dice che loro sono degli scrocconi che volevano che il padre continuasse a mantenerli a vita. Il che è d’un certo Zeitgeist, nell’epoca in cui tutti sono figli di qualcuno: i figli di Judelson sono più vecchi di me, non sono trentenni del tempo in cui tutti i genitori si occupano della carriera e del sostentamento di tutti i figli ormai assai maggiorenni, ma c’è una cosa che non cambia da un secolo di benessere economico all’altro, ed è che una generazione fa i soldi e quella successiva li sciala.
«Ho dato moltissimo a tutti voi, specialmente a te», scrive il patriarca ricco in una mail scocciata al figlio Roy, scocciata giacché i figli protestano perché Eva ha divorziato e s’è sposata col loro papà e lo fa spendere e spandere, un milione in cashmere e gioielli, perdindirindina, e lei chiaramente lo controlla: le carte giudiziarie elencano, tra le ragioni di sospetto, che non gli fa mangiare la cipolla.
Per non parlare del fatto che, quando il padre muore ottantanovenne, si pretende venga rispettata la clausola firmata anni prima per cui Roy deve restituire gli otto milioni e quattrocentomila dollari con cui aveva aiutato il figlio a comprare il suo appartamento, dal prezzo complessivo di dieci milioni e mezzo (chissà se almeno aveva il bagno con la vasca, povero, queste generazioni cui il patriarcato ha arrubbato il futuro).
È perché l’ha traviato l’orrida megera, che si è anche appropriata di trenta milioni di dollari, lui non li rivoleva davvero accusano Roy, che negli anni ha avuto 25 milioni dal padre, Paul, che ne ha avuti 14, e Jeaneane, che con soli sette milioni è chiaramente la Cenerentola di casa (altra vittima del patriarcato, evidente). I figli che accusano il genitore che dice «mo basta» (e viceversa) perché plagiati da esterni alla famiglia sono un grande classico di “C’è posta per te”, ed è sempre molto affascinante osservare come non sia mai andata davvero così: sono proprio consanguinei che si detestano, anzi in genere la persona esterna cerca di mettere pace.
Nel caso Judelson però questa scoperta non può avvenire, non solo perché non c’è Maria De Filippi: il padre è morto, e quindi abbiamo solo la versione della vedova contro quella dei figli di primo letto, i quali pensano solo ai soldi, bramano solo i soldi, parlano solo di soldi. Il defunto padre come Carlo Verdone nella sua serie: «Voi mi trattate come un bancomat umano».
Negli eredi Judelson io vedo le mie amiche che hanno tutte fatto facoltà umanistiche condannando loro stesse a una vita di redditi bassi, ma mandano comunque i figli a scuole internazionali da trentamila euro l’anno perché tanto pagano i nonni, i quali hanno fatto studi seri e i soldi veri. Quando diciamo «capitalismo familiare» non intendiamo che le aziende sono di proprietà di qualche famiglia di ricchi: intendiamo che, finiti i parenti e i loro soldi, saranno cazzi. L’Italia è una repubblica fondata sui soldi di famiglia, ma pure il resto del mondo mica scherza.
Se il figlio di Sam Mendes e quello di Daniel Day-Lewis vivono scialando il talento dei padri, perché i figli di David Judelson non dovrebbero scialare l’eredità paterna? Se i figli dei benestanti che conosciamo noi danno in affitto appartamenti comprati loro dai genitori, invece di lavorare; se i figli degli artisti che conosciamo noi hanno tutti un libro in uscita, e genitori disperati che fanno gli influencer senili fotografando le copertine dei puccettoni; se tutto il mondo è paese, chi può mai voler regolamentare la sussistenza ereditaria?
Probabilmente gli stessi mostri che vorrebbero la patrimoniale, gente senza cuore, gente che non ha rispetto per le tradizioni italiane, tra le quali c’è nonna che coi suoi appartamenti e la sua pensione fa campare i nipotini ormai quarantenni, oltre a tirare la sfoglia tutte le domeniche per sfamarli, ché i giovani mica sanno badare a loro stessi.
L'articolo La generazione di scemi benestanti il cui unico talento è scialare l’eredità familiare proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0





























































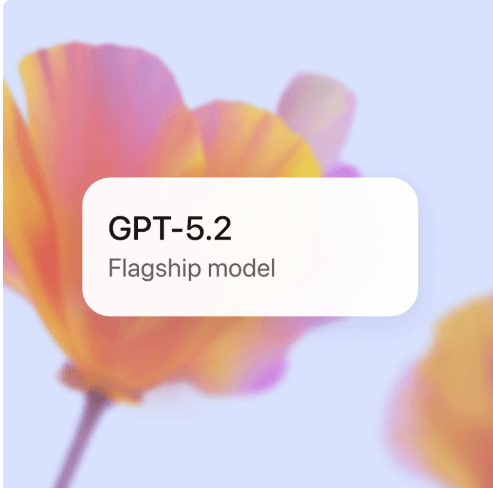
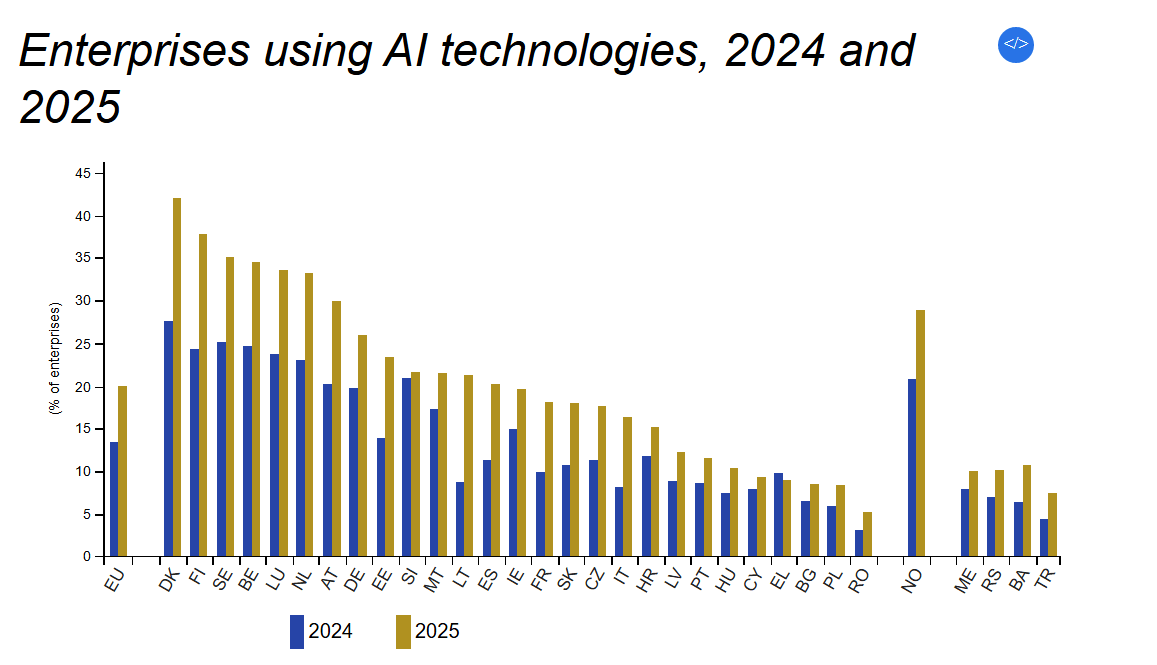

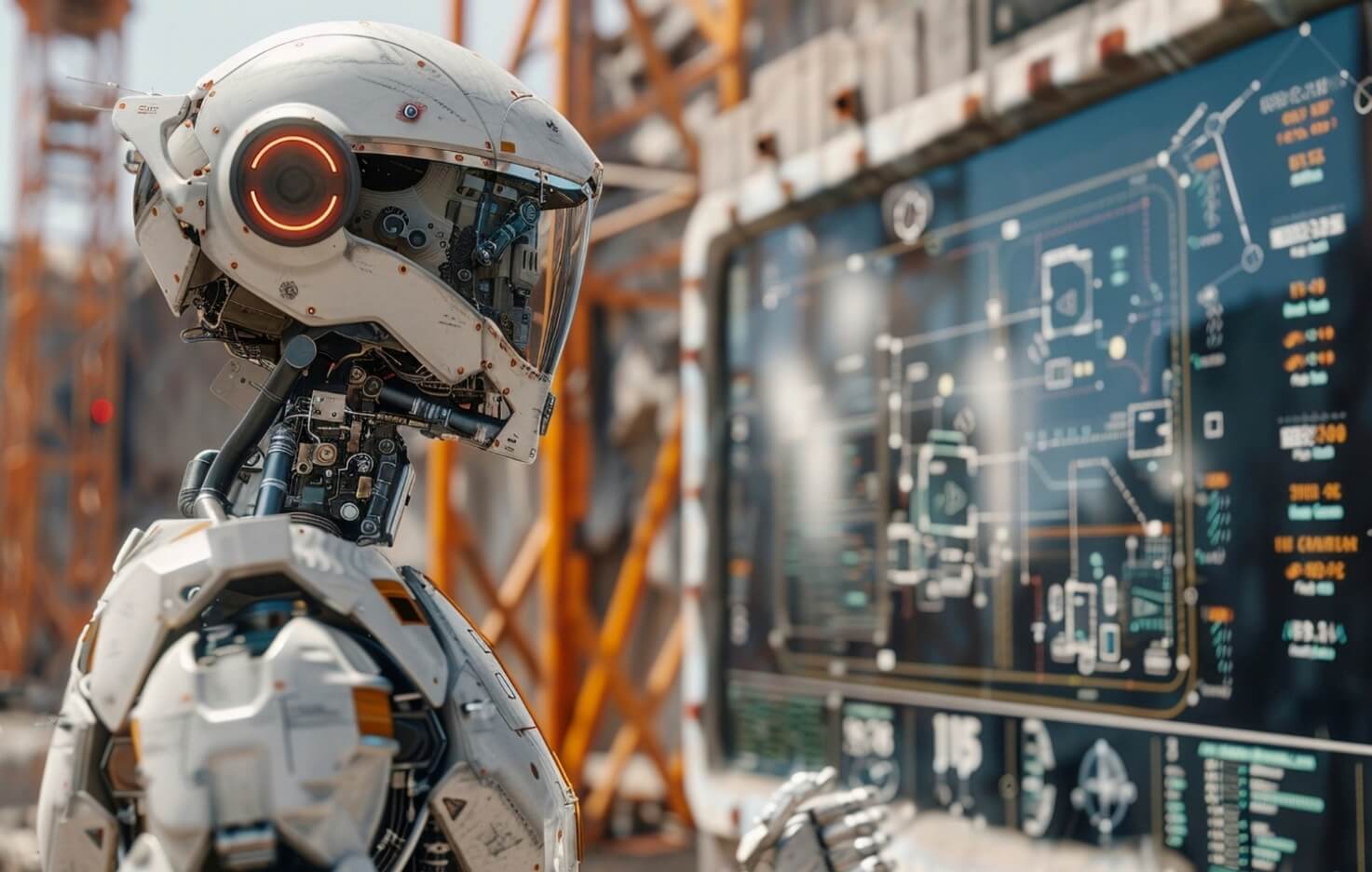




















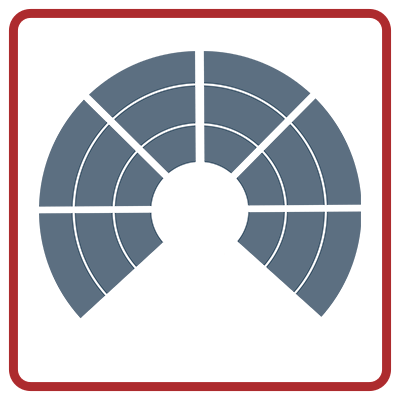


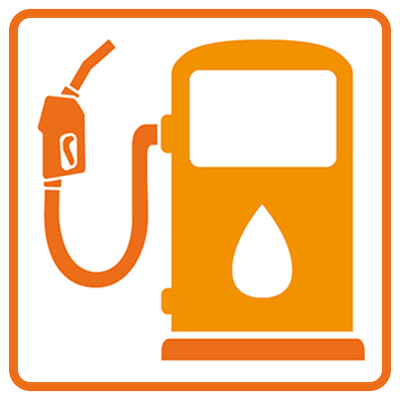






















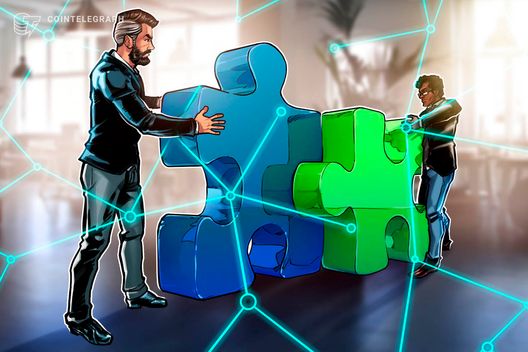




















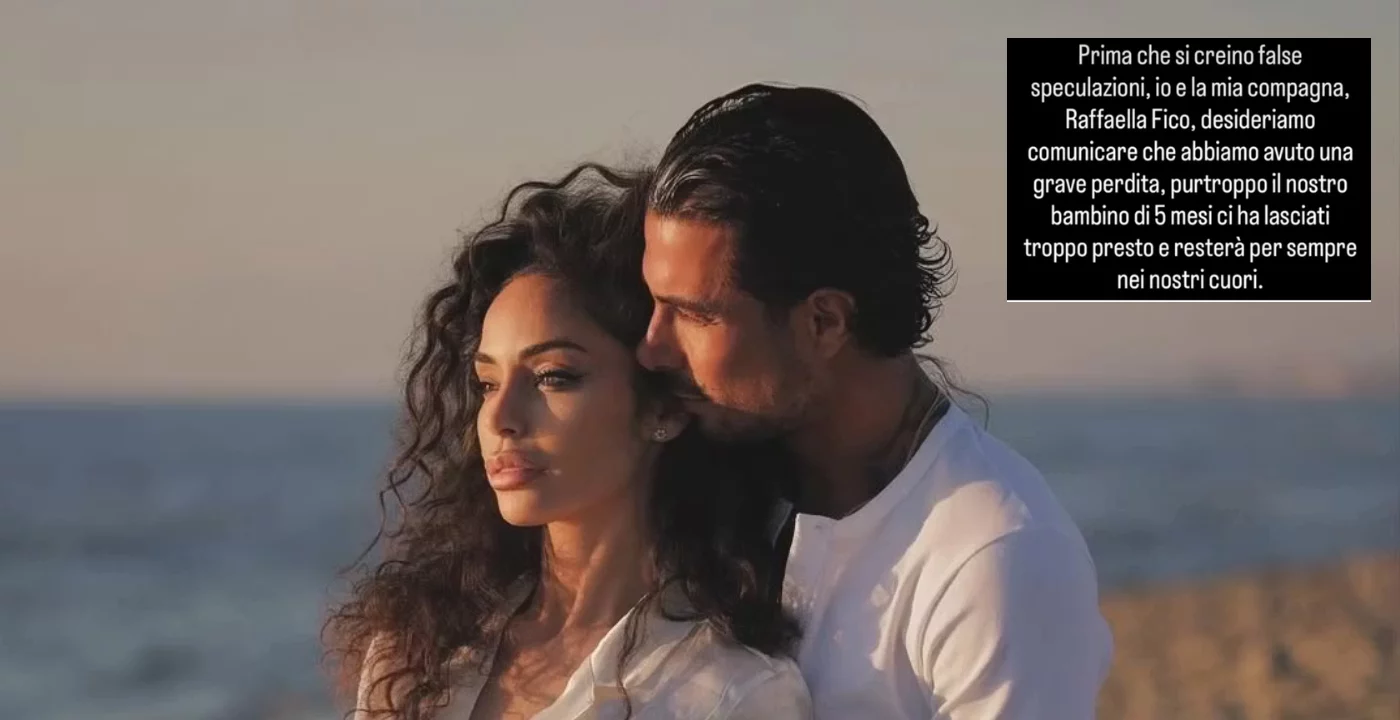



























































-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)