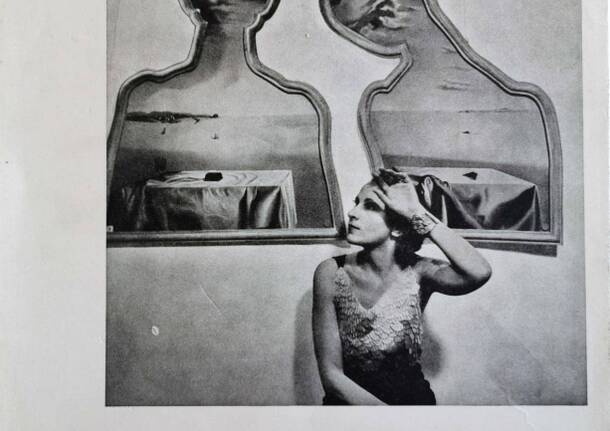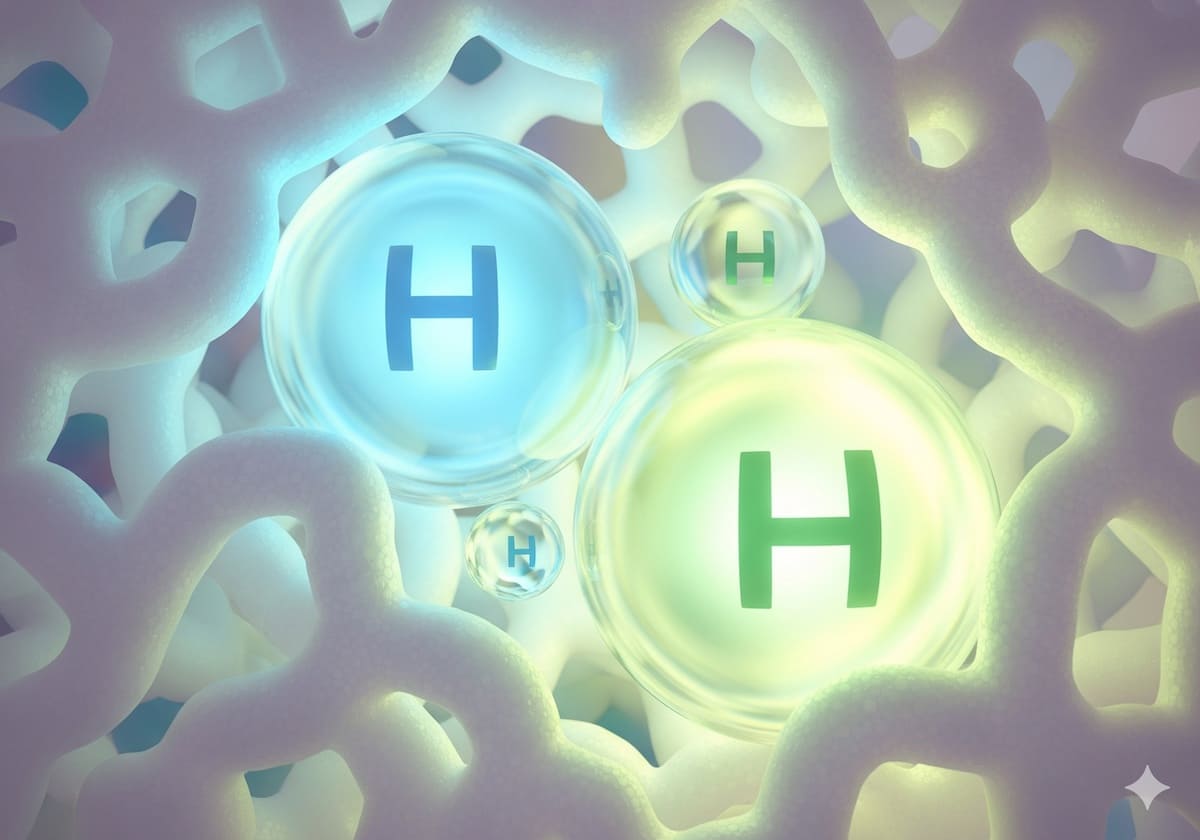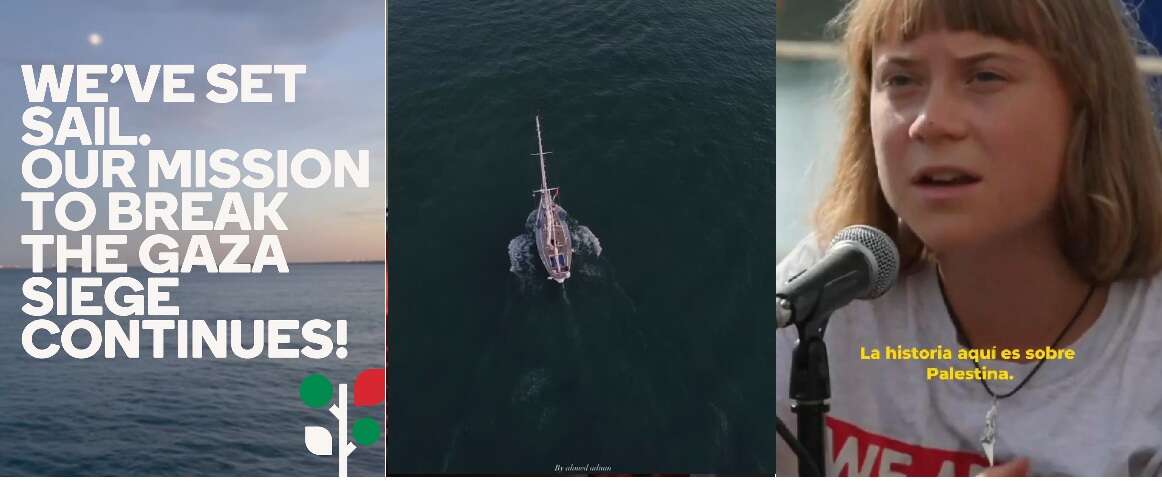Dai fanghi di depurazione si possono recuperare nutrienti e acqua, ma l’Italia ne butta via il 54%


Dai fanghi da depurazione delle acque reflue urbane è possibile recuperare sostanze preziose come il carbonio, elemento essenziale per la salute dei suoli, nonché l’azoto e il fosforo, nutrienti fondamentali per le colture agricole. Per non parlare del fatto che i fanghi costituiscono fertilizzanti di origine naturale utili per ridurre la dipendenza dai concimi chimici e rendere il mercato europeo più autonomo. O del fatto che possiedono un significativo potenziale energetico, sia per la produzione di biocarburanti, sia come materiali destinati al trattamento termico, con particolare attenzione al recupero del fosforo, una materia prima critica per l’economia del nostro Paese. Ebbene, nonostante tutte queste qualità e opportunità offerte, in Italia oltre la metà - 54% per la precisione - dei fanghi di depurazione prodotti, pari a 1,6 milioni di tonnellate l’anno, non vengono recuperati.
Tra l’altro, oltre alle sostanze citate in apertura, questi residui del trattamento degli scarichi fognari possono contenere fino all’85% di acqua. E dunque quel 54% sprecato fa anche perdere l’occasione di recuperare oltre 1,3 milioni di metri cubi di risorsa idrica. Ad oggi la loro mancata gestione efficace comporta uno spreco in termini ambientali (1,4% delle emissioni globali dallo smaltimento dei fanghi), economici (10,6 miliardi di euro di costo globale per lo smaltimento) e strategici. Tutti fattori che evidenziano l’urgenza di un cambio di passo e di strategia su questo fronte.
Tutti questi dati, uniti a un appello forte a muoversi in una direzione più conveniente dal punto di vista economico e ambientale, trasformando gli impianti di depurazione in vere e proprie bioraffinerie capaci di recuperare acqua, nutrienti e energia, arriva da oltre 50 protagonisti della filiera idrica italiana che insieme a ministero dell’Ambiente, Arera ed Enea hanno partecipato al primo workshop dedicato proprio ai fanghi di depurazione, parte integrante del percorso della Community Valore Acqua di Teha.
Già in passato sulle nostre pagine abbiamo segnalato le opportunità legate a tale comparto e i rischi che si corrono a causa di inopportune mosse del Mase. La gestione dei fanghi di depurazione rappresenta dunque un tema su cui bisogna muoversi con attenzione e da trattare sia senza perdere tempo e sia con lungimiranza. In Italia, infatti, ogni anno si producono 3,2 milioni di tonnellate di fanghi, destinati a salire a 4 milioni con l’ammodernamento del sistema depurativo, ma attualmente solo il 20% viene riutilizzato in agricoltura, mentre è in crescita l’impiego per la termovalorizzazione e il mono-incenerimento. «L’Italia – ha sottolineato Benedetta Brioschi, partner Teha e responsabile della Community Valore Acqua nel corso del workshop – vive una condizione paradossale all’interno della depurazione: a fronte di standard qualitativi di alto livello della risorsa alla fonte, è al 22° posto in Ue per quota di acque reflue trattate in modo sicuro (70,2%) e 1,3 milioni di cittadini vivono in Comuni ancora privi del sistema di depurazione. Il 65% dei costi operativi di un impianto è ancora legato alla gestione dei fanghi, quando potrebbero rappresentare un’opportunità. È necessario aggiornare la direttiva europea vigente che risale al 1986 e la normativa italiana del 1992: sono obsolete rispetto agli standard ambientali e alle nuove potenzialità tecnologiche».
Grazie alle tecnologie oggi disponibili, stima Teha, è possibile recuperare oltre 2,5 milioni di metri cubi di acqua depurata di alta qualità all’anno solo in Italia da destinare a usi agricoli e industriali, ma si potrebbero recuperare fino a 63.000 tonnellate di fosforo (pari al 6% del consumo di fertilizzanti in UE) e fino a 87.500 tonnellate di azoto (1% dei fertilizzanti). Perciò i depuratori possono diventare veri e propri hub industriali di economia circolare, capaci di recuperare acqua, energia e nutrienti valorizzabili sul mercato. I fanghi permettono l’estrazione di nutrienti strategici come fosforo e azoto, sempre più richiesti dall’agricoltura europea, e possono generare energia tramite processi come la digestione anaerobica e la gassificazione.
«Durante la sessione di lavoro dedicata – ha riferito sempre Brioschi – gli operatori si sono trovati concordi sull’opportunità strategica di trasformare gli impianti: il ruolo dell’innovazione renderebbe possibile anche il raggiungimento della loro neutralità energetica e contribuirebbe in modo decisivo alla rimozione di microinquinanti emergenti, come i Pfas e le microplastiche. La transizione verso un modello di bioraffineria rappresenta dunque una risposta concreta e integrata alle esigenze di sostenibilità, resilienza e qualità ambientale del sistema idrico italiano e un passo importante verso l’obiettivo di definire una roadmap europea della gestione efficiente di una risorsa chiave come i fanghi di depurazione».
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0











































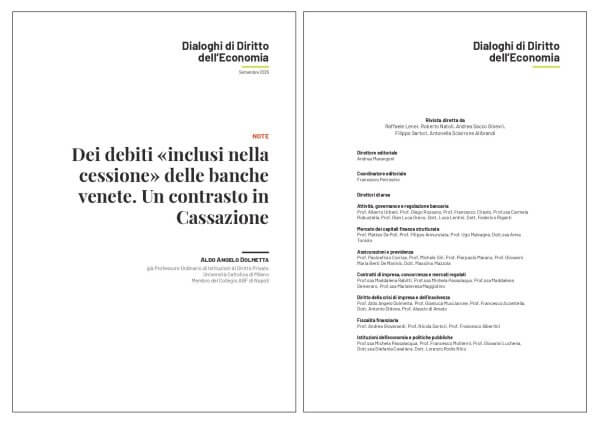
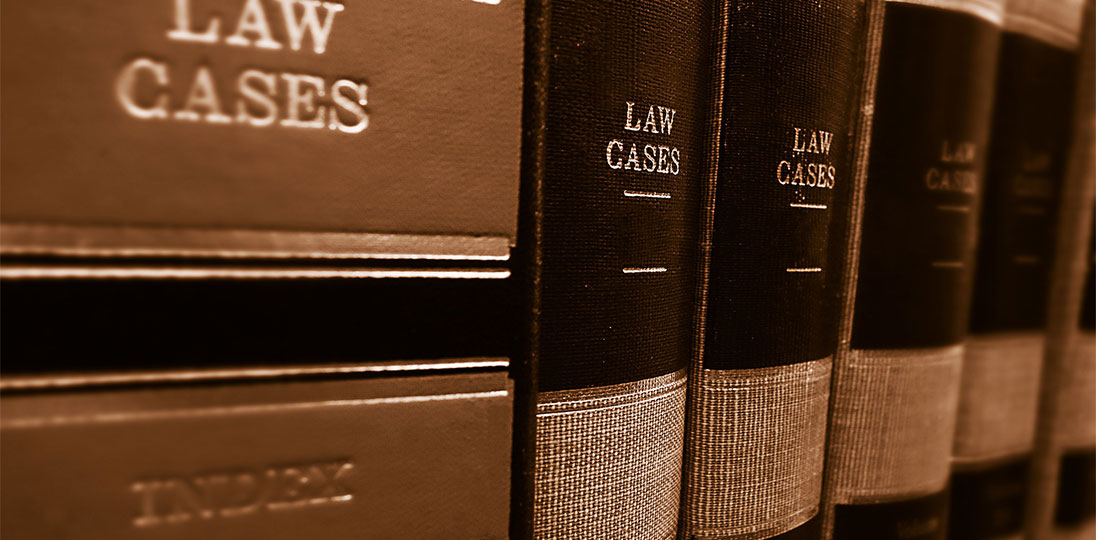



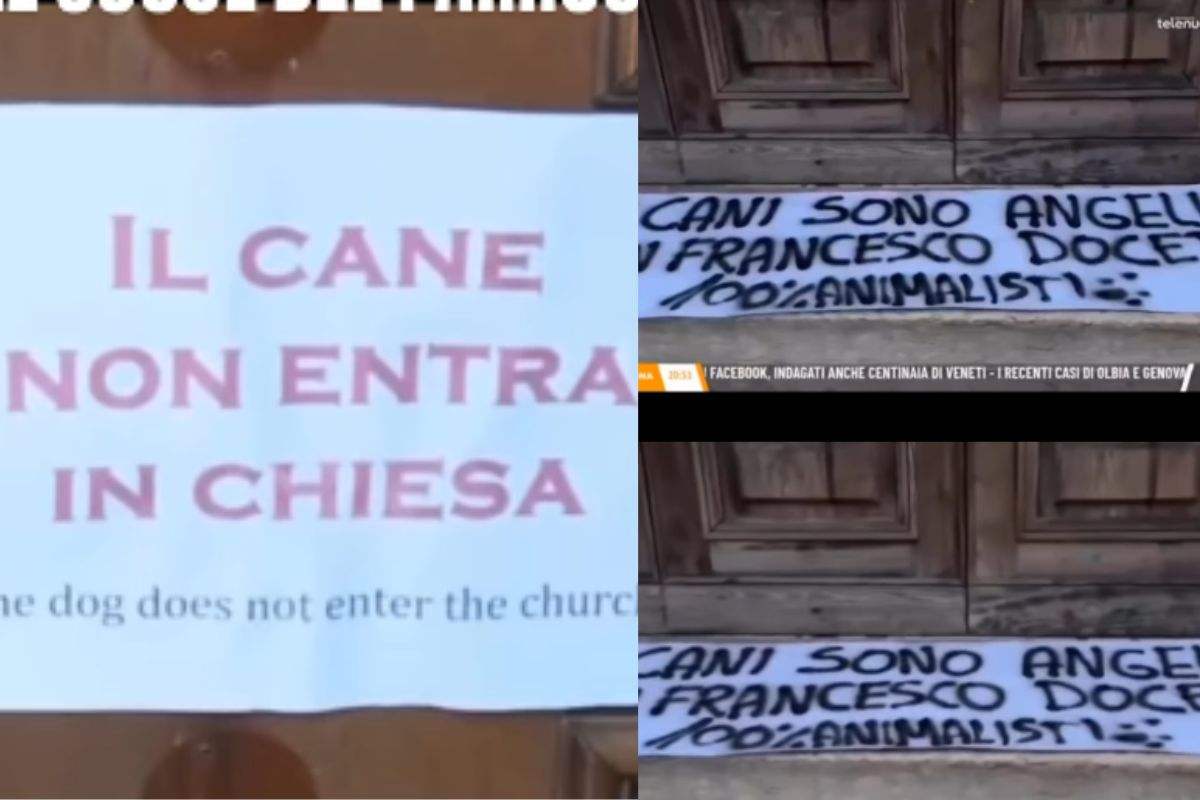





































/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/09/wp_drafter_181208.jpg)
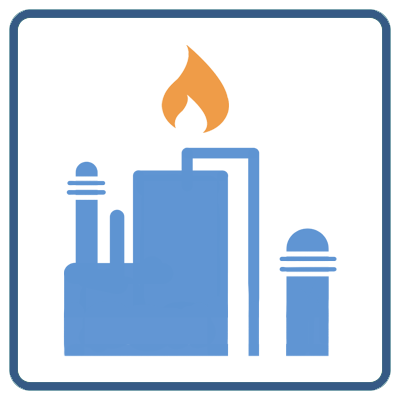


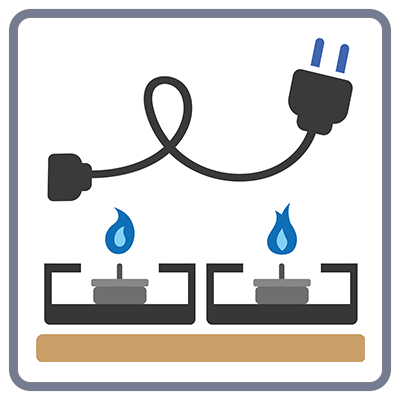


























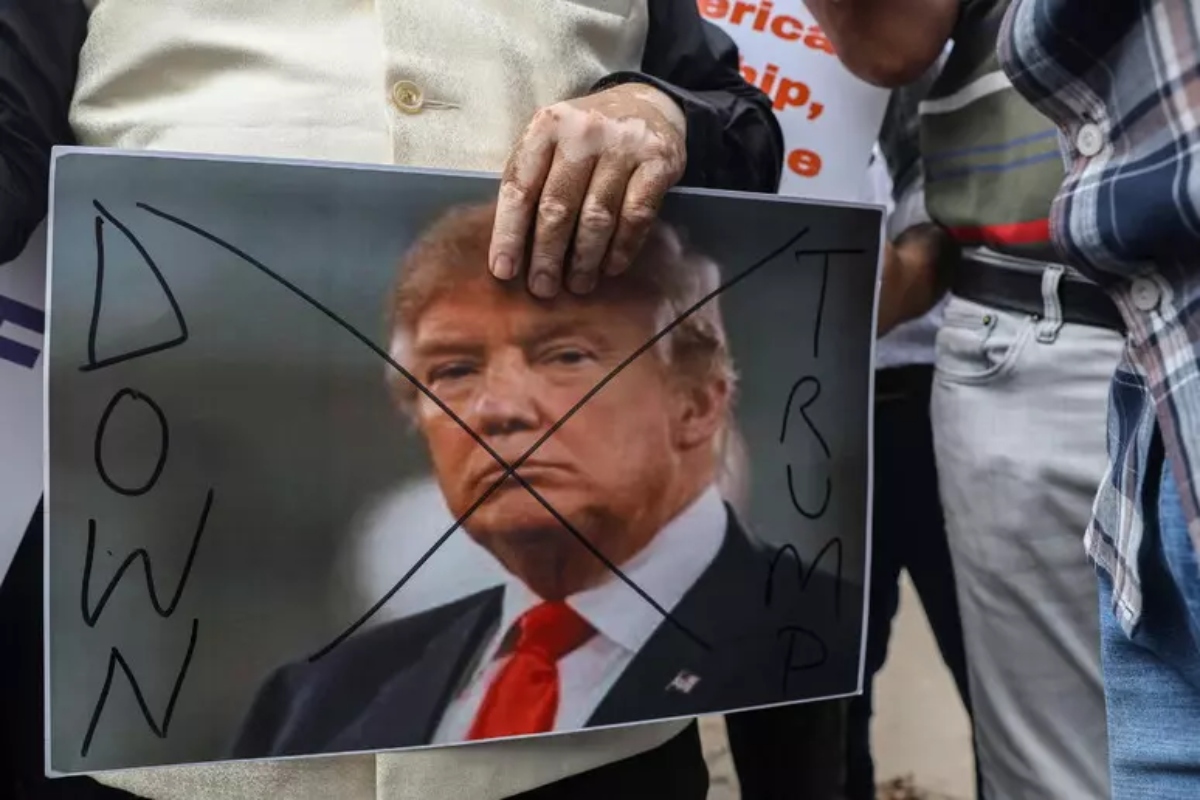





















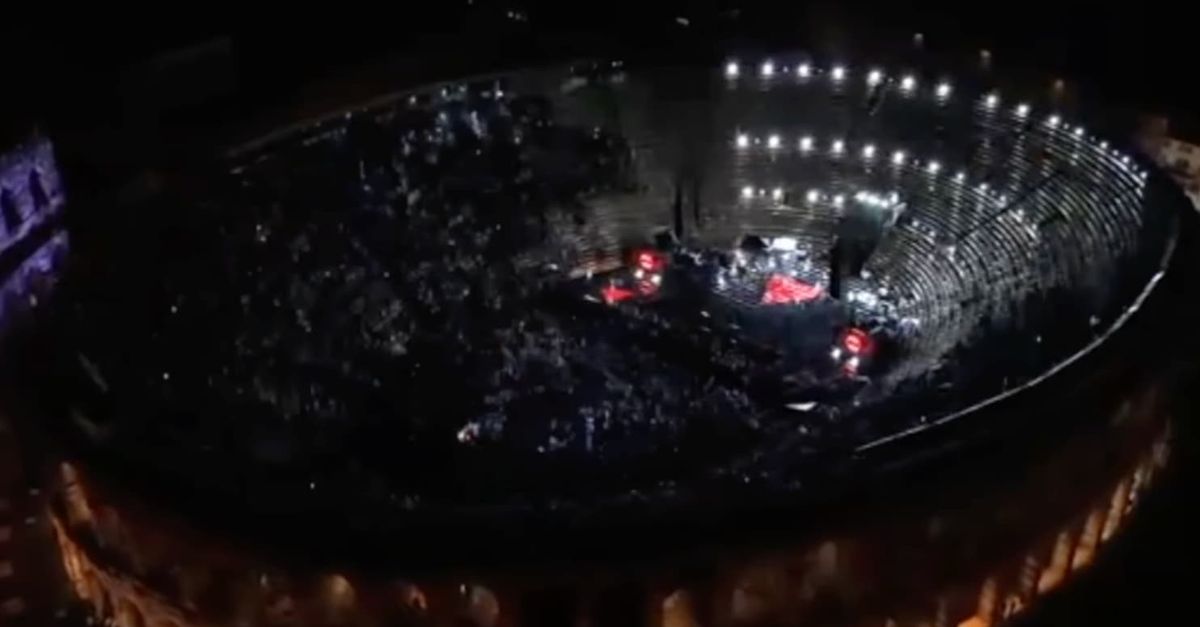

























![[SPOILER] La Forza di una Donna: anticipazioni mercoledì 3 settembre! Sirin teme il peggio](https://images.everyeye.it/img-notizie/-spoiler-donna-anticipazioni-mercoledi-3-settembre-sirin-teme-peggio-v4-825173-800x600.webp?#)












%20Carole%20Bethuel.jpg)













-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)