Come si misura la maturità dell’AI industriale? Sicurezza, costi e indipendenza

intelligenza artificiale
Come si misura la maturità dell’AI industriale? Sicurezza, costi e indipendenza
Le sfide per rendere davvero operativa l’AI industriale: costi sostenibili, sicurezza dei dati e indipendenza tecnologica. Tra open source, modelli di governance e scelte tra sviluppo interno o piattaforme integrate, emerge la necessità di un approccio pragmatico e aperto, in cui l’intelligenza artificiale diventa leva concreta di efficienza e innovazione aziendale

L’intelligenza artificiale sta entrando in una fase di maturità che richiede non solo innovazione tecnologica, ma anche modelli di gestione sostenibili e affidabili. Al convegno dell’Osservatorio Big Data & Business Analytics del Politecnico di Milano, Fabio Pascali, Regional Vice President Italy, Greece & Cyprus di Cloudera, ha sottolineato come le imprese stiano affrontando un passaggio cruciale: dalla sperimentazione all’AI industriale, un’evoluzione che implica la capacità di controllare costi, sicurezza e indipendenza tecnologica.
Secondo Pascali, la sfida per le organizzazioni non è più dimostrare la fattibilità tecnica di un progetto di intelligenza artificiale, ma garantirne la scalabilità economica e la solidità operativa, in modo che i casi d’uso possano essere integrati in maniera stabile e sicura nei processi aziendali.
L’equilibrio tra costi e scalabilità dell’AI industriale
Una delle principali barriere alla diffusione di modelli di AI industriale è rappresentata dai costi. Pascali evidenzia come molti modelli, specialmente quelli generativi, si basino su architetture a consumo, dove il prezzo è legato ai token elaborati. «La ragione principale è che i modelli che tendenzialmente utilizzano sono basati su token. Questo, passando a un modello industriale, fa esplodere i costi rispetto magari ad altri approcci», spiega.
La questione non riguarda soltanto la spesa immediata, ma la sostenibilità economica nel lungo periodo: più casi d’uso vengono sviluppati, più aumenta il costo complessivo. Pascali sottolinea che per molte organizzazioni diventa quindi strategico orientarsi verso modelli infrastrutturali che non crescano linearmente con il numero di applicazioni, ma che permettano economie di scala reali. In questa logica la scalabilità dell’AI non è solo una questione tecnica, ma un fattore determinante di competitività.
La sicurezza dei dati come fattore di fiducia
Accanto ai costi il secondo elemento che definisce la maturità dell’AI è la sicurezza. Pascali richiama l’attenzione su un punto che molte aziende sottovalutano: la delicatezza delle informazioni utilizzate durante il training e nelle interazioni con modelli generativi. «Pensate all’applicazione per fare una prenotazione medica. Io passo informazioni sensibili, compresa la mia patologia. Tutti questi aspetti stanno, in qualche modo, frenando il passaggio a un modello industriale molto più vasto», osserva.
Il riferimento non è solo alla tutela della privacy, ma alla necessità di governare l’intero ciclo di vita del dato: dalla raccolta all’uso nei modelli, fino alla conservazione e al controllo degli accessi. La fiducia, infatti, diventa un prerequisito per l’adozione su larga scala dell’intelligenza artificiale, soprattutto in settori regolamentati come la sanità, la finanza o le telecomunicazioni.
L’indipendenza tecnologica come garanzia di controllo
Un altro tema centrale dell’intervento di Pascali riguarda l’indipendenza tecnologica. La scelta dell’infrastruttura su cui basare i modelli di AI — che sia cloud pubblico, privato o on-premise — non può essere dettata da vincoli di piattaforma, ma deve rispondere a esigenze di governance e di sicurezza del dato. Pascali lo spiega chiaramente: «Noi forniamo la piattaforma dove il cliente serve, non forziamo il cliente a andare verso una soluzione cloud piuttosto A o B o C piuttosto che on-prem. Sarà il cliente a scegliere in funzione del bisogno di privacy o di delicatezza dell’informazione».
Questo principio di neutralità infrastrutturale riflette un trend crescente nel mercato: la volontà delle imprese di mantenere il controllo sulle proprie informazioni, anche quando si affidano a servizi esterni. La capacità di muoversi liberamente tra diversi ambienti — cloud, edge o sistemi locali — è oggi considerata una condizione necessaria per evitare il lock-in tecnologico e per assicurare una gestione trasparente dei dati.
Open source e interoperabilità: leve per l’AI industriale
Un altro pilastro individuato da Pascali è il ruolo dell’open source come acceleratore di cambiamento. «L’open source è un grande acceleratore di cambiamento, è sempre stato e per noi è centrale», afferma, sottolineando come l’adozione di standard aperti permetta di superare le barriere tra ambienti e soluzioni.
L’uso di formati condivisi, come il formato Iceberg per la gestione dei data lake, consente di creare un’infrastruttura realmente interoperabile, dove i dati restano accessibili e utilizzabili da diversi sistemi e modelli di AI. Allo stesso modo, l’apertura ai Large Language Model open source rappresenta un passo verso un ecosistema più flessibile, in cui le organizzazioni possono scegliere, integrare e adattare i modelli in base ai propri obiettivi, mantenendo sempre il controllo sul dato.
Questo approccio riflette una visione sempre più diffusa nel mondo dei dati: l’apertura come forma di sicurezza e sovranità. Utilizzare componenti open consente alle aziende di verificare il codice, comprendere i meccanismi decisionali dei modelli e adattarli alle proprie policy di compliance.
Make vs. Buy: l’AI tra autonomia e velocità
Nella seconda parte del suo intervento Pascali tocca un tema cruciale per la strategia di molte imprese: la scelta tra sviluppare internamente le proprie piattaforme di AI o adottare soluzioni integrate già disponibili sul mercato. «Posso sviluppare una piattaforma in casa partendo da zero e combinando tutti i modelli open source forniti liberamente da qualche altro soggetto? Certo che posso farlo. Dipende qual è l’obiettivo dell’azienda», osserva.
La riflessione porta a una metafora efficace: costruire un’auto da zero o noleggiarla per partire subito. «È come se io avessi oggi un obiettivo, quello di partire e andare a fare un giro per vedere il bellissimo foliage di questa stagione. Esco, vado da un noleggiatore, scelgo la mia auto e parto immediatamente. Oppure esco da questa stanza, trovo un concessionario di pezzi di ricambio ben fornito e, manuale alla mano, mi metto a costruire la mia auto e forse un giorno partirò».
La metafora rende evidente la tensione tra autonomia e time-to-value: da un lato la libertà di personalizzare e controllare ogni componente, dall’altro la necessità di arrivare rapidamente a generare valore. Pascali invita a una riflessione pragmatica: se l’obiettivo è costruire valore di business attraverso l’AI, la priorità dovrebbe essere la messa in produzione dei casi d’uso, più che la costruzione ex novo dell’intera infrastruttura tecnologica.
Verso una AI industriale sostenibile e aperta
Dalle considerazioni di Pascali emerge una visione dell’AI industriale fondata su tre assi di maturità: la sostenibilità economica, la sicurezza dei dati e la libertà di scelta tecnologica. Solo bilanciando questi elementi, le imprese possono trasformare l’intelligenza artificiale da strumento sperimentale a leva strategica per l’efficienza e l’innovazione.L’AI industriale, in questa prospettiva, non è un traguardo, ma un percorso: un modello in evoluzione che unisce governance dei dati, apertura degli ecosistemi e responsabilità nella gestione delle informazioni. Come ricorda Pascali, la vera differenza non sta nella tecnologia in sé, ma nella capacità delle organizzazioni di mettere i dati al centro, garantendo sicurezza, interoperabilità e valore duraturo per il business .
L'articolo Come si misura la maturità dell’AI industriale? Sicurezza, costi e indipendenza proviene da Innovation Post.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0

































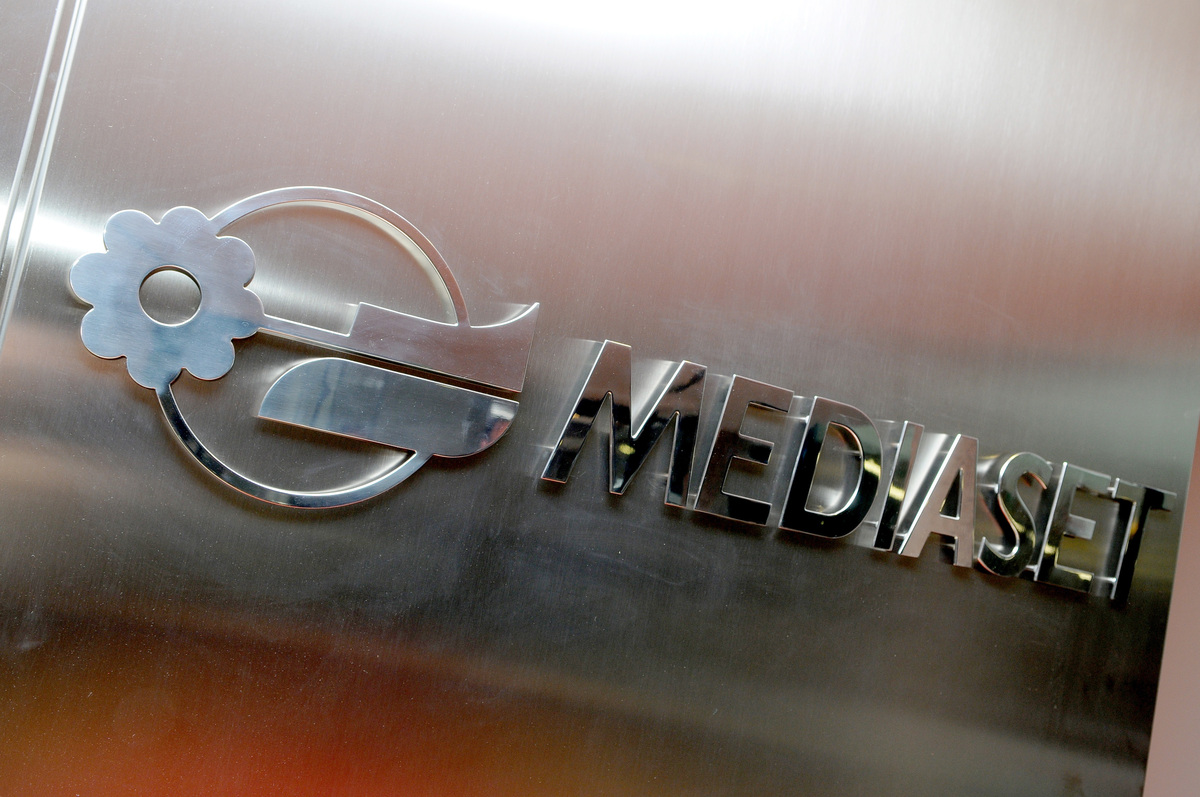























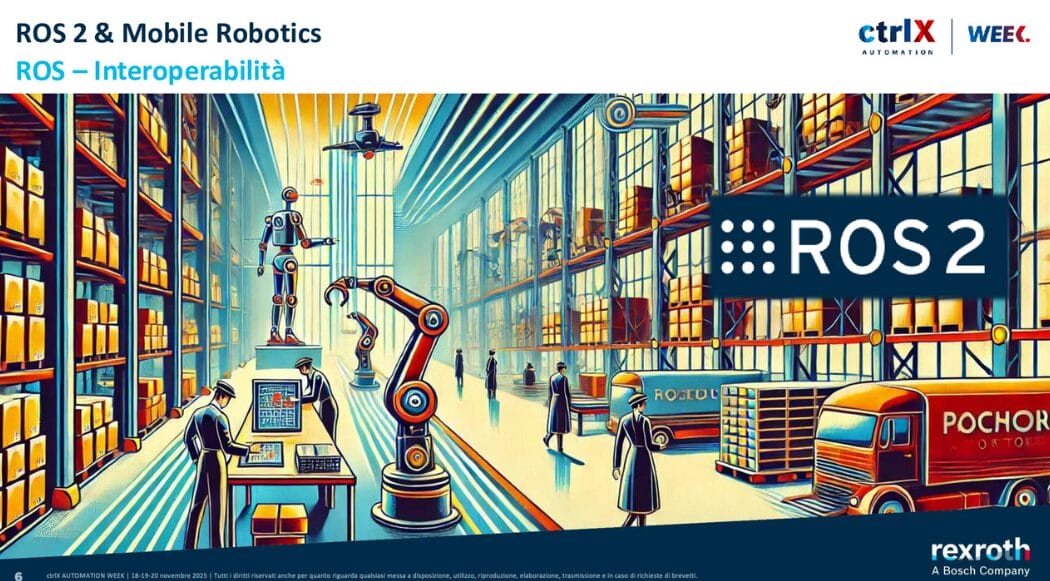



















































































































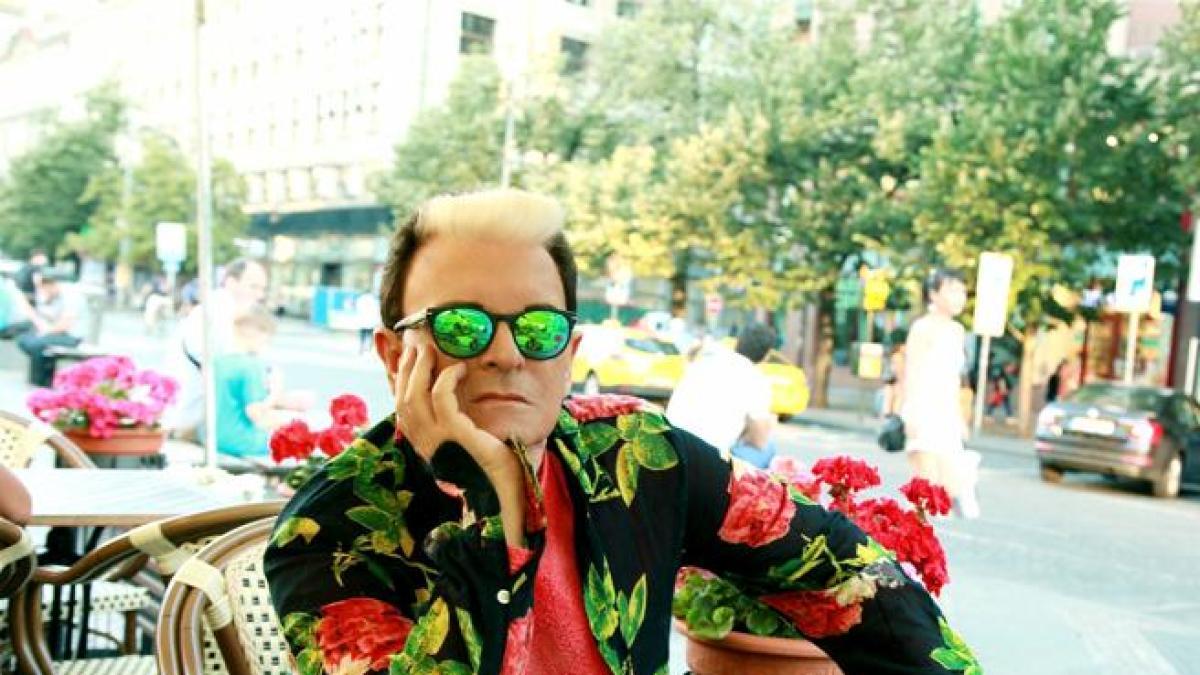

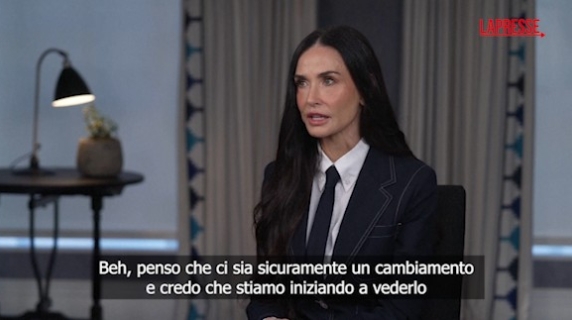










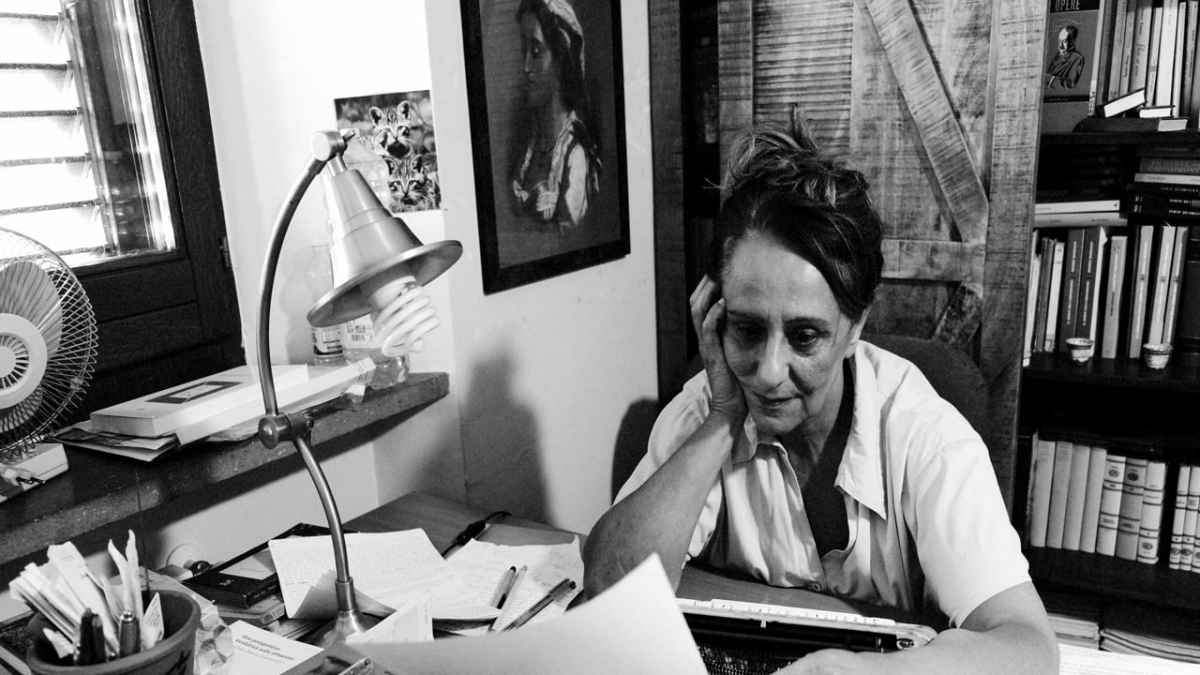









-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)
























































