Volontariato: la parte migliore del Paese o narcisisti del bene?

Il volontariato è un eroismo silenzioso, o un modo per attirare consensi e piacersi allo specchio? Fare del bene è possibile o è solo una forma di narcisismo? La solidarietà è un moto dell’animo o non piuttosto l’ennesima smania di condividere la parte migliore di se stessi, per collezionare like e diventare, chissà, influencer del bene? E il volontariato all’era dei social ha ancora una sua autenticità o è solo l’ennesima esperienza da mettere in mostra? È intorno a queste domande che si snoda La parte migliore del paese, ultimo libro di Andrea Cardoni appena pubblicato da Fandango. Cardoni interverrà alla presentazione del nuovo numero di VITA, mercoledì 19 novembre a Firenze: sul magazine è una delle dieci voci a cui abbiamo chiesto di indicare quali sono oggi i motori dell’azione volontaria. Lui ha scelto “mondo”, che è molto più di una parola.
Una storia possibile: il bene diventa like
In breve, la trama del romanzo – che vuole offrire l’occasione per una riflessione onesta sul senso, ma anche i possibili rischi, scivolamenti e deformazioni dell’impegno sociale – è questa: Mattia, il protagonista, arriva al volontariato tutt’altro che “volontariamente”. Per riavere la sua patente, che gli è stata ritirata, viene indirizzato ai lavori socialmente utili e si ritrova a “Esserci Sempre”, una storica associazione di volontari del soccorso del territorio in cui vive. A salire su un’ambulanza, però, proprio non ce la fa, perché la vista del sangue lo fa svenire.

Così Mattia scende a patti: anziché soccorrere malati e feriti, si occuperà di comunicazione e promozione, impegnandosi a far conoscere l’associazione. Lo farà attraverso un podcast, “Maimut”, realizzato con i racconti dei soccorsi dei volontari in ambulanza. E quel podcast diventerà virale.
Muovendosi tra paradosso e realtà, tra sarcasmo ed ironia, ma soprattutto con la competenza di chi questo mondo lo conosce da vicino, Cardoni impone una riflessione e una domanda: qual è – se c’è – la parte migliore del Paese? E il volontario, perché lo fa?
«Innanzitutto, una premessa: nel mio romanzo, la definizione “parte migliore del Paese” è usata per sottolineare le contraddizioni della retorica che esaspera e mescola l’eroismo, il patriottismo, il paternalismo; che esalta quelli che vengono chiamati gli “eroi silenziosi di tutti i giorni” dagli stessi che li silenziano. Alla domanda, rispondo prendendo in prestito le parole di Vincenzo Sciortino, presidente di Anpas Piemonte, quando a Torino, al Circolo dei Lettori, durante una recentissima presentazione di questo romanzo, ha detto che non c’è una parte migliore del Paese, ma che il volontariato è una parte necessaria. Il volontariato è una parte del Paese che produce un incontro che avviene tutti i giorni e, come ricorda padre Enzo Bianchi, esistono solo le cose che si fanno tutti i giorni.
Impotenza è la cifra del nostro tempo, ma in Italia ci sono 4,7 milioni di persone che si spendono per gli altri.
Qual è il senso di questo impegno? Le risposte all’interno del magazine ‘‘Volontario, perché lo fai?”

Qual è la sua esperienza personale con questa parte del Paese?
È da più di vent’anni che, tra cooperazione e volontariato, ho a che fare con persone che, anche se vengono date per scontate, cercano di fare qualcosa per gli altri. Anche per lavoro cerco di raccontare queste persone per quello che fanno ogni giorno, non solo quando vengono chiamate gli “angeli” del soccorso, del fango, del terremoto, eccetera. Per questo, anche un po’ per frustrazione, ho immaginato che cosa potrebbe succedere se queste persone, e se le organizzazioni di cui fanno parte, smettessero di essere date per scontate e venissero riconosciute e ascoltate: se all’improvviso diventassero influenti o addirittura famose.
Pensa che i social stiano trasformando l’essenza stessa del volontariato e dell’impegno sociale?
Social e contenuti digitali in generale sono parte di un contesto con cui ci si deve confrontare. Anche chi si impegna nel sociale deve farlo e questo per forza implica una trasformazione, sia dal punto di vista organizzativo sia dal punto di vista delle singole persone. In questo senso, chi decide di stare sui social, decide di accettare in qualche modo che la propria identità, trasformata in un profilo, sia osservata e misurata. Accettando l’approvazione social anche della propria attività sociale, si accetta che questa possa essere misurata in base alle reazioni e al traffico che è capace di generare. Questo inevitabilmente crea delle trasformazioni. In un testo che si intitola Storia della fama (Effequ, 2025), Alessandro Lolli evidenzia questa trasformazione scrivendo che se nel Novecento cla domanda chiave era “che fare?”, oggi la domanda è “chi sono?”.
Anche nelle catastrofi umanitarie a cui stiamo assistendo, spesso gli operatori umanitari si espongono, ci mettono la faccia. Crede che sia un modo per mettersi in vetrina, o piuttosto sensibilizzare è parte dell’impegno, in quel confine sempre più sfumato che c’è tra volontariato e attivismo?
Nel romanzo ho provato a raccontare il meccanismo che si crea quando un’azione solidale diventa estetica, quindi merce, quindi monetizzabile, quindi performance, quindi spettacolo. E come può, una relazione di aiuto, generare consenso e contribuire alla costruzione strategica della propria immagine pubblica. Ogni azione solidale porta con sé una portata di complessità che non si può sciogliere a prescindere. Con i social network questo può essere amplificato soprattutto in un contesto comunicativo che, come è stato rilevato dalla sociologa Eva Illouz nel volume Modernità esplosiva (Einaudi, 2025), sta creando un tipo di società basata su un intenso sviluppo delle emozioni, che porta con sé una condizione di eccitazione permanente. Avere a che fare con il bene delle persone, anche in situazioni di guerra, e poter generare contenuti altamente emozionali con una bassa soglia di conoscenze tecnologiche, in alcuni casi, può essere piegato al bisogno di approvazione, che è comunque connaturato con l’umano. Per questo penso sia importante il ruolo dell’organizzazione, delle associazioni che, attraverso percorsi di costruzione di senso partecipato, possano de-individualizzare l’azione solidale.

Raccontare “il bene” che si fa, anche attraverso gli strumenti digitali, può essere una forma di esibizionismo oppure una forma di informazione e sensibilizzazione. Dove sta il confine?
È una questione sulla quale si dibatte dai tempi di Sant’Agostino, che nel IV secolo aveva individuato questo vizio di forma del bene una volta che è reso pubblico: una dinamica morale che esiste da sempre. Scriveva Sant’Agostino che «le parole che risuonano sulle nostre labbra e le azioni che sono alla vista di tutti presentano una pericolosissima tentazione rampollante da quella bramosia di essere lodati che va raccogliendo o mendicando approvazioni per mettere in vista i nostri meriti personali». Nel romanzo ho provato a raccontare i meccanismi che stanno dietro a ciò che siamo disposti a fare per soddisfare il bisogno di ricevere attenzioni. Non so se ci sia un limite in un contesto comunicativo in cui, per sopravvivere, il singolo individuo deve piacere. E per piacere, deve rendersi tale da dover piacere.
Mattia, grazie a una disavventura, scopre un mondo. Secondo lei questo incontro lo trasforma, oppure lui continua ad essere semplicemente uno che “prende atto”?
Il protagonista del romanzo è uno che non sa di niente e che ha paura addirittura del sangue e mi interessava utilizzarlo come grimaldello per entrare in una delle tante associazioni di volontariato che in pochi conoscono. Lì incontra personaggi e si deve misurare con situazioni che lo trasformano perché gli fanno scoprire aspetti della sua personalità che lo costringono a mettersi al centro della sua stessa vita, con i suoi lati più oscuri. Lati che magari non ha mai riconosciuto suoi, come il suo essere un umano aspirazionale, che vuole piacere a tutti. Questo, inevitabilmente, lo porterà a un epilogo che ho scritto pensando all’episodio descritto da Lucio Della Seta, quando ricorda un rigattiere a Londra con un quadretto su cui è scritto: «Morto per aver voluto compiacere tutti».

A chi ha voluto dare voce nel tuo romanzo?
Ho provato a scrivere una narrazione che restituisca un po’ della complessità, delle contraddizioni, delle ossessioni che, attraverso la varietà dei personaggi del romanzo, sono all’interno dell’altruismo organizzato. Ma dall’altra parte ho cercato di dare voce a chi ogni giorno entra nelle case delle persone, attraverso vere interviste agli operatori e alle operatrici che raramente vengono raccontate. Voci che dicono: «Nelle case c’è gente talmente sola che si farebbe arrestare o ricoverare», oppure «Sai qual è il miglior favore che puoi fare a un paziente incidentato? Dire alla moglie che non hai trovato il telefono». Sono partito dalle loro voci e da alcuni dati di realtà, come indicato nelle note sulle violenze in aumento sugli operatori sanitari, per poi esasperare il tutto al servizio dell’invenzione, o dell’invenzione di un presagio.
Se hai un abbonamento leggi subito Volontario, perché lo fai? e grazie per il tuo sostegno. Se vuoi abbonarti puoi farlo a questo link.
Fotografie fornite da Andrea Cardoni
L'articolo Volontariato: la parte migliore del Paese o narcisisti del bene? proviene da Vita.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0

































![Mondiale Rally. LIVE! Ecco la Ypsilon Rally2 HF Integrale [VIDEO]](https://img.stcrm.it/images/47903459/1200x/lancia-ypsilon-hf-integrale-2.jpg)




























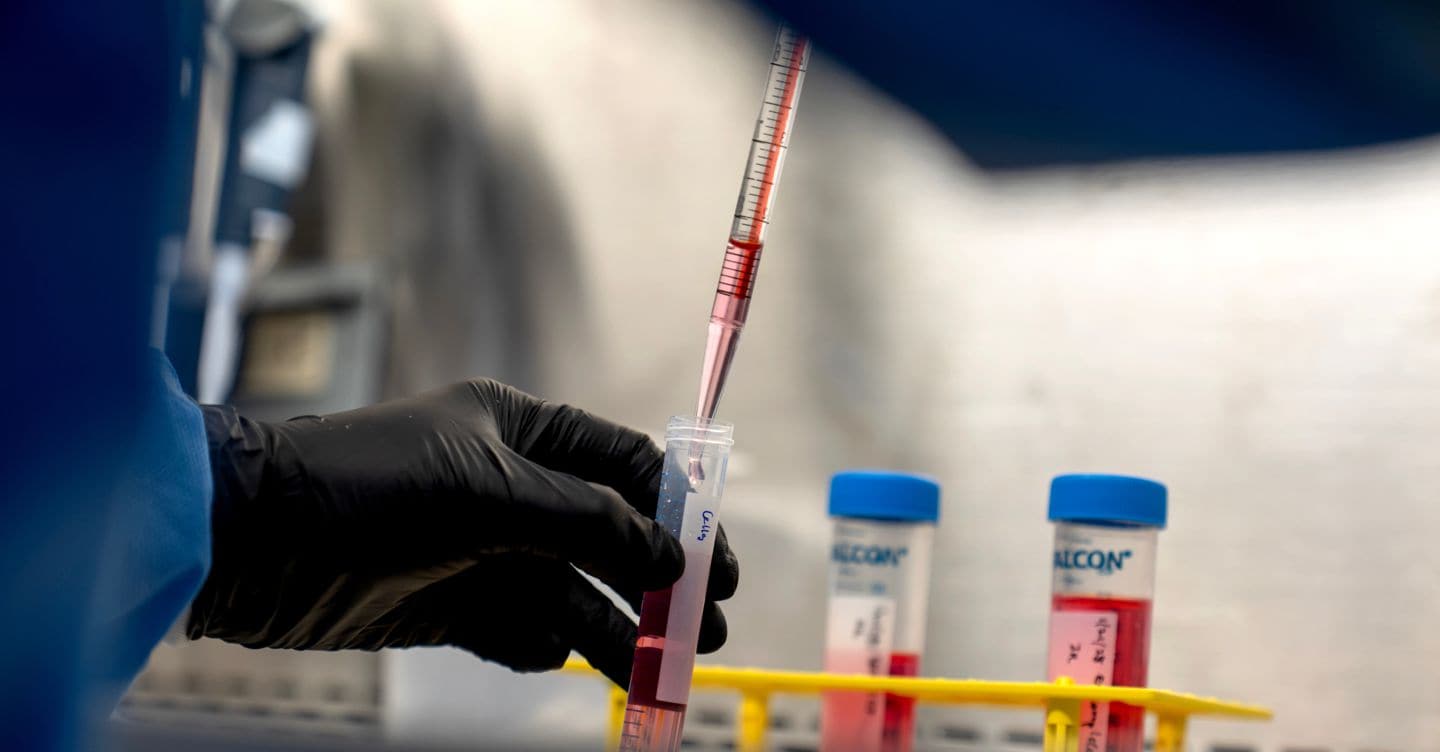




















/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/11/trade-republic-conto-canone-zero-offre-2-percento-liquidita.jpg)










































































































-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)





















































