Delpini in Bocconi: «Dobbiamo scegliere se vivere nella relazione o nella solitudine»

 Da sinistra, Marta Cartabia, Fabio Mercorio, Francesco Billari e monsignor Mario Delpini (foto Andrea Cherchi)
Da sinistra, Marta Cartabia, Fabio Mercorio, Francesco Billari e monsignor Mario Delpini (foto Andrea Cherchi)Un incontro atteso, preparato con cura dagli studenti con un titolo attrattivo e allusivo, «What was (A)I made for», ispirato all’omonima canzone di Billie Eilish e che gioca sul doppio significato di “I” e “AI”. È quello che si è svolto presso l’Università Bocconi, in una gremita aula “Franceschi”, con la partecipazione dell’Arcivescovo. In precedenza la Messa da lui presieduta nella chiesa San Ferdinando dell’Ateneo, per i docenti e il personale scomparsi nello scorso anno accademico, concelebrata dal vicario episcopale di settore don Giuseppe Como, dal responsabile della Pastorale universitaria don Marco Cianci, dal cappellano della Bocconi don Pierpaolo Zannini e da altri sacerdoti; erano presenti, tra gli altri, il rettore Francesco Billari e Mario Monti, Rettore emerito e già Presidente del Consiglio dei Ministri.

Una semplice, ma partecipata benedizione del moderno e funzionale spazio interreligioso contiguo alla Rettoria ha preceduto il momento di riflessione dedicato all’intelligenza artificiale e comunità e affidato, in un interessante dialogo tra studenti e relatori, a monsignor Delpini, a Marta Cartabia, presidente della Corte costituzionale, in passato Guardasigilli e docente in Bocconi, al rettore Billari e al professor Fabio Mercorio, direttore del master in AI e Data Analytics dell’Università Bicocca.

Intelligenza artificiale e comunità
Il punto di partenza dell’incontro – «fortemente voluto dalla Pastorale universitaria e che si inserisce nel contesto delle sue iniziative», come ha spiegato in apertura don Cianci – è stata l’analisi delle potenzialità di uno strumento come l’AI (innegabili) come pure la domanda sulla sua utilità, in riferimento al doloroso suicidio del sedicenne californiano Adam Raine, isolatosi da mesi in un solitario dialogo con ChatGPT. Ma soprattutto, considerando che tra i maggiori utilizzi dell’AI generativa nel 2025 vi sono gli ambiti della terapia e dell’amicizia al primo posto, dell’organizzazione della giornata al secondo e del trovare uno scopo al terzo. Così come è emerso da una ricerca dell’Harward Business Review, che ha incuriosito e sorpreso il mondo accademico internazionale.
«L’Intelligenza artificiale non è programmata, ma addestrata, le si mostra la realtà e la riesegue con un obiettivo. L’evoluzione tecnologica ci ha reso necessario avere qualcosa che ripropone i dati a disposizione con una decodificazione generativa di contenuti», ha subito detto Mercorio, indicando come l’Intelligenza artificiale «usi il criterio della probabilità per approssimare un ragionamento, mentre il criterio che guida l’essere umano è solo parzialmente la probabilità».
«L’AI è un fenomeno che interroga tutti perché accompagna, ormai, la nostra quotidianità – ha sottolineato Cartabia -, ma una prima domanda che sorge è che mondo abbiamo generato e cosa c’è intorno ai ragazzi che, per trovare un’amicizia, si rifugiano nel dialogo con una macchina. Se questo accade, l’interrogativo deve essere più complessivo, anche perché così si stanno affidando alle macchine compiti a cui esse non possono dare risposta, poiché implicano l’umanità, la relazione, l’alternativa. La questione più urgente da affrontare è educarsi e istruirsi su come utilizzare in concreto l’IA, sapendo cosa possiamo chiederle e cosa no. Occorre un investimento enorme per comprendere i rischi e capire dove stanno i pericoli: servono le regole. Davanti a noi abbiamo tre strade: l’americana – tutto è possibile, il modo si corregge da solo -, la via cinese – lo Stato che controlla tutto – e l’approccio europeo che prevede la libertà, ma appunto con delle regole. Per esempio, nel mondo della giustizia ci sono casi che mai si possono lasciare in mano all’IA e, dunque, le regole sono utili per mantenere la persona al centro: una verità che in Europa tiene ancora, mentre sta crollando in altre parti del mondo», ha concluso la giurista, che si è definita «fieramente europea».

L’intervento dell’Arcivescovo
Articolato e particolarmente approfondito l’intervento dell’Arcivescovo: «Azzardo una distinzione terminologica tra strumento e mezzo, dove il primo termine significa una risorsa che l’individuo usa per fare qualcosa e che, quindi, è un modo di abitare il mondo in funzione utilitaristica, con la solitudine della persona che usa strumenti per ottenere degli scopi. Io vorrei parlare, invece, dei mezzi che sono “una strada per”, una modalità che non mette in evidenza la solitudine, ma la dinamica relazionale e che, dunque, utilizza le cose non come uno strumento per se stesso, ma come una via. Questo ci dice che siamo di fronte a delle scelte, non viviamo dentro a un ingranaggio, ma siamo gente che deve scegliere. La persona consapevole di sé decide se vivere nella relazione o nella solitudine».
Il richiamo è al pensiero occidentale che «ha elaborato l’idea della persona a partire dal fatto che vi sia in essa un principio di libertà, di amore e di conoscenza, mentre il tempo che stiamo vivendo rischia di ridurre la persona a individuo, costruendo il mondo intorno alla sua solitudine con una macchina che può essere seducente perché convince che l’uomo basta a se stesso».
La spiritualità e le macchine
In risposta alla domanda degli studenti «se la spiritualità possa aiutare di fronte a queste sfide», l’Arcivescovo ha aggiunto: «La spiritualità può essere, talvolta, un analgesico, una cura palliativa della solitudine per gente che si sente schiacciata da un mondo cattivo, mentre invece è un’apertura al mistero che si lascia amare e incontrare dalla verità da cui veniamo e verso cui andiamo. La spiritualità è un modo di vivere come persone che si vogliono bene, che si incoraggiano, che si consolano, che edificano una società in cui sia desiderabile abitare. Umanizzare l’intelligenza artificiale (come ha detto recentemente papa Leone) è importante e interessante, ma pare mettere di fronte a un pericolo da cui difendersi, mentre dobbiamo approcciarla come uno strumento che può condurre a risultati straordinari, ma che non può consolarci, abbracciarci. Qui sta il punto».
La responsabilità verso i giovani
Poi, un secondo giro di domande ai relatori sulla loro responsabilità verso i giovani, nate da diversi incontri «davanti a Coca cola e patatine» dei ragazzi di 10 associazioni diverse presenti in Bocconi.
«Noi ci aspettiamo la verità dall’IA e arriva la verosimiglianza, attendiamo la coscienza e otteniamo il calcolo, cerchiamo la compagnia e abbiamo l’engagement. Quindi, la responsabilità è cercare la verità che lega tutte le cose della vita e comunicarla agli altri. La responsabilità sta a voi, ragazzi, perché sarà la vostra generazione a guidare l’evoluzione dell’IA», scandisce Mercorio, cui fanno eco Cartabia e Delpini, evidenziando il valore del dialogo tra persone reali,.
«La responsabilità ha al suo centro la libertà – dice l’Arcivescovo – . La mia idea di persona ha, tra le sue componenti, appunto questo. Il compito del prete, del vescovo è quello di tenere acceso il fuoco, un luogo dove ci si possa radunare per scaldarci, anche se c’è vento e pioggia. Non è un giudizio, una pretesa, ma un’offerta. I giovani possono contribuire affinché non vi sa un vuoto esistenziale drammatico e, per questo, propongo tre parole. Il buon vicinato, dicendo che gli altri mi interessano; la conversazione che vuol dire parlare, non per indottrinare o semplicemente per fare chiacchere, ma per ragionare e dire cose serie e, infine, l’intercessione, cioè il prendersi cura degli altri fino a pregare per loro. Così si costruisce anche una dinamica universitaria costruttiva».

Infine, a suggellare la serata sono stati Oreste Pollicino, giurista e docente in Bocconi di Regolamentazione dell’Intelligenza artificiale e il rettore Billari.
«Il tema della disinformazione è aumentato dall’IA e vi è una progressiva erosione del pensiero critico – ha osservato il docente -. L’Università può agire per non scivolare in un pensiero sempre più distopico e la Bocconi fa molto su questo con la ricerca, la didattica e la sua terza missione. L’IA non è la fine del pensiero se l’Università si pone e agisce come un luogo di resistenza cognitiva, collegando conoscenza e responsabilità».
«Il pericolo è non avere i campus, i luoghi dove incontrarci, come abbiamo visto con il Covid, per cui l’Università deve diventare una comunità sempre più fisica e relazionale che segni per un certo periodo la vita di una persona, insegnando una ricerca di senso che dura l’intera esistenza», termina Billari, richiamando il fatto che l’incontro si sia tenuto all’interno delle “Settimane dell’inclusione” promosse da un Ateneo che vede la presenza di studenti che vengono da tutto il mondo. «Se ciascuno stesse nella sua stanzetta non avremmo questa comunità meravigliosa che mi emoziona sempre. Oltre le tre parole suggerite dall’Arcivescovo vorrei aggiungerne una quarta: essere ambiziosi, alzare l’asticella, ma contribuendo al progresso come una comunità che, grazie alle diversità, tira fuori il meglio di sé».
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0





























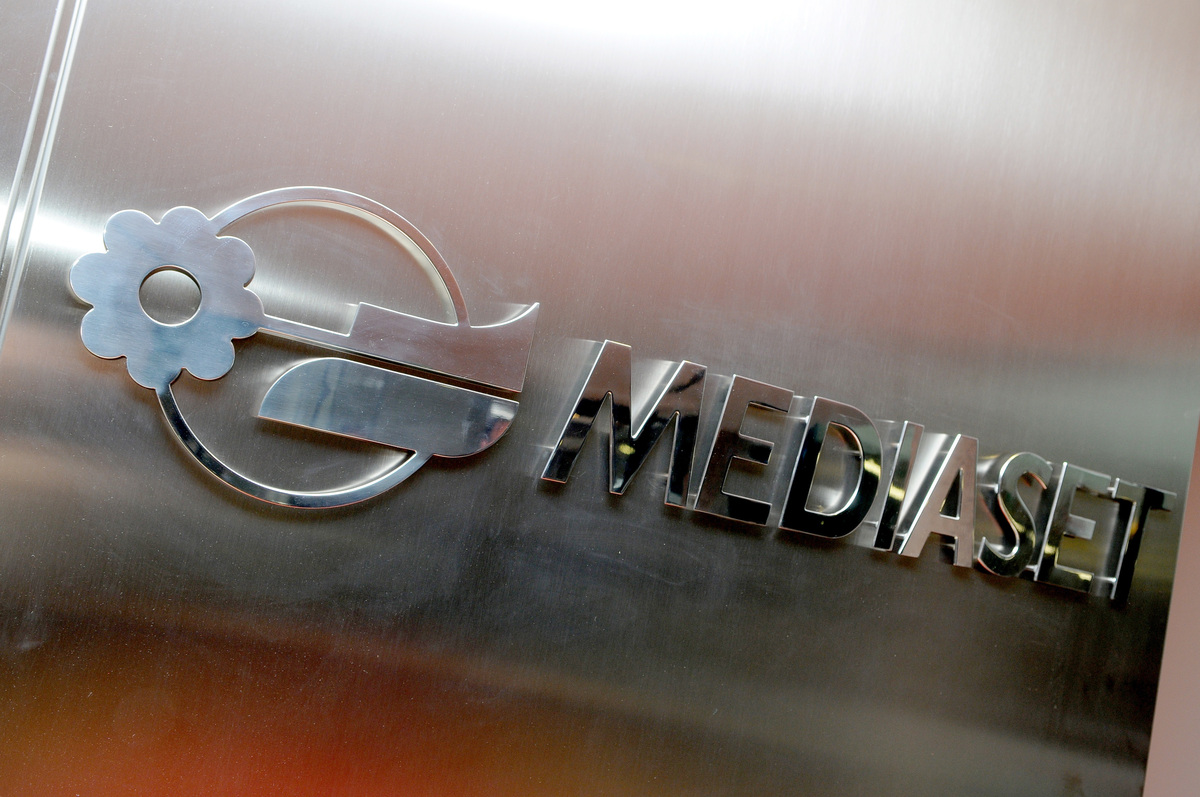



























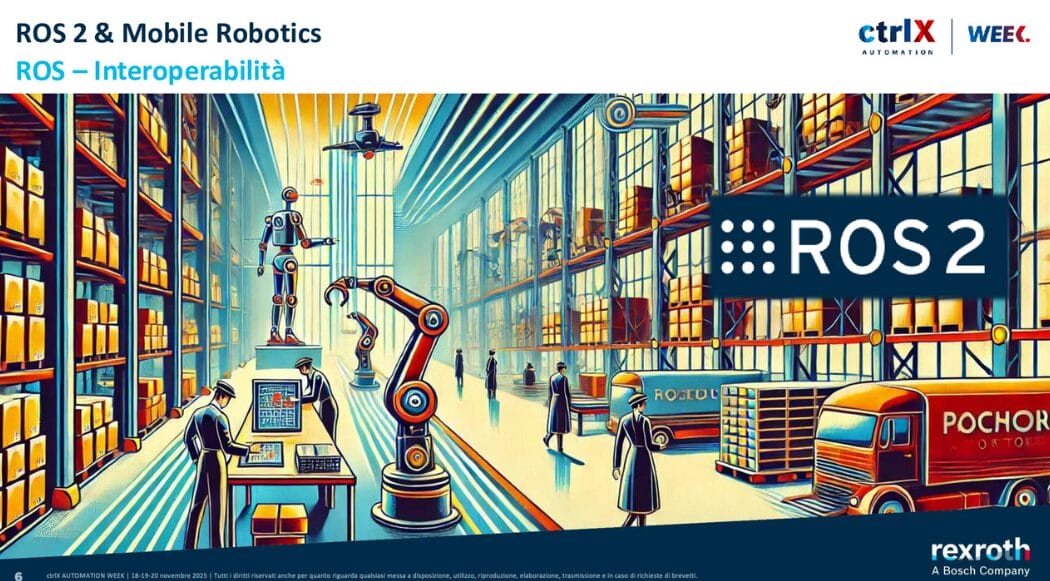











































































































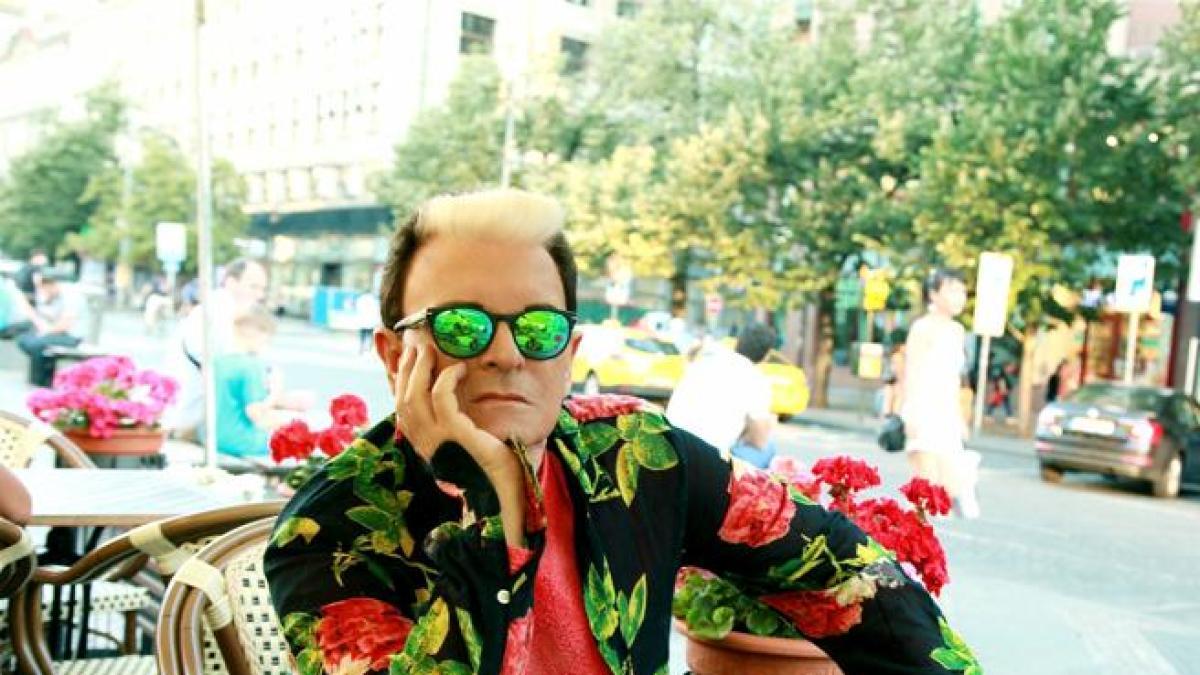

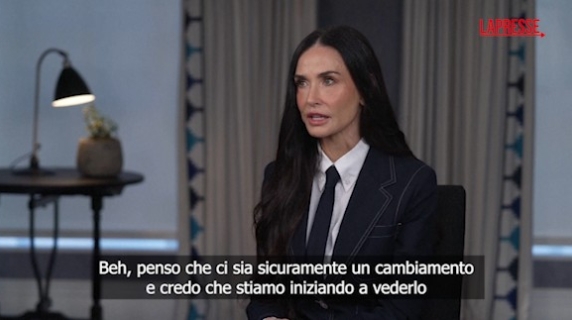




















-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)















































































