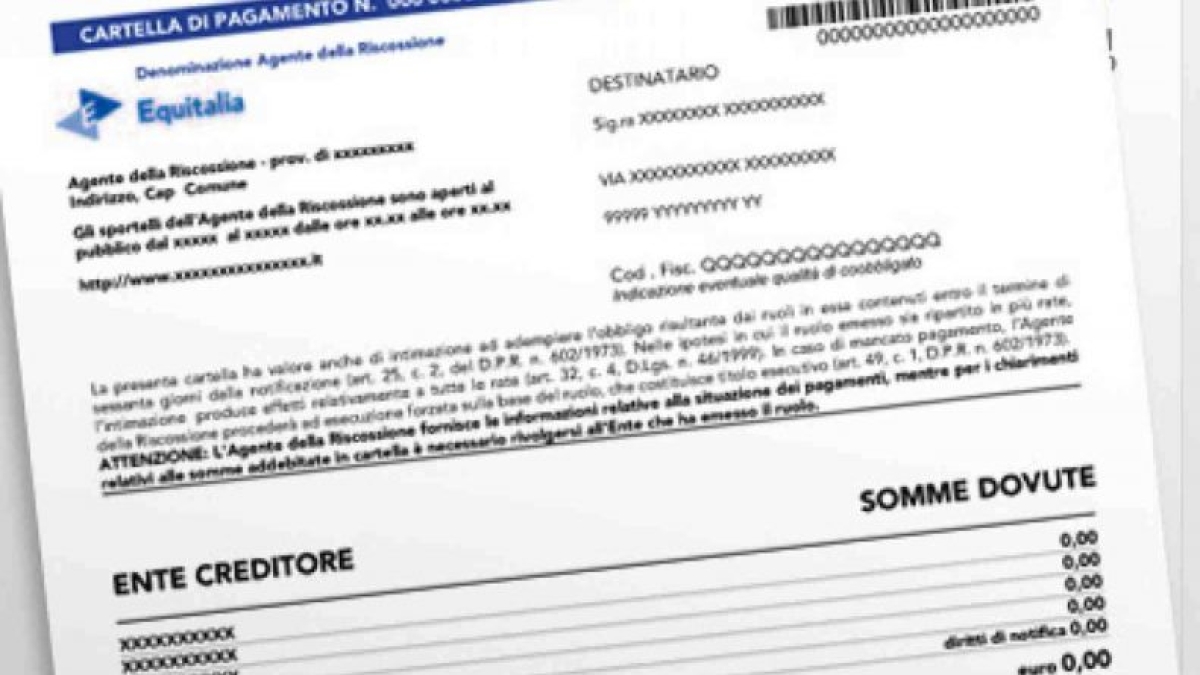Il caso del generale Oresta, rimosso per il discorso “prima la salute, poi il lavoro”. Si può fare?

lentepubblica.it
Sta facendo molto discutere il caso del generale Pietro Oresta, rimosso a seguito di un discorso agli allievi della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze: il succo era di mettere davanti allo stress del lavoro la propria salute mentale. Discorso che deve essere piaciuto poco ai suoi superiori. Ma è legittimo rimuovere una carica pubblica per una riflessione che appare semplicemente di buon senso?
Una questione che ci costringe a guardare in faccia una realtà che fa paura: quella in cui l’umanità è trattata come debolezza, e la salute mentale come un argomento tabù.
Ma se non si può nemmeno parlare del benessere di chi ogni giorno rischia la vita per garantire la sicurezza di tutti, allora siamo di fronte a un cortocircuito.
La domanda “si può fare?” non riguarda più solo un discorso, ma il futuro stesso delle istituzioni. Perché senza persone sane, motivate e ascoltate, nessuna divisa può reggere il peso del proprio simbolo.
Scopriamo dunque nel dettaglio come è andata e perché questa decisione è stata presa, riflettendo anche sulle implicazioni che comporta.
Il caso del generale Oresta, rimosso per il discorso “prima la salute, poi il lavoro”.
“Ricordatevi che il vostro benessere e quello dei vostri familiari è superiore a qualunque istruzione o procedura”. Una frase semplice, umana, pronunciata da un ufficiale dell’Arma durante un discorso rivolto ai futuri marescialli.
Qui di seguito il momento saliente del discorso.
Parole che in un contesto ideale dovrebbero aprire un dibattito costruttivo sulla salute mentale nei corpi dello Stato. E invece, per questo intervento fuori dai canoni, il generale Pietro Oresta è stato rimosso dal suo incarico. Il gesto, tanto eloquente quanto silenzioso, lascia una domanda inevasa: si può davvero parlare di benessere psicologico nelle forze dell’ordine? E soprattutto, chi può farlo senza pagarne il prezzo?
Salute mentale e uniformi: un tabù che scotta
Nel suo intervento, Oresta ha osato toccare una zona grigia, troppo spesso ignorata o minimizzata: quella del disagio psicologico di chi indossa una divisa. Le sue parole, lungi dall’essere sovversive, si muovevano su un terreno di evidente attualità. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, i disturbi psicologici tra i giovani sono più che raddoppiati dopo la pandemia da Covid-19.
E questi giovani, oggi, entrano nei ranghi delle forze armate e di polizia, portandosi dietro ansie, pressioni e fragilità che non possono essere spazzate via con il rigore di un regolamento.
In un contesto in cui lo stress lavorativo si somma alla tensione operativa, ignorare il fattore umano è una scelta miope. Secondo il sindacato Unarma, tra gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri si registrano livelli allarmanti di disagio mentale, con episodi di burnout e suicidi che non sono più isolati, ma sintomi di un sistema che chiede silenzio e prestazione, e in cambio offre poca comprensione.
Il paradosso: “umanità” sotto accusa
Il discorso del generale, definito da molti come “fuori protocollo”, ha toccato temi cruciali: il diritto alla cura di sé, il rispetto della propria salute, l’invito a non sacrificarsi in nome di un dovere malinteso. Un invito al discernimento etico, alla priorità della vita umana sulla cieca obbedienza. Ma è proprio questa visione, più empatica e moderna, a risultare indigesta a una cultura istituzionale ancora rigidamente gerarchica, che teme ogni deviazione dal paradigma della disciplina assoluta.
Il problema non è soltanto culturale. È anche giuridico. In Italia, infatti, la rimozione da un incarico all’interno delle forze armate può avvenire per motivi discrezionali da parte del comando superiore, in base ai poteri di organizzazione sanciti dall’articolo 97 della Costituzione, secondo cui l’amministrazione pubblica deve agire con buon andamento e imparzialità. Tuttavia, la mancanza di motivazioni trasparenti e la natura punitiva del provvedimento nei confronti di chi solleva questioni di benessere solleva dubbi di legittimità e opportunità.
La normativa di riferimento è contenuta nel D.P.R. 90/2010, “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”, che consente al vertice gerarchico ampi margini d’intervento in caso di presunto scostamento dal comportamento atteso. Tuttavia, come evidenziano i giuristi del settore militare, ogni provvedimento disciplinare o di rimozione dovrebbe essere motivato e proporzionato, anche nel rispetto dell’articolo 3 della Costituzione, che sancisce il principio di uguaglianza e ragionevolezza dell’azione amministrativa.
Le parole che non si possono dire
Alla luce di tutto questo, la domanda torna insistente: si può fare? Si può parlare di salute mentale in caserma, senza rischiare di essere messi alla porta? La risposta, al momento, sembra essere negativa. In un sistema ancora permeato da una cultura del sacrificio estremo e della performance senza cedimenti, chi invoca l’umanità viene percepito come un elemento destabilizzante.
Eppure, è proprio questo modello a mostrarsi ormai insostenibile. L’incremento delle richieste di supporto psicologico, i casi di suicidio tra i militari e il ricorso ai congedi straordinari per motivi di salute mentale raccontano una realtà ben diversa da quella idealizzata. Il silenzio imposto a chi prova a rompere il muro del conformismo non fa che aggravare la frattura.
Una svolta necessaria (e possibile)
Per affrontare seriamente il problema, non basta lo sdegno. Serve un ripensamento sistemico, anche normativo. Alcuni passi sono stati avviati: il Piano Nazionale di Prevenzione del Suicidio nelle Forze Armate, previsto dal Ministero della Difesa e rinnovato con circolari interne dal 2022, punta a rafforzare il supporto psicologico, ma resta confinato a interventi ex post, non a una prevenzione culturale.
Servirebbe invece una riforma organica che garantisca:
- la presenza obbligatoria di sportelli di ascolto psicologico indipendenti in ogni struttura militare;
- la formazione specifica sul benessere psico-fisico per i comandanti;
- la tutela legale per chi, come Oresta, richiama alla centralità della persona.
The post Il caso del generale Oresta, rimosso per il discorso “prima la salute, poi il lavoro”. Si può fare? appeared first on lentepubblica.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0












































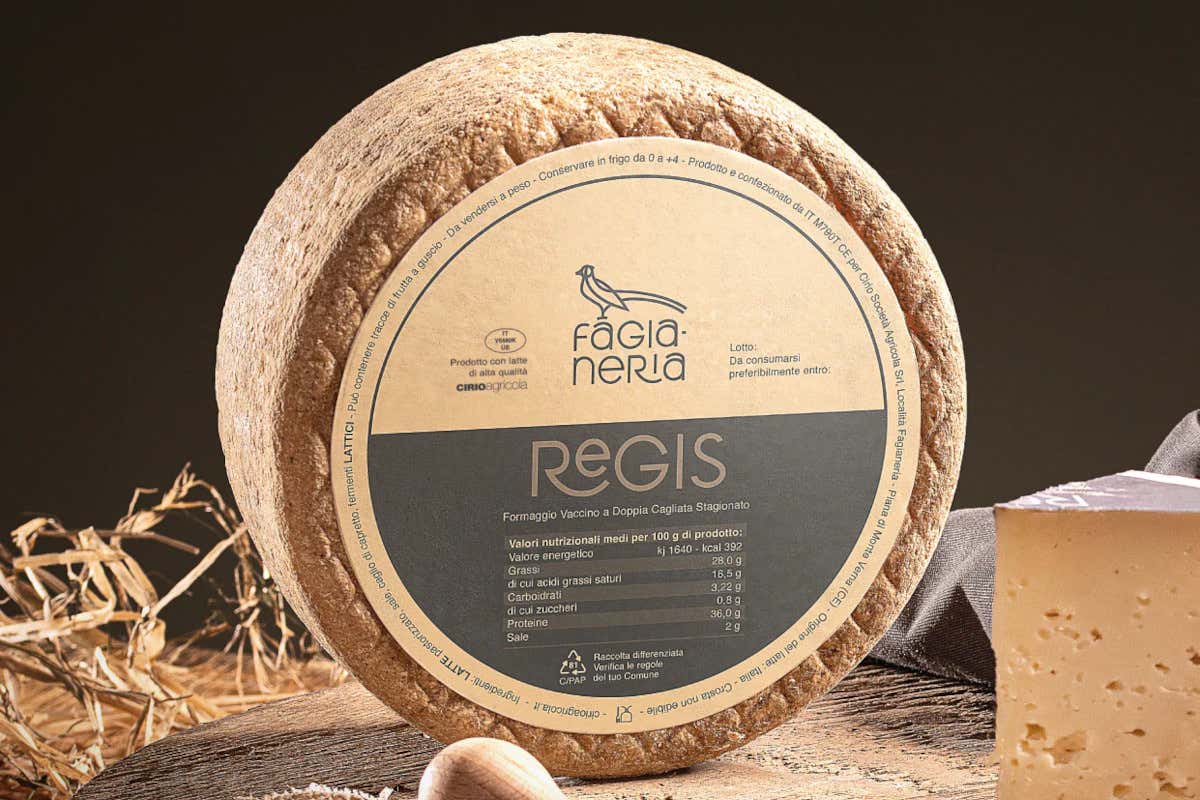



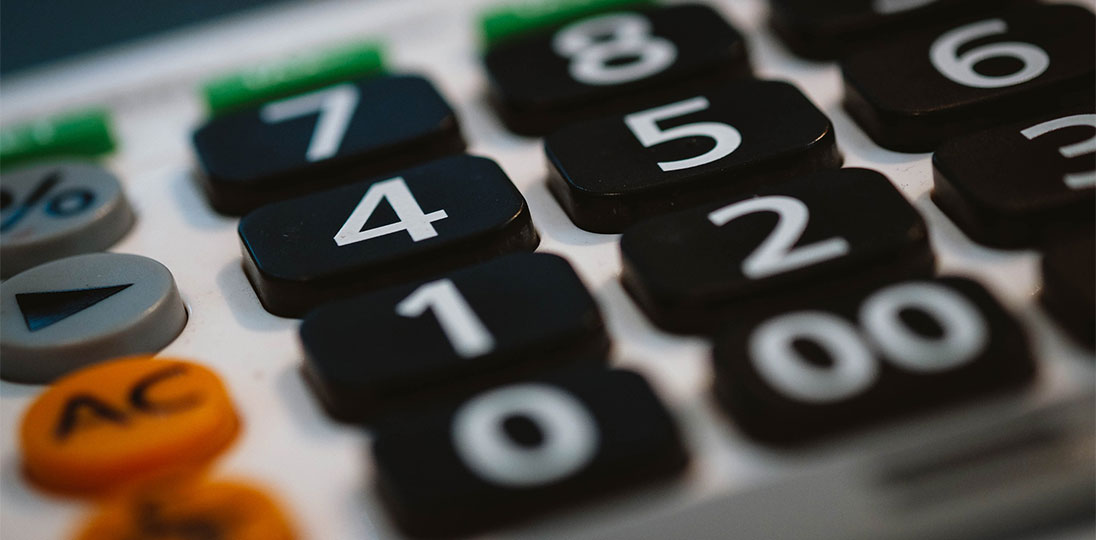















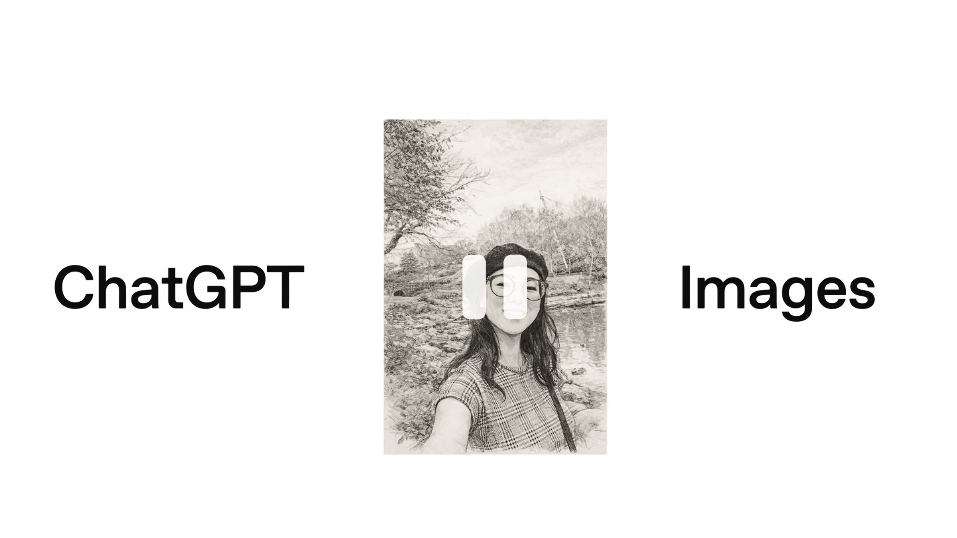


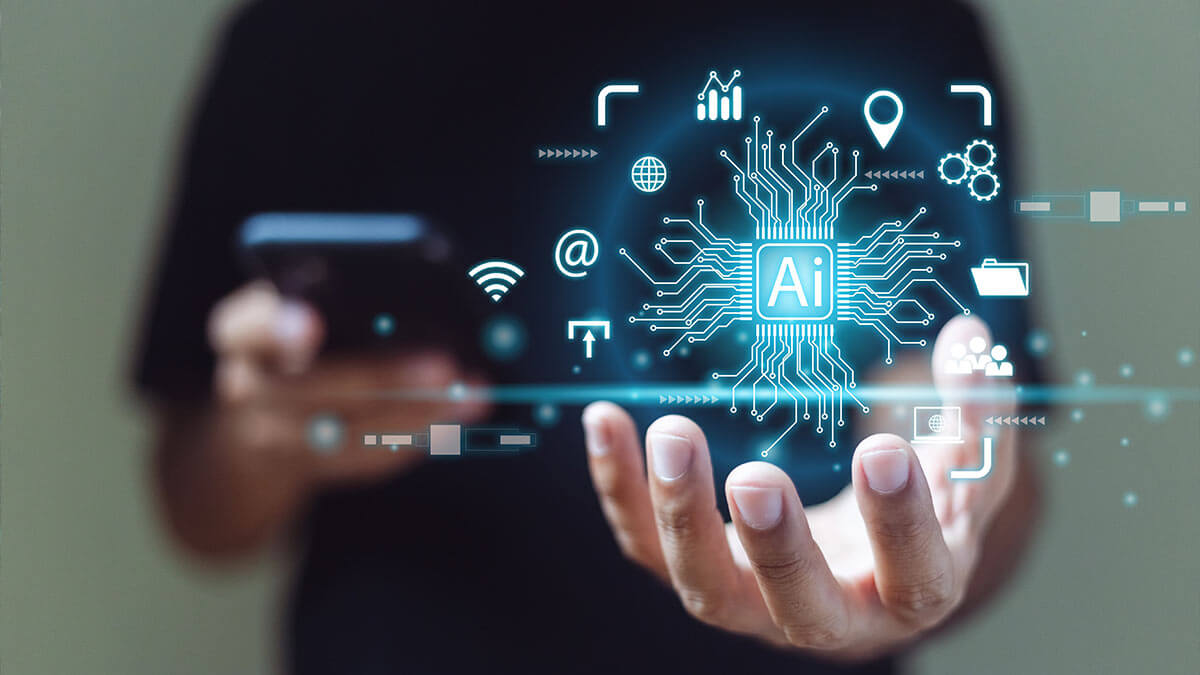



















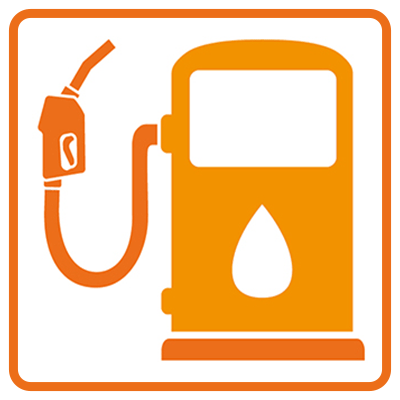


































































































_(50)-1765960548246.jpg--tamponamento_tra_due_auto_sulla_provinciale_che_collega_castellamonte_a_cuorgne__grande_spavento_e_lievi_contusioni_per_i_conducenti.jpg?1765960548409#)






-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)