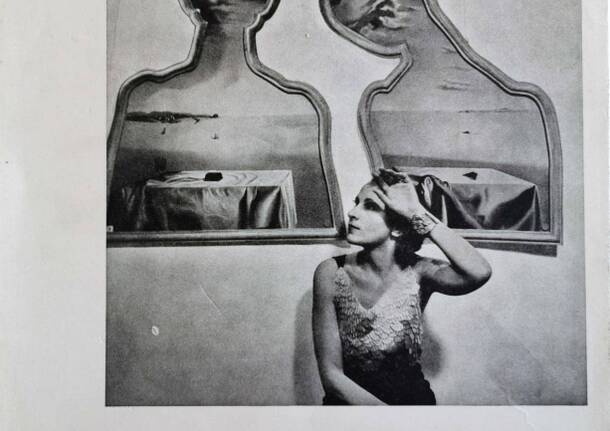La separazione delle carriere (contro gli slogan): perché il divorzio tra pm e giudici non è contro la Costituzione

A volte è necessario scrivere di fenomeni che riguardano la nostra società senza perseguire fini scientifici, facendolo per far conoscere il proprio pensiero su argomenti che, solo apparentemente, appartengono a un settore specialistico come quello del Disegno di legge di iniziativa governativa per la riforma del Titolo IV della Costituzione, che per i più tratta della separazione delle carriere del Giudice da quella del P.M.
Una proposta nevralgica, seppur non risolutiva, per un’ineludibile miglioramento del servizio della giustizia penale, che deve essere sostenuto anzitutto da coloro che hanno una visione progressista della società, più sensibili di altri ai temi della giustizia e alle preoccupanti conseguenze che derivano dai risultati di un sondaggio condotto da Alessandra Ghisleri per LA7, secondo il quale “Gli italiani hanno paura della giustizia”, nonché dal giudizio critico di Antonio Polito, scritto su Il Corriere del Mezzogiorno, ispirato ai dati pubblicati dal Ministero della Giustizia per i quali dal 2018 al 2024, lo Stato ha speso 220 milioni di euro per riparazioni di ingiusta custodia cautelare in carcere, subita da indagati e imputati. I dati e i giudizi riportati sono un pericoloso segno di sfiducia del Popolo verso un’istituzione costituzionale indispensabile che, per poter adempiere al meglio il proprio ruolo, deve assicurare sostanzialmente i diritti di libertà ed eguaglianza per poter godere della fiducia incrollabile di tutti.
Eppure, davanti all’evidenza che più di qualcosa nel sistema penale non funziona, non mancano persone autorevoli, impegnate in diversi modi nel mondo della cultura, dalla letteratura allo spettacolo, che si dichiarano contrarie alla separazione delle carriere, basando le proprie convinzioni sul senso comune, anche se infondato, e su massime di esperienza alle quali ricorrono per giustificare decisioni intuitive e dipendenti da suggerimenti o suggestioni che provengono da altri, associandosi così al più comodo conservatorismo mentale. La loro non è altro che una manifestazione di “pensiero prevenuto”, alimentato da opinioni preconcette. C’è da dire che sulla separazione delle carriere, da oltre un secolo, si è detto e scritto molto, facendolo, gli sfavorevoli, con l’uso di slogan che, propagandosi sino all’infinito – affinché “anche l’ultima persona, arrivi a coglierne l’idea” -, comportano una semplificazione condivisa del rischio, giungendo a quel giudizio affrettato che è proprio delle “affermazioni categoriche”, fatte da chi, nel pubblico, dà l’impressione di sapere cosa sta dicendo, generando quella che i neuroscienziati chiamano “fenomeno della verità illusoria”. Gli elementi che caratterizzano questo fenomeno ci sono tutti: leader riconosciuti e autorevoli; un avversario che, con le sue proposte, appaia di volta in volta un pericolo concreto; l’uso di slogan che prefigurano scenari tragici; la ripetizione continua di questi detti; una condizione di tribalismo da parte dei maggiori organi di informazione.
La realtà, invece, è ben diversa e si svela solo attraverso il ragionamento logico e con la matura conoscenza delle dinamiche processuali e storico-politiche che riguardano l’argomento. Non potendo immaginare che quanti sono contrari alla separazione delle carrier, ignorino il substrato storico-culturale nel quale si è formata e alimentata l’attuale proposta di riforma costituzionale, devo dedurne che le loro affermazioni siano una manifestazione di slealtà istituzionale, con l’obiettivo, da una parte, di continuare ad assicurare il potere che i Padri costituenti non intendevano attribuire, dall’altra, seguitare a fungere da ipocrite ancelle, ossequiose di quell’Ordine, peraltro senza più ritrovarsi con la propria tradizione politica. Ciò avviene a danno della giurisdizione penale, ispirata costituzionalmente a un giudice rispettoso della legge, terzo e imparziale. L’obiettivo che qui mi propongo, dunque, è di provare a disabituare il cittadino dagli effetti che derivano da questo continuo stillicidio di affermazioni persuasive, ma irreali.
Da autorevoli personalità che stabilmente occupano le pagine dei giornali e i salotti televisivi, sentiamo ripetere che:
A) “Questa riforma è un attentato alla Costituzione… che essa nasconde il vero scopo del Governo che vuole sottoporre i PM alle sue dipendenze o a quelle del ministro della Giustizia”. Una “rottura con la Costituzione”, in questo caso, è davvero impensabile: il nuovo testo è all’esame del Parlamento, ed è trattato con la procedura prevista dall’art. 138 della Costituzione. D’altronde sulla legittimità della separazione delle carriere dei magistrati e della sua compatibilità anche con l’attuale testo costituzionale, si è incidentalmente espressa la stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 37 del 3-7 febbraio 2000 quando, dovendo giudicare sull’ammissibilità del referendum abrogativo dell’art. 190 comma 2 dell’Ordinamento Giudiziario, riguardo alla possibilità di passaggio delle funzioni requirenti a quelle giudicanti e viceversa, la Corte ha fatto due affermazioni di particolare interesse:
1) che quel quesito referendario non investiva le disposizioni il cui contenuto normativo essenziale fosse costituzionalmente vincolato, con la conseguenza che il referendum sulla materia era ammissibile;
2) che “La Costituzione, infatti, pur considerando la magistratura come un unico “ordine”, soggetto ai poteri dell’unico Consiglio Superiore, non contiene alcun principio che imponga o al contrario precluda la configurazione di una carriera unica o di carriere separate fra magistrati addetti rispettivamente alle funzioni giudicanti e a quelle requirenti…”.
Questo per dire che, salvo a voler considerare la stessa Corte eversiva dell’Ordine Costituzionale, lo slogan sbandierato è un atto irresponsabile. Anche l’altro argomento, quello della perdita di indipendenza e autonomia esterna del P.M., è ingannevole. Per dimostrarlo basta leggere il testo del disegno di legge costituzionale, dal quale si comprende che non sarà possibile in alcun modo sottoporre il P.M. al controllo o alla volontà dell’Esecutivo o a quella del Ministro della Giustizia. Piuttosto, è da dire che sul tema la storia della magistratura e la psicologia insegnano che il magistrato corra sempre questo rischio, ciò a prescindere dalle norme che lo garantiscono: il fenomeno delle c.d. “porte girevoli” è sotto gli occhi di tutti; come lo è il fatto che il pericolo dipenda dal cedimento morale dell’individuo a favore di chi, di volta in volta, detiene il potere: sono l’ambizione, l’amore per il proprio ego, il desiderio di successo, quei diversi fenomeni interiori che in vario modo offuscano il limite etico di una persona, a determinare il superamento di ogni regola scritta diretta a evitarne il rischio.
Lo sapeva bene anche Pietro Calamandrei quando scriveva che “bisogna altresì togliergli [al magistrato] ogni speranza che un atteggiamento servile ed inchinevole possa giovare alla sua carriera futura… se il nostro ordinamento giudiziario riesce a proteggere il giudice contro le vendette, non riesce a proteggerlo contro un’arma più insidiosa e più penetrante, cioè contro i favori dei governanti”. Questo condizionamento appartiene alla nostra storia recente, ma soprattutto è quanto accaduto durante il regime fascista, dove, a fulgidi esempi di indipendenza e autonomia della funzione, si sono accompagnate situazioni di spregevole asservimento: a magistrati che hanno ceduto alle chimere del potere perdendone l’autonomia, come quel Gaetano Azzolini che, proveniente dalla magistratura ordinaria, divenne Presidente del Tribunale della Razza e poi, caduto il regime, venne nominato primo presidente della Corte di Cassazione e, ancora dopo, Presidente della Corte Costituzionale, si contrapposero magistrati eroici.
Questi fecero valere quei limiti etici che derivano dalla responsabilità della funzione, alla quale adempirono con coraggio e onore: tra i molti, va ricordato Mauro Del Giudice che, indagando sull’omicidio del deputato Giacomo Matteotti, si rifiutò di accogliere le pressioni provenienti dal Partito unico e dai suoi stessi superiori, i quali pretendevano che l’omicidio volontario dell’esponente socialista venisse degradato a omicidio preterintenzionale. Menzionare questo luminoso e valoroso esempio di magistrato, con la sua autonomia e indipendenza interna ed esterna, è un dovere e va fatto riportando le sue parole, rese a verbale quando, caduto il fascismo, la vicenda giudiziaria che lo aveva visto protagonista si riaprì: “Allora gli dissi chiaro e aperto: che avevo capito ciò che si pretendeva da me e che io non mi sarei mai prestato a simili ribalderie, giacché alla infamia pubblica, io preferivo la persecuzione, la miseria, ed anche, occorrendo, la morte”.
Fine prima parte (Continua)
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0















































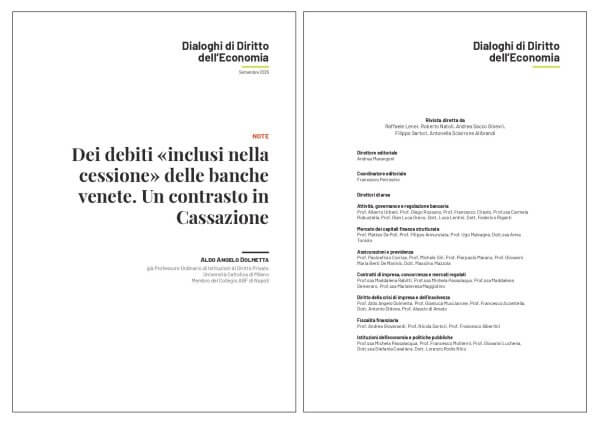
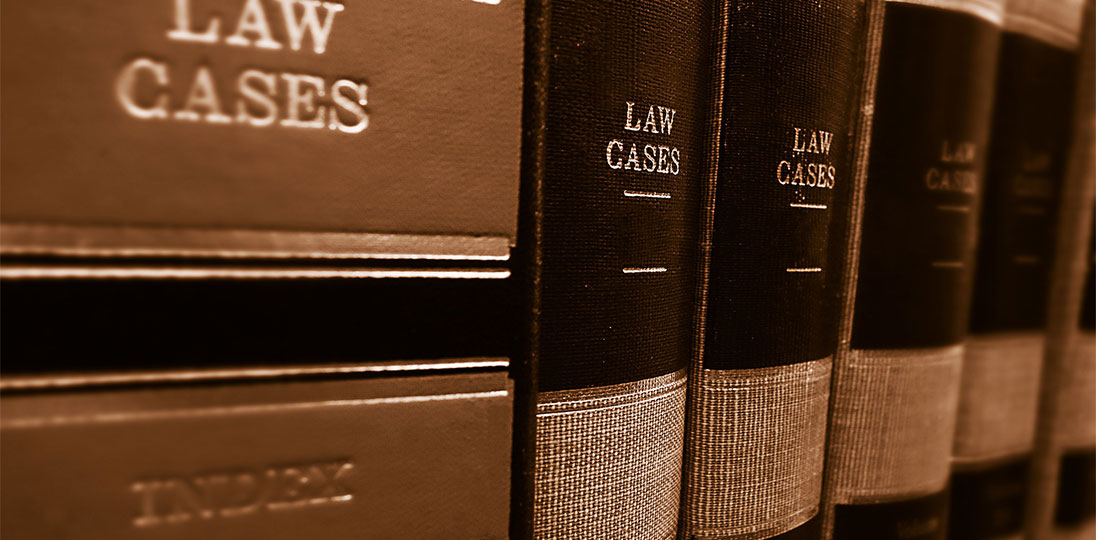



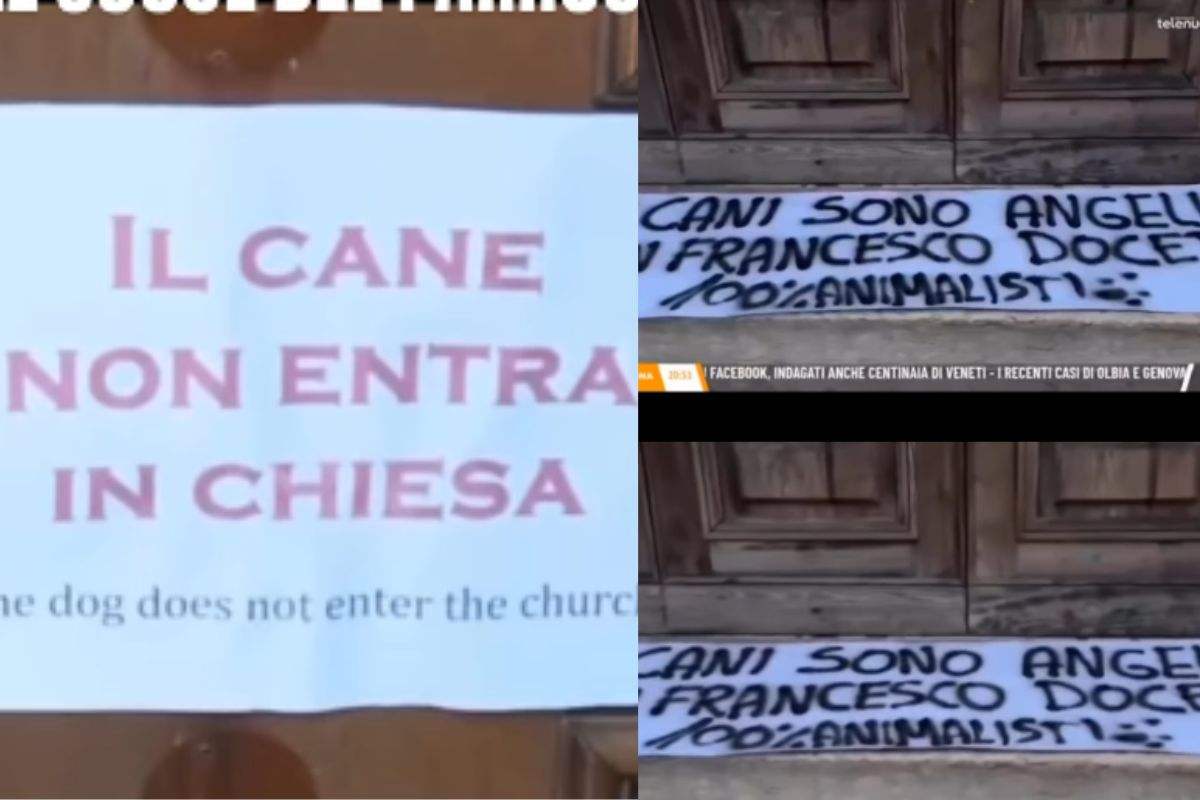

































/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/09/wp_drafter_181208.jpg)
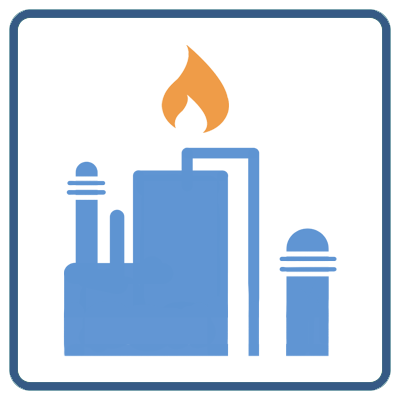


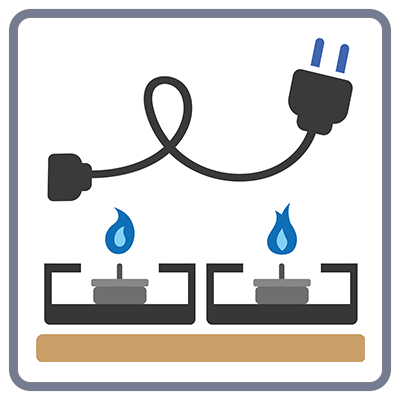


























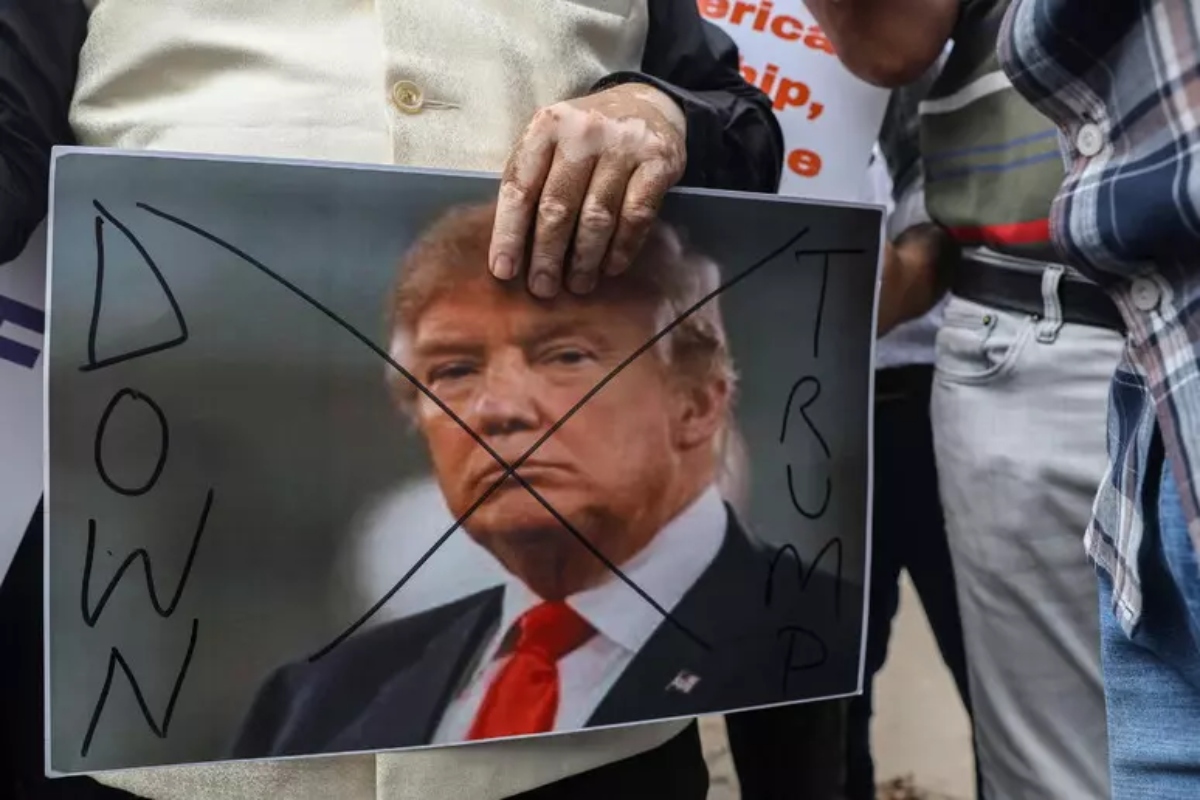





















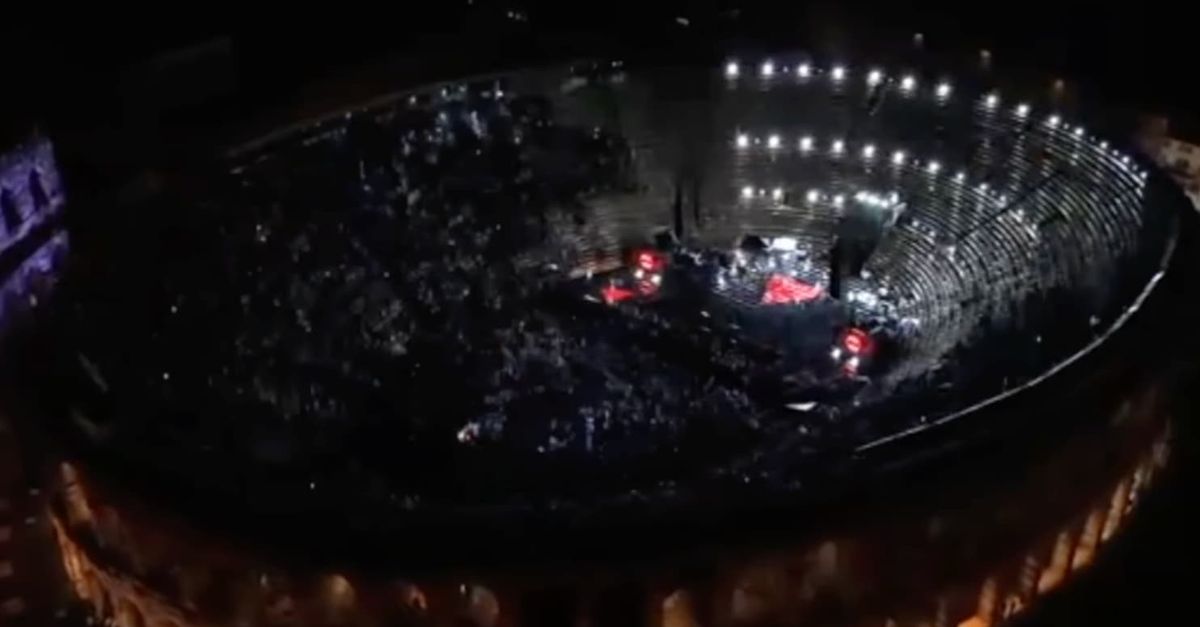






































%20Carole%20Bethuel.jpg)













-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)