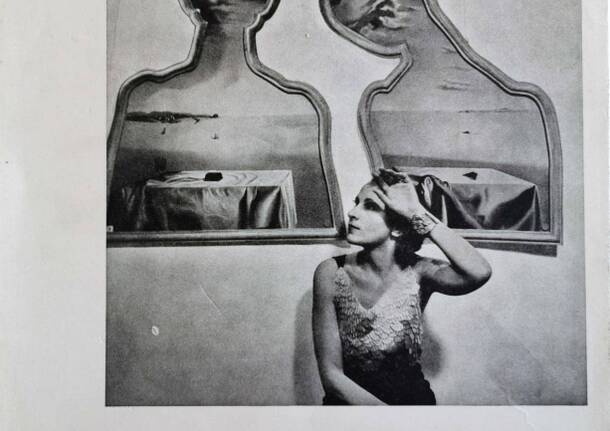Quando l’agricoltura si piega all’export, a pagare è sempre la terra


È buono ciò che ci fa stare bene o ciò che conviene vendere? La risposta sembra ovvia, ma nei campi di pomodori dell’Iran e tra le piantagioni di quinoa in Bolivia, le cose si fanno più complesse. La domanda estera trasforma paesaggi, ridefinisce abitudini alimentari, altera equilibri millenari. E quasi mai si chiede quanto potrà durare.
Secondo un’indagine di The Economist, l’Iran ha sviluppato negli ultimi anni una rete occulta di esportazione di frutta e ortaggi verso gli Emirati Arabi Uniti. Si tratta di un commercio che aggira le sanzioni internazionali, ma anche le regole del buon senso ambientale: per garantire angurie, pomodori e cavolfiori a basso costo nei mercati di Sharjah e Dubai, il paese sta letteralmente svuotando le proprie riserve idriche sotterranee.
Il risultato è devastante. Bacini come Amir Kabir, Lar e Latyan sono ridotti a meno del dieci per cento della capacità. A Teheran il terreno sprofonda fino a 25 centimetri all’anno per effetto della subsidenza. Eppure, il flusso non si arresta: il denaro dell’export alimentare è troppo prezioso in un paese soggetto a sanzioni e inflazione. Così, sulle bancarelle di Al Aweer a Dubai si vendono cassette d’ortaggi iraniani etichettati come turchi o azeri, mentre le falde acquifere persiane si prosciugano giorno dopo giorno.
Un copione diverso, ma con analogie profonde, si è visto negli altopiani di Bolivia e Perù. La quinoa, coltivata per secoli da comunità locali che la consideravano cibo rituale e quotidiano, è diventata nei primi anni Duemila un “superfood” globale. Preziosa, proteica, esotica. Perfetta per le tavole salutiste d’Europa e Nord America.
Ma questo successo globale non ha arricchito le comunità contadine, né ha migliorato la sicurezza alimentare locale. Al contrario: molti produttori hanno smesso di consumare quinoa, che veniva venduta a prezzi alti all’estero, per acquistare riso importato e pane industriale più economico. Il cambio di dieta ha avuto effetti negativi sulla salute, ma anche sull’ambiente. Per rispondere alla domanda crescente, i campi andini sono stati spinti a una coltivazione intensiva, che ha causato erosione del suolo, perdita di pratiche agricole tradizionali e conflitti tra comunità contadine per l’accesso alla terra. Molti contadini si sono indebitati per comprare trattori e per avere più strumenti per coltivare la terra, senza avere alcuna certezza che questi investimenti sarebbero stati sostenuti nel lungo periodo dalle voglie capricciose del mondo occidentale.
A differenza dell’Iran, però, la produzione di quinoa non ha prosciugato le falde né fatto sprofondare il suolo. Ma ha comunque posto una domanda cruciale: fino a che punto un alimento può essere sostenibile, se per produrlo si snatura il territorio che lo genera e anche la sua struttura sociale e agricola? C’è poi anche un aspetto sanitario: quanto peserà questo cambio di dieta nell’economia globale del Paese?
Lo stesso schema si ripete dall’altra parte del mondo, nel Sud-Est asiatico. In Thailandia e Malesia, il protagonista è un frutto: il durian, amato e odiato per il suo odore pungente, diventato simbolo di lusso tra i consumatori cinesi. Nel giro di un decennio, la domanda estera ha trasformato intere province agricole: le foreste pluviali del Pahang malese e del Sud della Thailandia sono state rase al suolo per far posto a monocolture intensive, destinate all’esportazione. Laddove prima c’erano biodiversità e piccoli orti familiari, oggi ci sono filari di durian irrigati con impianti chimici, trattati con pesticidi per anticiparne la maturazione. I profitti? Spesso finiscono in mani esterne, mentre le comunità locali perdono accesso alla terra, all’acqua e persino al proprio cibo quotidiano. Il durian, che un tempo era venduto nei mercati rionali, è diventato un bene di lusso: esportato, imballato, monetizzato. Raro e caro anche per chi lo coltiva.
Nel caso iraniano, la risposta è ancora più drammatica. Il commercio alimentare sommerso non arricchisce i contadini, ma solo gli intermediari. I proventi non vengono reinvestiti in agricoltura, ma in macchinari e beni di consumo importati. È un sistema che scambia acqua con valuta estera, in un deserto che non ha più niente da dare.
Nei paesi produttori, che si tratti di quinoa, pomodori o durian, la terra diventa merce globale. Ma una merce particolare: non si rigenera, non si trasporta, non si clona. La sua ricchezza è fatta di tempo, di equilibrio, di relazioni tra esseri viventi. E quando queste relazioni vengono spezzate per rispondere a un mercato esterno, il sistema crolla. Gli ecosistemi si impoveriscono, le comunità perdono sovranità alimentare, i paesaggi si svuotano di senso. Il paradosso è che spesso questa corsa all’export nasce da una buona intenzione: portare ricchezza, migliorare l’economia, rispondere alla domanda globale. Ma senza regole, senza visione e senza attenzione per l’equilibrio ecologico, finisce per distruggere proprio ciò che voleva valorizzare.
Il cibo non è solo una merce. È storia, identità, paesaggio. E anche ciò che scegliamo di coltivare, e per chi, racconta chi siamo. O chi stiamo diventando.
L'articolo Quando l’agricoltura si piega all’export, a pagare è sempre la terra proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0











































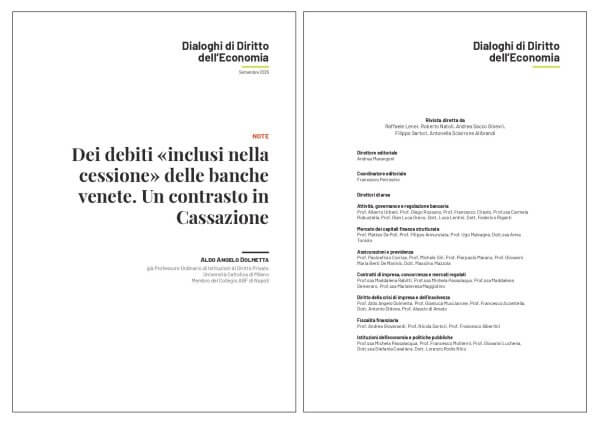
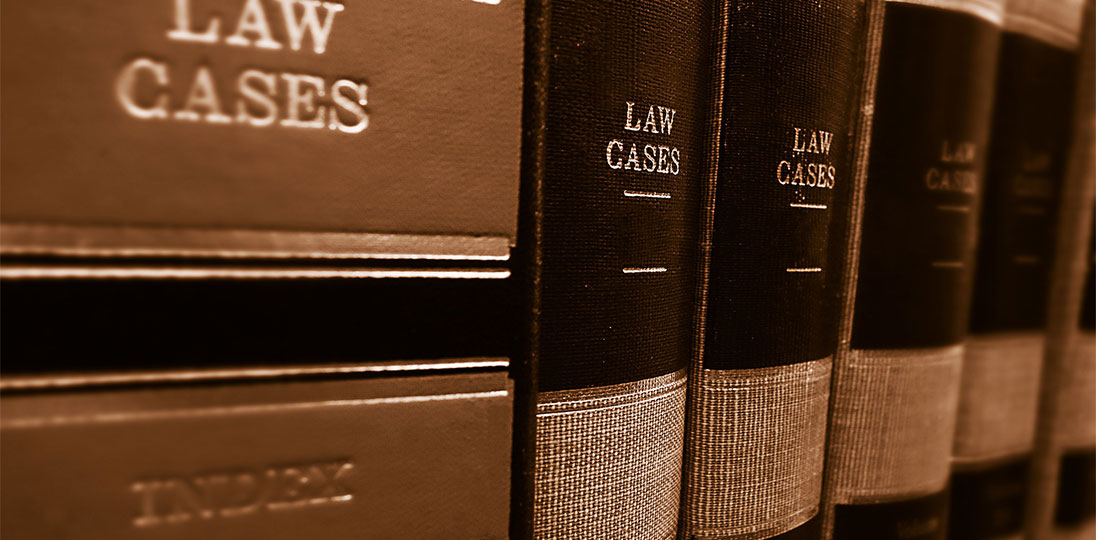



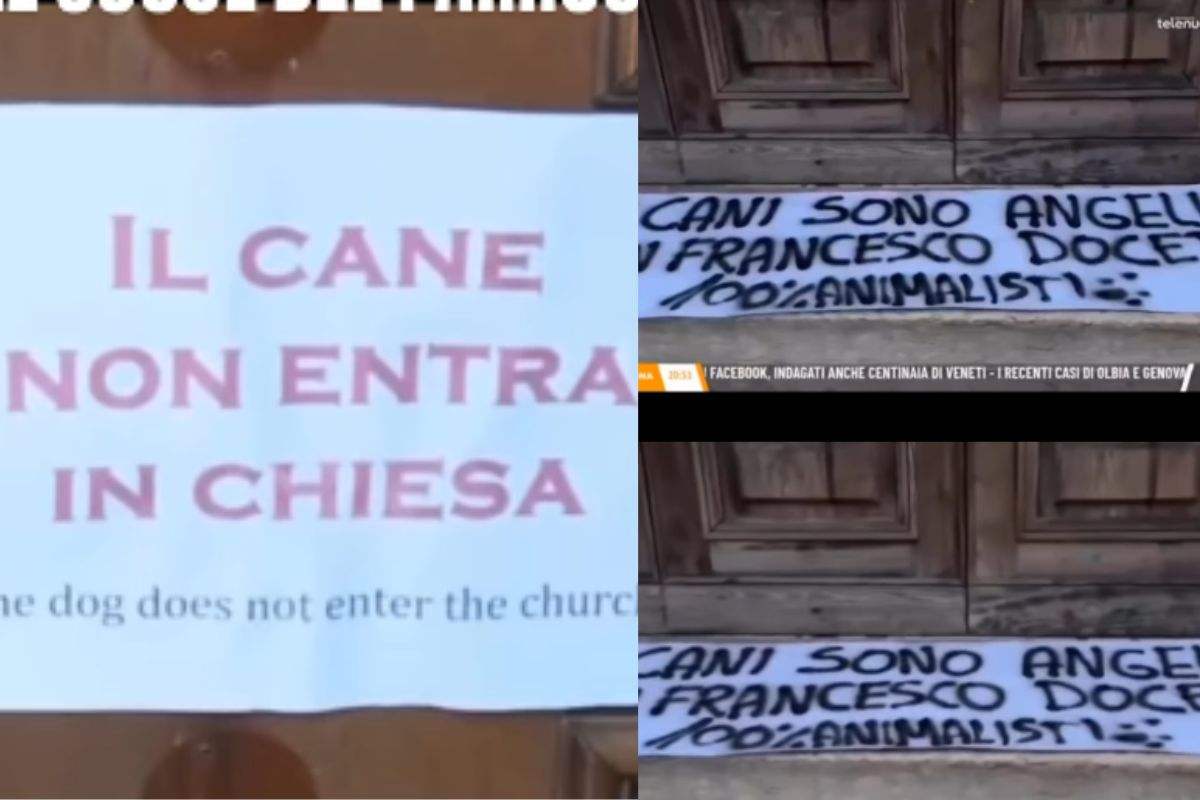





































/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/09/wp_drafter_181208.jpg)
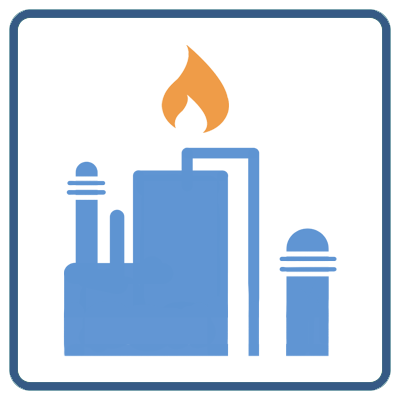


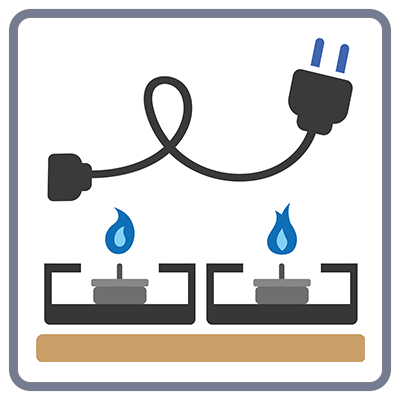


























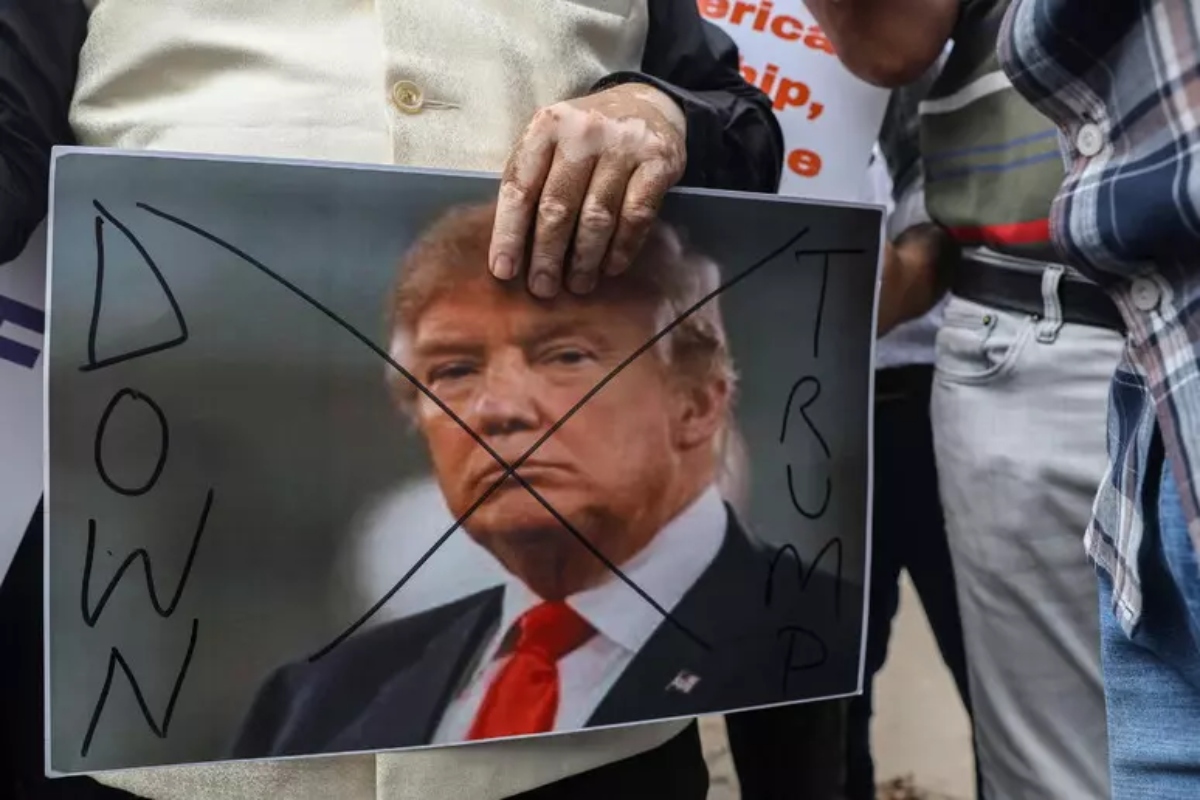





















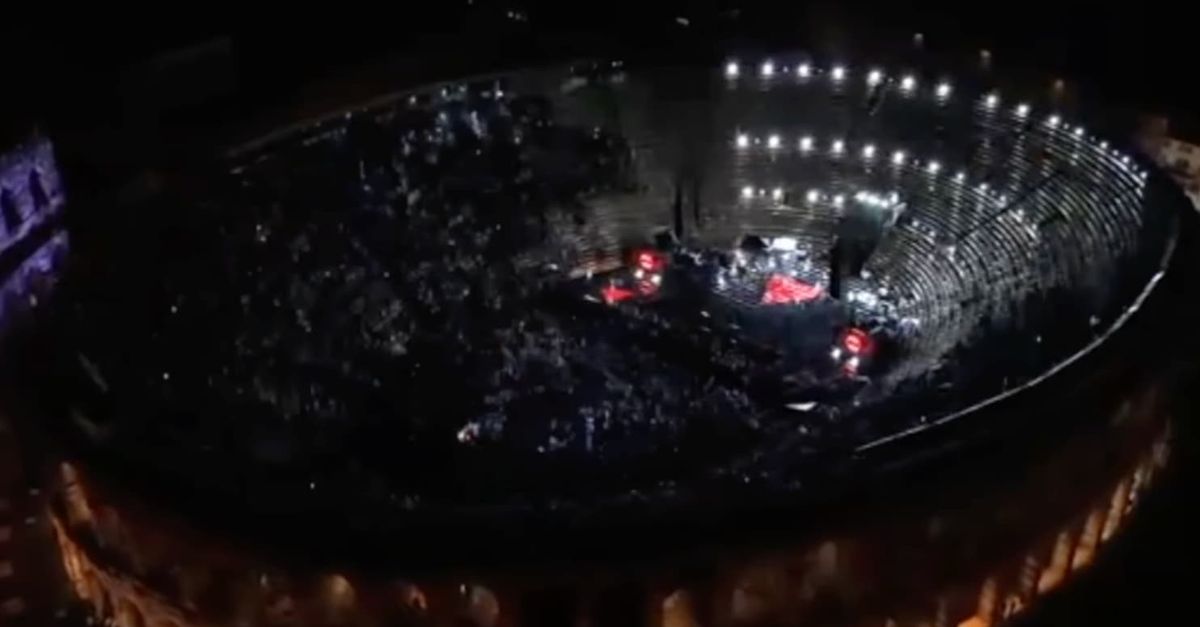

























![[SPOILER] La Forza di una Donna: anticipazioni mercoledì 3 settembre! Sirin teme il peggio](https://images.everyeye.it/img-notizie/-spoiler-donna-anticipazioni-mercoledi-3-settembre-sirin-teme-peggio-v4-825173-800x600.webp?#)












%20Carole%20Bethuel.jpg)













-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)