Anatomia di una dieta mediterranea e di ciò che ne rimane


In principio erano il grano, l’olivo e la vite, e per lo chef greco Spyros Liakos in parte è ancora così. «La Grecia è, per sua natura, un Paese mediterraneo e la sua alimentazione è profondamente legata alla terra, al clima e al suo popolo». Una cucina di equilibrio e misura, in cui il sapore è quello dell’ingrediente, marginalmente della tecnica utilizzata. «Ragione per cui – continua – la lavorazione ha un ruolo secondario sta nell’alto valore nutrizionale degli alimenti e nella loro identità. Che è sostenuta (pure) da un sostrato mitico».
I Greci facevano risalire la nascita dell’agricoltura cerealicola a Demetra, la dea alla quale veniva attribuito il dono del grano e quindi della sopravvivenza stessa della comunità. L’intera vicenda è raccontata su una placca in terracotta risalente al IV secolo a.C., che venne rinvenuta a Eleusi. Secondo il mito, Persefone, figlia di Demetra, venne rapita da Ade e trattenuta nel mondo sotterraneo. Non trovandola, Demetra sprofondò in un dolore cosmico prima ancora che personale, e la sua disperazione si rifletté sulla terra: i campi smisero di dare i frutti, le messi si seccarono e la vita ne fu gravemente rallentata. Solo quando la dea ottenne un compromesso, gli uomini poterono tornare a sperare.
Lo stesso meccanismo simbolico sosteneva gli altri due pilastri della dieta mediterranea: l’olivo e la vite che i Greci legavano rispettivamente ad Atena e Dioniso. La fondazione di Atene veniva raccontata attraverso la contesa per il dominio sull’Attica tra l’omonima dea e Poseidone. Avrebbe vinto chi avesse offerto agli uomini il dono più utile. Il dio del mare fece apparire un maestoso cavallo, in segno di prestigio e forza militare. Atena invece donò un’argentea pianticella d’olivo, promessa di continuità agricola ed economica che le fece guadagnare la vittoria. L’olivo divenne il fondamento politico della città perché riassumeva in sé l’idea che la comunità esistesse perché in grado di produrre da sé ciò che la manteneva in vita. L’olio significava luce, nutrimento e ricchezza condivisa.
Dioniso completava il quadro con la vite. Nelle “Baccanti” di Euripide, il vino veniva presentato come l’altro elemento essenziale accanto al pane: da una parte il cibo dato da Demetra, dall’altra il bere disposto da Dioniso. Ma il vino non serviva a un consumo sregolato. Nella pratica sociale del simposio, i Greci lo allungavano con acqua, lo versavano in precise quantità per gustarlo in uno spazio di condivisione e scambio politico. Il nettare degli dèi finiva per diventare piacere dei sensi e insieme garanzia di ordine pubblico.
Alla cosiddetta triade mediterranea s’accompagnavano erbe aromatiche, legumi e verdura di stagione; le quantità di carne erano minime così come quelle di formaggio; lo stesso non si può dire del pesce che veniva consumato in virtù dell’alto contenuto di Omega3. La formula utilizzata riassumeva anche un paesaggio agricolo specifico: il grano sfruttava le piogge invernali, mentre l’olivo e la vite resistevano alla siccità delle lunghe estati. Gli agronomi attivi sul bacino del Mediterraneo hanno sottolineato come l’agricoltura tradizionale in Grecia e in Italia si basasse su colture in asciutto, non dipendenti da irrigazioni costante e su continue rotazioni. Lungi dall’essere una mera tecnica agraria, il modello mediterraneo era una vera strategia di gestione del rischio climatico; gran parte del territorio era infatti collinare, sassoso e difficile da irrigare. La Fao ha descritto questo modo di agire come un esempio storico di uso calibrato delle risorse locali: un’agricoltura che non pretendeva di forzare l’ambiente con acqua che non c’era, ma che distribuiva le funzioni vitali tra colture complementari e stagioni diverse.
Secondo Spyros: «I prodotti locali offrono il miglior valore. Quando qualcosa è prodotto vicino, senza alti costi di trasporto e in armonia con i cicli naturali, mantiene al massimo freschezza, sapore e valore nutrizionale. In questo modo, la qualità resta alta e l’equilibrio tra costo e valore è giusto per il produttore e per il fruitore». Una filosofia che tiene insieme filiera corta ora molto in voga, cucina semplice e consumo collettivo. E che ha trovato (pure) spazio come patrimonio immateriale riconosciuto dall’Unesco. Persino la parola díaita, convenzionalmente adoperata per descrivere un regime alimentare restrittivo, in origine indicava un modo di vivere.
Un concetto che ritorna nelle parole dello chef, formatosi tra le isole dell’Egeo e che co-dirige insieme al fratello Vangelis quattro insegne ad Atene (Ateno, Basegrill, Travolta e Hoocut). Uno dei problemi più grandi della cultura alimentare contemporanea – racconta – è l’ipertrasformazione degli ingredienti e l’uso di conservanti chimici, che prolungano la durata dei prodotti, ne uniformano il gusto, ma ne impoveriscono la forza nutrizionale. Su Frontiers in Nutrition è stata di recente pubblicata un’analisi dei consumi alimentari in Italia confrontando due momenti: 2005-2006 e 2018-2020. Gli esperti hanno misurato quanto la popolazione conducesse un’alimentazione salutare e insieme sostenibile secondo gli standard internazionali.
Dallo studio è emerso che i cibi ultraprocessati rappresentano circa il sei per cento di quello che gli italiani mangiano in termini di peso. Il numero può sembrare basso, ma quei prodotti arrivano a coprire il ventitré per cento delle calorie giornaliere totali. Significa che quasi un quarto dell’energia quotidiana degli adulti proviene da alimenti industriali confezionati. Quindici anni prima, nel 2005-2006, la quota calorica era più o meno la metà. In altre parole: gli italiani non stanno ancora mangiando enormi quantità di alimenti ultraprocessati in termini di grammi, ma quelli che consumano sono così densi di calorie, zuccheri e grassi da occupare ormai una fetta enorme della loro dieta reale.
Spyros sottolinea anche la vicinanza con la tradizione italiana. Dall’olio extravergine d’oliva che è l’inizio e la fine di ogni vezzo culinario in entrambe le nazioni ai diversi tipi di erbe aromatiche (timo e origano) fino ai formaggi (la graviera greca per certi versi ricorda il pecorino; la mizithra assomiglia alla ricotta di bufala salata). «Bisogna tornare a distinguere tra mangiare e nutrirsi; mangiare semplicemente placa la fame, nutrirsi è un’azione che alimenta l’intero essere umano».
Corpo, mente e spirito s’incontrano anche in quello che secondo lo chef deve tornare a essere l’essenza della cucina, l’antico concetto di Threpsis (“Nutrimento” in greco) che è anche il punto in cui il cibo smette di essere semplice consumo e diventa cura. Tutto ha inizio con ingredienti e prodotti stagionali, continua con un modo di cucinarli che non ne snaturi il valore naturale, e si compie quando quel cibo viene condiviso a tavola. «Threpsis significa nutrire davvero una persona, non solo sfamarla. Ed è il rispetto per l’ingrediente, l’equilibrio nella cottura e l’onestà nel risultato. Finché questi elementi esisteranno, l’essenza della cucina mediterranea resterà viva».
L'articolo Anatomia di una dieta mediterranea e di ciò che ne rimane proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0

































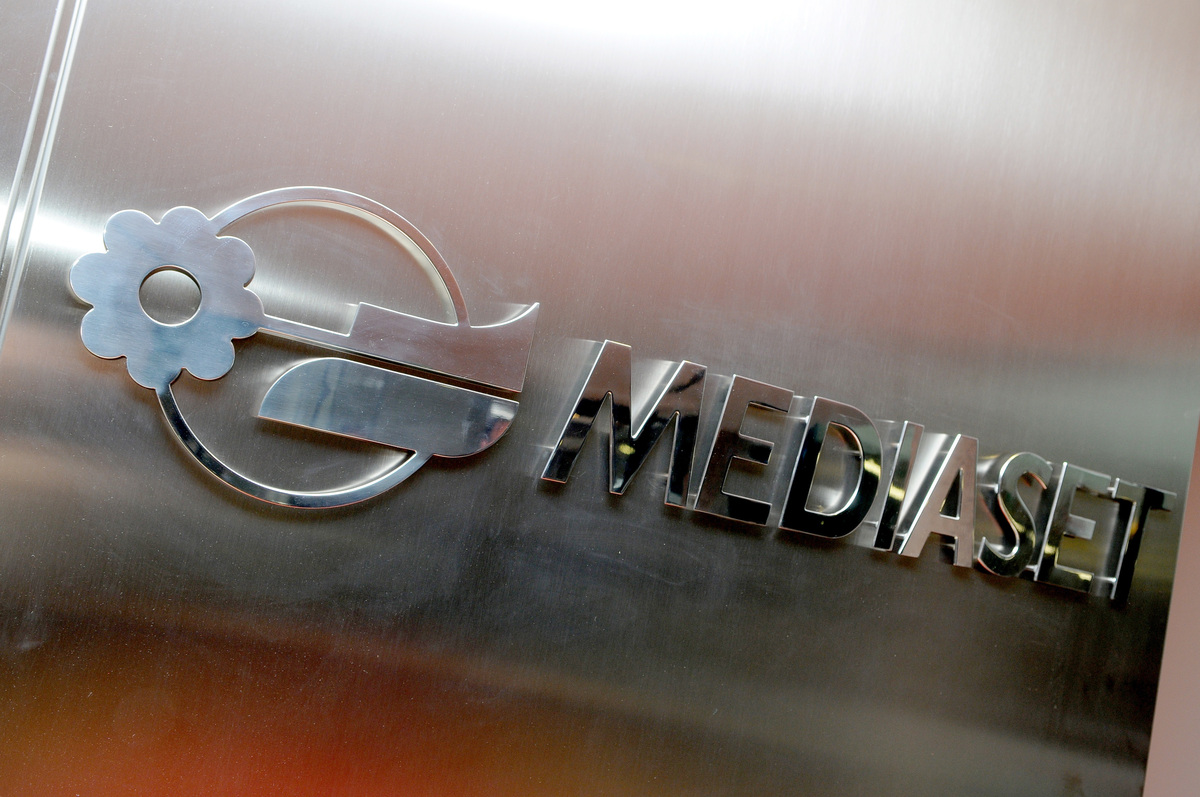























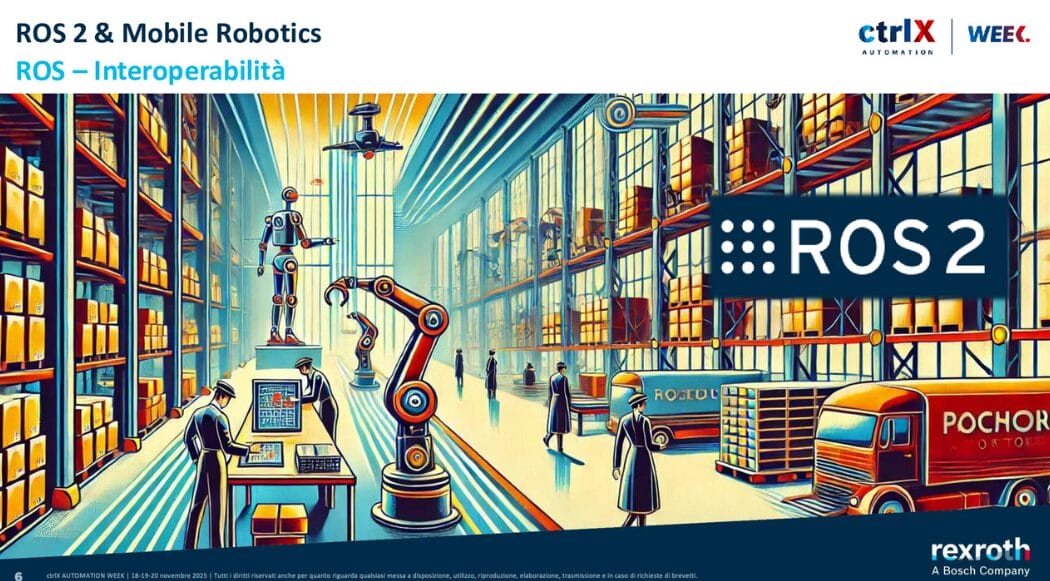















































































































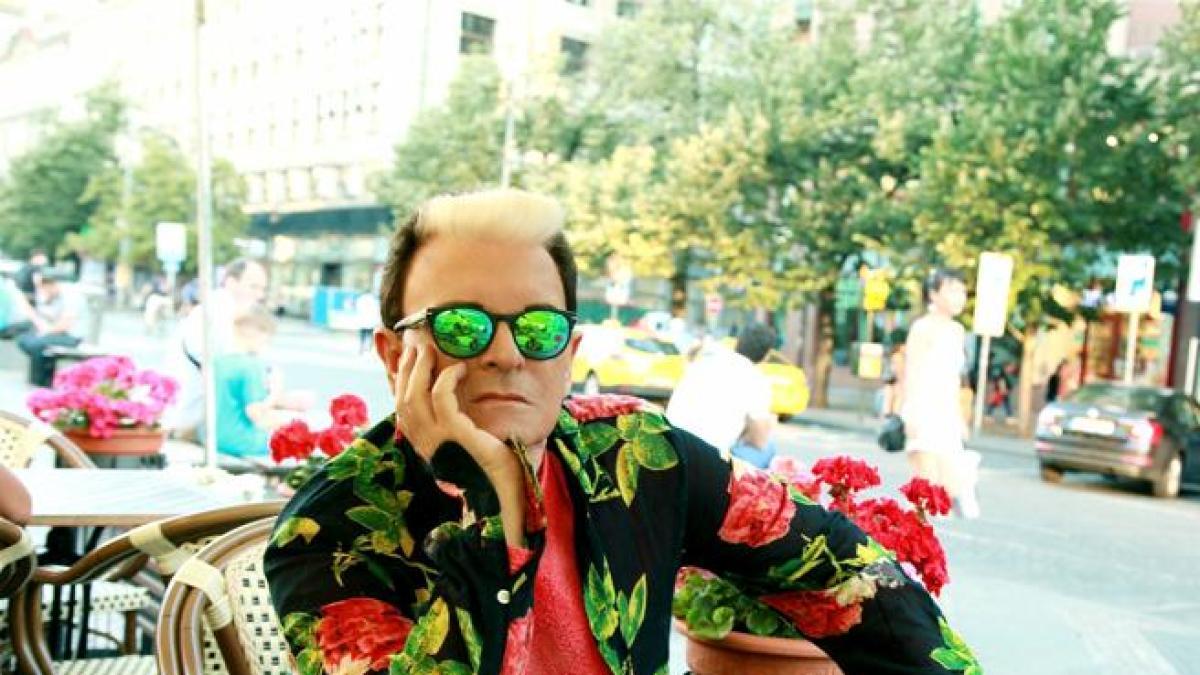

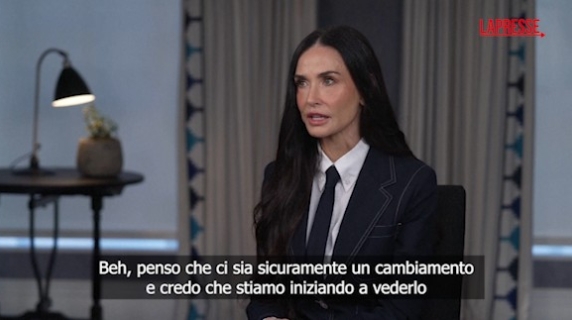
















-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)



























































