«Con la “Dilexi te” papa Leone XIV ci dice che la povertà è una questione famigliare, non un problema sociale»

 Papa Leone XIV
Papa Leone XIV«Ho letto con piacere l’Esortazione apostolica di papa Leone Dilexi te», dice monsignor Claudio Stercal, teologo e direttore del Centro di spiritualità della Facoltà teologica dell’Italia settentrionale. «Se dovessi sintetizzare la mia impressione di lettura, utilizzerei questi due termini: “continuità” e “profondità”. Continuità con il magistero di papa Francesco, in particolare nella prima parte, ampia, nella quale ripercorre l’aspetto biblico e la storia bimillenaria, come dice Leone, dell’attenzione della Chiesa ai poveri. La profondità, invece, l’ho colta nel quinto breve e ultimo capitolo, in cui papa Leone ci propone una profonda e intelligente lettura del tema della povertà, dicendo in sintesi che i poveri – e in generale la povertà che condividiamo un po’ tutti -, ci aiutano a vedere aspetti della realtà che altrimenti non vedremmo».
Per esempio?
Quando dice che la povertà non è «un problema sociale», ma «una questione famigliare», quindi riguarda tutti, inoltre i poveri o la povertà che tutti condividiamo ci insegnano la precarietà dell’esistenza, la fiducia in Dio, l’aiuto reciproco. Il Papa con una simpatica espressione scrive che i poveri riescono a evangelizzarci, nel senso che ci pongono di fronte alla nostra debolezza e quindi alla necessità di cercare la salvezza della solidarietà, nell’aiuto e nel rapporto con Dio. Rispetto alla missione della Chiesa dice bene, per esempio al numero 103, che l’amore ai poveri è garanzia evangelica di una Chiesa fedele al cuore di Dio e quindi mostra l’autenticità della fede. E nei numeri finali suggerisce come l’amore cristiano, che si esercita nell’attenzione alle molteplici forme di povertà che ci sono nel mondo (non solo quella economica, culturale, sanitaria, politica), esprime il nostro modo di concepire la vita e la fede. Mi è piaciuta questa lettura profonda, teologica, della povertà, come una condizione con la quale tutti abbiamo a che fare e che può veramente insegnarci a vivere.

Il Papa invita ad ascoltare il grido dei poveri che «interpella la nostra vita, le nostre società, i sistemi politici ed economici e, non da ultimo, anche la Chiesa». Prendersi cura dei poveri è quindi responsabilità di tutti, singoli e istituzioni, che non devono restare indifferenti.
Questo è un tema che attraversa tutta l’Esortazione e forse attraverserà l’intero pontificato di papa Leone, stante anche la sua esperienza internazionale, istituzionale. I problemi non sono mai i problemi del singolo e la povertà è uno di questi e interpella tutti, singoli, istituzioni e, come abbiamo visto anche in questi primi mesi, c’è un modo di affrontarlo insieme che educa, aiuta. Forse esprime veramente il senso dell’esistenza, che non è fatta da assenza di prove, ma ciò che qualifica la maturità di un’esperienza umana o cristiana è esattamente il modo con il quale insieme le affrontiamo.
Fin dalle prime pagine Leone scrive che «doppiamente povere sono le donne» che soffrono situazioni di esclusione, maltrattamento e violenza e con meno possibilità di difendere i loro diritti.
Penso che sia un’attenzione da avere nel leggere l’Esortazione, ma poi anche nel valutare progressivamente la missione della Chiesa, cioè che il concetto di povertà qui proposto non è solo la povertà economica, ma riguarda tanti aspetti: la povertà della condizione femminile, la povertà di alcuni Paesi in particolare, la povertà sanitaria, la povertà della mancanza di tenere desta l’attenzione. Non si può ridurre semplicemente a una povertà economica, seppure nelle pagine finali il Papa parli anche dell’esercizio dell’elemosina, una pratica che a volte viene sottovalutata. Io direi che sia l’elemosina economica sia l’attenzione al vicino di casa sono elementi importanti perché sottolineano come anche i piccoli gesti, le piccole attenzioni quotidiane in qualunque circostanza, in qualunque relazione possono rispondere a questo desiderio di soccorrere la povertà di tutti noi.

Senza però cadere nell’assistenzialismo, perché non aiuta le persone a un cambiamento di vita e a raggiungere l’autonomia. Non a caso il Papa usa verbi come «accogliere, proteggere, promuovere e integrare».
A mio parere è ben consapevole di non voler cadere nell’assistenzialismo come a volte facciamo noi. Penso che siano i due gli antidoti fondamentali per non cadere nell’assistenzialismo: l’attenzione alla dignità della persona, anche di colui che eventualmente fosse povero; e la relazione. Il Papa ripercorre la storia della Chiesa in cui spesso i cristiani nel soccorrere la povertà del mondo hanno impegnato completamente se stessi, quindi non è stato solo un gesto di carità, ma è il coinvolgimento personale di sé in una relazione autentica con l’altro. La relazione personale autentica attenua il pericolo dell’assistenzialismo che a volte è semplicemente un puro gesto che sembra liberare la coscienza, invece si tratta di condividere un’esperienza.
Infatti il Papa scrive che ai poveri va dedicato tempo, «ore, settimane o anni della nostra vita».
Certo, proprio così. Penso che sia il motivo per il quale, pure in sintesi, ha voluto ripercorrere alcune tappe importanti dell’attenzione al prossimo della Chiesa cristiana. La prima parte sembra quasi una sintesi del manuale di storia della Chiesa, perché vuole mettere l’accento sulle cose fatte con impegno, dedizione, intelligenza, nella varietà dei contesti e delle epoche. Per questo, non a caso, l’ultimo capitolo si intitola “Una sfida permanente”, nel senso che interpreta la storia della Chiesa come una risposta sfidante alle necessità del mondo e adesso tocca a noi andare avanti. E Il quarto capitolo si intitola infatti “Una storia che continua”.
Insomma, per imparare ad ascoltare il grido dei poveri, la Chiesa deve tornare al modello dei primi cristiani?
Sì. L’impressione che io ho in generale, ma anche leggendo i riferenti biblici che il Papa propone, è che il modello degli inizi della vita nella Chiesa è sempre una grande fonte di ispirazione. Anche noi dobbiamo avere il coraggio di riconfrontarci con quella esperienza, che rispetto ad altre, rispetto alla nostra, ha la vicinanza al fondatore. Molte persone avevano conosciuto personalmente Gesù, poi hanno dovuto iniziare ad applicare il Vangelo che avevano ascoltato. Agli inizi c’è sempre un principio di ispirazione di creatività, di intelligenza, di novità che forse anche noi dobbiamo recuperare.

Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0
































![Cupra Formentor VZ5: il ritorno del cinque cilindri che emoziona (e che forse non rivedremo più) [VIDEO]](https://img.stcrm.it/images/48012354/1200x/formentor-vz5_10.jpg)





.jpeg)














































/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/11/600-euro-buoni-amazon-aprendo-conto-credit-agricole.jpg)

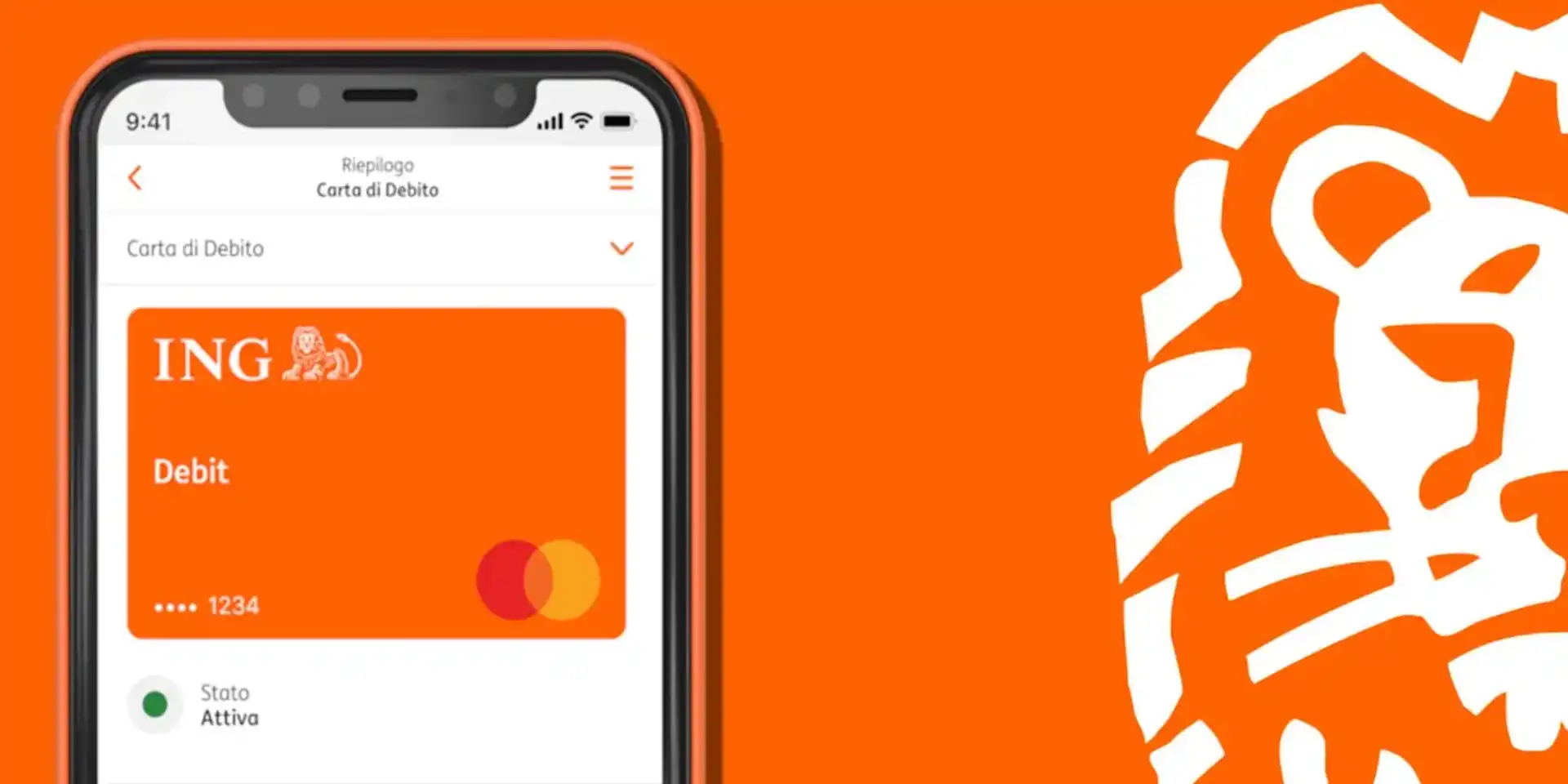










































































































-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)























































