Da Arbasino a TikTok, o la lenta scomparsa della cattiveria intelligente


«Volendo fare un paragone alla società letteraria, la mia infelice generazione, che aveva vent’anni negli anni Cinquanta, stava peggio, credo. Stava peggio perché ci trovavamo davanti a una società culturale che potrei definire di millepiedi, perché tenevano mille piedi in mille scarpe. Basta ricordare che avevamo davanti, come esempi e come modelli, punto interrogativo, Moravia/Guttuso, Picasso/Sartre, cioè un grande affannarsi e sbattersi fra il marxismo, l’esistenzialismo, le riviste di moda tipo Vogue, la fenomenologia, quel cinema delle maggiorate tutte chiappe e tette, però anche Santa Romana Chiesa, però anche il premio Stalin, però scrivere e fare in genere le cose abbastanza facili per poter diventare eventualmente bestseller in America e essere venduti nei chioschi degli aeroporti, ma però anche il Corriere della Sera di Missiroli, che è la destra vecchia borghese conservatrice confindustriale, ma però anche l’Unità, Rinascita di Togliatti, e i cardinali e le contesse e i braccianti e il mondariso e oltre le contesse i conti correnti» – interrompo il periodo a metà, perché lo so che non ce la potete fare: vi siete persi al primo anacoluto.
È la primavera del 1994, Alberto Arbasino ha cambiato il corso della mia vita da sei mesi ma non lo sa allora e non lo saprà mai, è ospite di Alessandro Baricco a “Pickwick”, e io non l’avevo mai sentito parlare. Il periodo che ho interrotto continua così: «E poi in tutto questo, però, sempre tener d’occhio il bestseller, cosa che né Gadda né Longhi né Praz, i grandi maestri, hanno mai badato al bestseller, poi basati anche molto su quel tipo di lettrice, “sotto l’ombrellone estivo” si diceva allora, per cui il grande interesse è di avere un romanzo dove potersi interessare se quella zoccola gliel’ha data o non gliel’ha data all’ingegnere o al ragioniere; ma se si pensa che in ombrelloni vicini c’erano frotte di maestrini di pensiero che invece chiedevano se Heidegger – non quella zoccola: Heidegger, sommo filosofo – lo era o non lo era, un po’ nazi, e lo era prima o lo era dopo, e lo era tanto o lo era poco, ecco, il clima era quello».
Pochi minuti prima di fargli la domanda sulla società letteraria che non gli pare, a lui ultimo arrivato, ’sta meraviglia, Baricco gli ha chiesto se gli autori che ci piacciano debbano essere brave persone (sembra un dibattito di questo decennio), e Arbasino ha tra le altre cose risposto che Gadda scriveva come parlava (è qui, al ventinovesimo minuto), e la me ventunenne davanti alla tele sta pensando: ma pure tu parli preciso uguale pittato come in quel libro pazzesco, ma che meraviglia.
Sei mesi prima, nella libreria sotto il Pavaglione (chi è di Bologna sa), ho aperto e sfogliato un libro che né le milletrecentosettantuno pagine di testo né le sessantottomila lire di prezzo mi hanno scoraggiato dall’amare a prima vista. È un Adelphi ma non ha una copertina particolarmente bella, s’intitola “Fratelli d’Italia” che non è un titolo particolarmente appetitoso, ma dentro ci sono dialoghi così: «Ma scusa, non ti diverti, non ti piace, quando l’erotismo diventa pornografia?» «Mah, per la noia della fica basta già Moravia. E la letteratura del culo è solo settoriale, come i libri sulle barche, sul Molise, sui funghi».
Ogni tanto mi passa davanti qualche breviario su come leggere e come scrivere, e penso sempre a quel “Fratelli d’Italia”, in quarta versione ma per me prima scoperta che si potesse scrivere così – così come, direte voi: così, come parla uno che è cresciuto nella civiltà della conversazione. Leggo istruzioni che raccomandano di sottolineare, nei libri, massimo tre frasi a pagina, di non disperdere l’attenzione, e penso a quella copia del romanzo cui Arbasino lavorò tutta la vita, quella copia che ho ancora e che è interamente sottolineata. A matita, perché ero giovane e scema (e scarabocchiavo delle note a margine del testo che morirei piuttosto che rendere pubbliche).
Ieri è uscita una nuova versione di “Fratelli d’Italia”, dopo quella Feltrinelli del 1963 lievemente modificata nell’edizione del 1967, dopo quella Einaudi del 1977, e dopo l’Adelphi dei miei ventun anni. In una chiusura di cerchio che commuoverà chi ama i simbolismi, lo ripubblica Feltrinelli, con una nota di Giovanni Agosti di ottanta pagine, una nota che mesi fa l’unico Luminare Culturale di cui mi fidi m’aveva detto «leggerete in tre», e posso dimostrare che no, non c’è uno cui l’abbia declamata da quando ho sul comodino il volume che non sia corso a ordinare l’edizione per leggere Agosti più di Arbasino, ché Arbasino ce l’avevamo in casa già tutti e quasi tutti in più versioni, ma la storia della gestazione di “Fratelli d’Italia”, le crisi di nervi e i bisticci mondani che neanche il Truman Capote di “Preghiere esaudite”, tutta quella vicenda su cui se avessimo un Ryan Murphy ci sarebbero otto puntate già in lavorazione, tutte quelle cose io non le sapevo, e sto per dedicare un monumento a cavallo ad Agosti, custode di meraviglie ignote persino a chi è cresciuta in anni in cui i giornali esistevano e avevano le pagine culturali.
(L’altro giorno stavo maramaldeggiando dicendo che negli anni Novanta noi su Repubblica avevamo Arbasino che scriveva di Lady Diana, e guardali, i ventenni d’oggi, che al massimo hanno Edoardo Prati che vuole pure scrivere di cose alte invece che di Kim Kardashian, vuole pure convincere sé stesso e i lettori che il midcult sia sofisticato; poi mi sono resa conto della mia viltà nel citare un ragazzino secchione con uso di TikTok e non gli abissi rappresentati dai miei coetanei Luminari Culturali del momento: in Italia non si può fare la rivoluzione perché scriviamo tutti per gli stessi giornali).
Una cosa che ho scoperto dalla nota di Agosti è che ho in comune con Pasolini un parere: che “Fratelli d’Italia” sia uno dei più gran romanzi della seconda metà del Novecento italiano. Bravo Pier Paolo, hai ragione, uno dei soli tre che valgano la pena, per una volta ne hai detta una giusta, anche se su quali siano gli altri due non credo avremmo concordato. (Quando metterete sui social uno screenshot di queste righe per indignarvi perché Soncini si permette condiscendenza con Pasolini, mi raccomando gli aggettivi: come minimo «il grande Pier Paolo»).
“Fratelli d’Italia” è pieno di descrizioni che ti vorresti ammazzare quando ti viene il sospetto che ti somiglino, «Vestita piuttosto bene, ma disperatamente sul sofisticato-a-tutti-i-costi», «Molto amica della frase fatta», «Si vede che sono delle ordinarie anche quelle, con delle schienone nude un po’ formaggiose e dei reggipettacci che scappan fuori da tutte le ascelle appena provano a ballare», «Versa da bere come se le stesse offrendo la vita».
C’è, in tutti i grandi scrittori, una spietatezza che è il «no» che Arbasino non ha bisogno di rispondere alla domanda di Baricco: solo gli scrittori inutili sono brave persone nel senso sociale del termine. «Jonathan del resto deve correre via, perché alle dodici e mezza deve farsi fare delle pipì addosso da uno che ha trovato in banca venerdì mattina». Non c’era ancora Grindr, e Arbasino già batteva a macchina il presente, il futuro, e tutto il passato da cui erano e siamo passati.
L'articolo Da Arbasino a TikTok, o la lenta scomparsa della cattiveria intelligente proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0
































![Cupra Formentor VZ5: il ritorno del cinque cilindri che emoziona (e che forse non rivedremo più) [VIDEO]](https://img.stcrm.it/images/48012354/1200x/formentor-vz5_10.jpg)





.jpeg)














































/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/11/600-euro-buoni-amazon-aprendo-conto-credit-agricole.jpg)

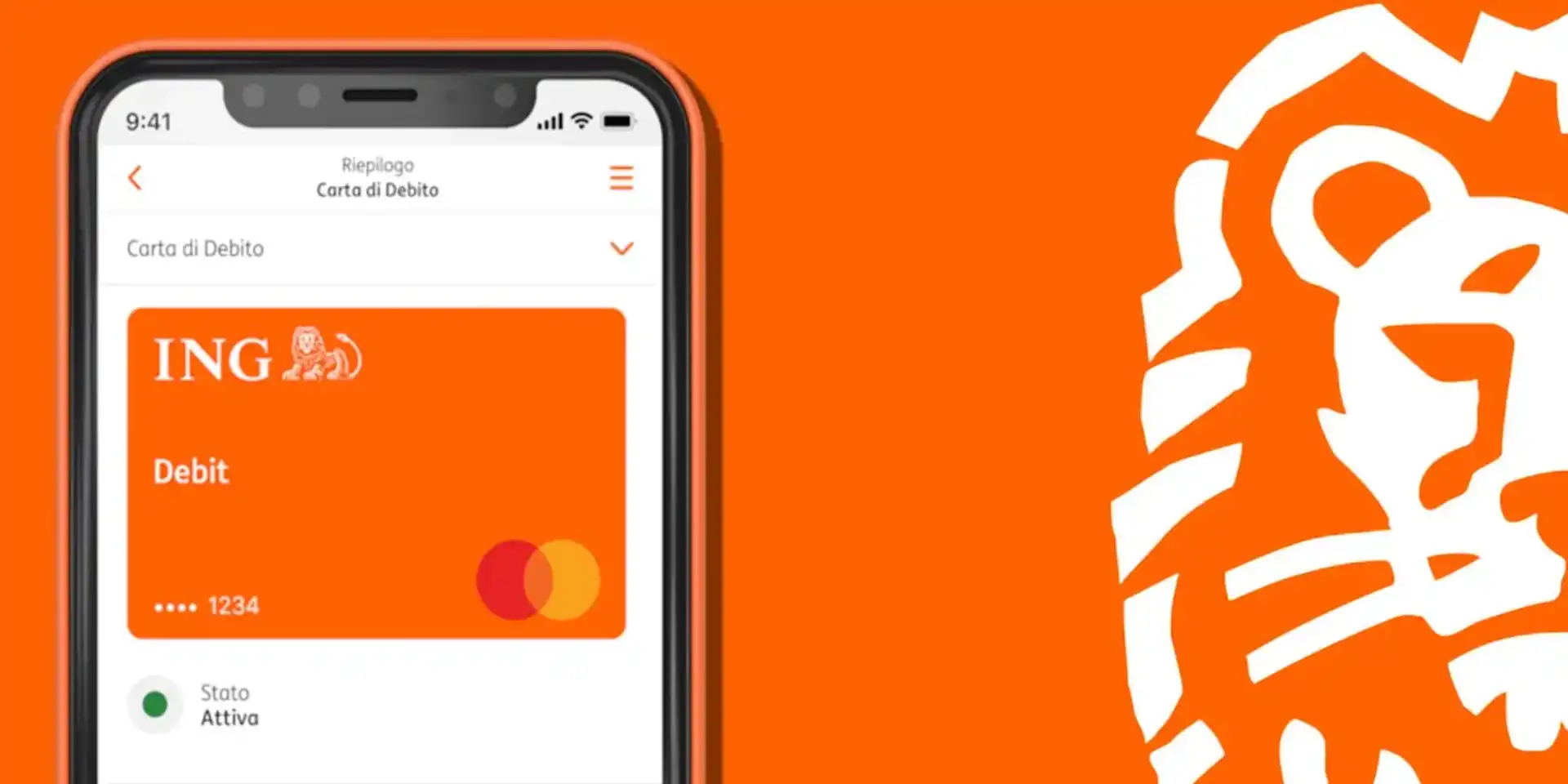













































































































-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)






















































