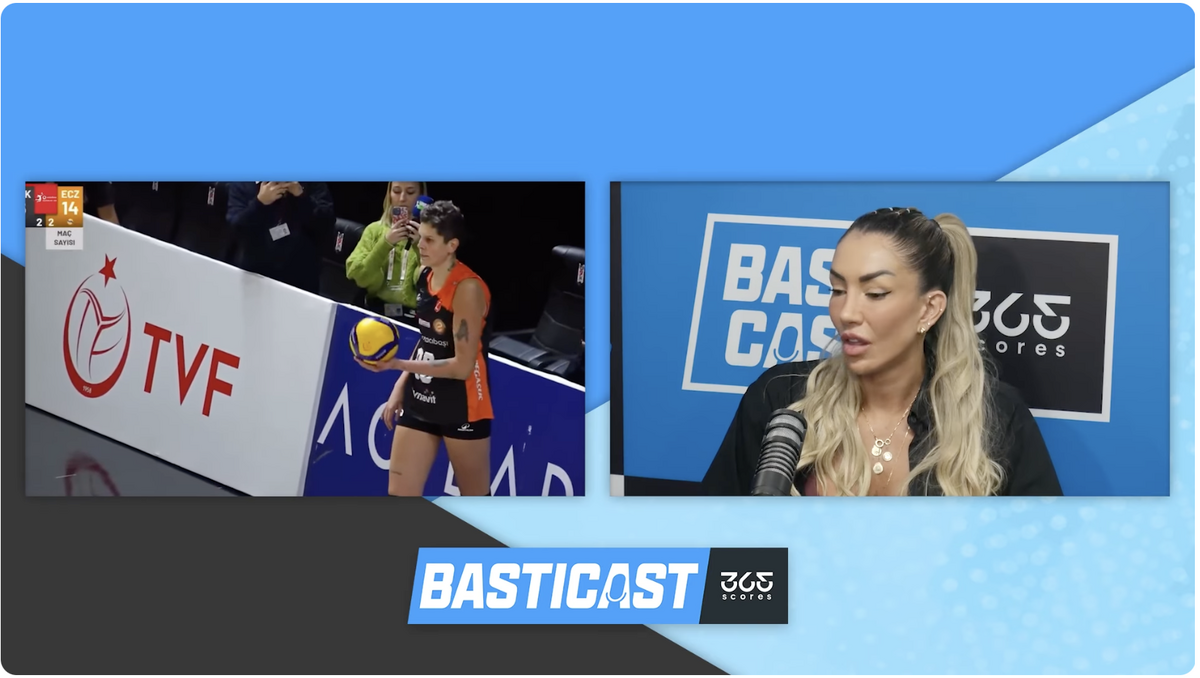La memoria addomesticata dell’antimafia, e l’orrore dell’omicidio di Giuseppe Di Matteo


La stanza è stata ristrutturata. Pitturata, ripulita. Se non fosse per i lumini accesi, i fiori e per quella rete del letto, arrugginita, potrebbe sembrare qualsiasi cosa: un monolocale pronto a diventare un b&b, una stanza in affitto per studenti fuori sede, una di quelle soluzioni spartane e care che il mercato immobiliare spaccia per accoglienti. Anche il bagno è stato rifatto. Piastrelle nuove, sanitari. Non sia mai che a qualcuno venga il bisogno di fare pipì nel luogo dell’orrore. L’orrore più nero.
Siamo nel nulla della campagna intorno a San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo, nell’ultimo covo, dove venne tenuto prigioniero e ucciso un ragazzino, Giuseppe Di Matteo. Qui, in questa stanza che oggi sembra pronta per essere abitata, finisce una storia che non dovrebbe finire mai di essere raccontata, perché rappresenta il punto più basso, infame e disumano della mafia siciliana. Il momento in cui Cosa nostra smette definitivamente di fingere di avere un codice, un limite, una qualche idea distorta di «onore».
Giuseppe aveva dodici anni quando fu rapito, il 23 novembre del 1993. Il suo nome era una leva. Suo padre, Santino Di Matteo, era un uomo d’onore che aveva deciso di collaborare con la giustizia. Un tradimento imperdonabile. E così Cosa nostra colpì dove sapeva di poter infliggere il dolore massimo: un figlio. Per 779 giorni Giuseppe fu spostato da un covo all’altro, legato, minacciato, picchiato. Gli fecero credere che suo padre lo avesse abbandonato. Gli promisero libertà, che non arrivava mai. Fu tenuto in catene, come un animale, in condizioni disumane.
In quegli anni, mentre lo Stato cercava di reggere l’urto delle stragi e dei processi, mentre si discuteva di pentiti, di trattative vere o presunte, di equilibri criminali e istituzionali, un bambino marciva nella solitudine più totale.
L’11 gennaio 1996 arrivò la decisione finale. Giovanni Brusca, lo stesso che aveva azionato il telecomando a Capaci, ordinò che Giuseppe venisse ucciso. Fu strangolato. Il suo corpo sciolto nell’acido. Non doveva restare nulla. Nessuna tomba, nessun luogo del pianto, nessun segno. Cancellare un bambino per punire un padre e lanciare un messaggio a tutti gli altri: chi parla paga così.
La mafia, da quel momento, non è più solo un’organizzazione criminale. È un sistema che ha dimostrato di poter fare qualsiasi cosa, anche usare un bambino come arma. È per questo che l’uccisione di Giuseppe Di Matteo non è una pagina come le altre, ma un abisso. Un punto di non ritorno. Qui non è successo «qualcosa», ma l’indicibile. Questa non è una stanza qualunque, ma il simbolo di una linea superata per sempre.
Quella stanza, e quella casa, è al centro del Giardino della memoria. Un nome giusto, per carità. Un nome che dice l’intenzione. Ma anche un nome che, mentre cammini, ti costringe a fare i conti con una sensazione fastidiosa: quella di una memoria addomesticata, incorniciata, resa presentabile. Alla prigione del ragazzino si accedeva da un piccolo vano segreto. Una specie di montacarichi, pensato per far passare persone e vettovaglie senza essere visti. Un dispositivo da clandestinità, da sequestro, da sparizione. Oggi, al posto di quell’ascensore, c’è un buco. Un buco che guarda in basso e non restituisce nulla. È forse l’unica cosa davvero onesta rimasta.
Tutto intorno, però, la casa è stata completamente ristrutturata. Le pareti sono in ordine, gli spazi ripuliti, il perimetro sistemato. È diventata un luogo pubblico, visitabile, attraversabile. Al centro di un giardino che ospita targhe, piante, silenzi programmati. Qui si tengono le commemorazioni. Qui si portano le scuole. Qui si pronunciano parole come «legalità», «impegno», «mai più». Uno spazio rassicurante, quasi pacificato, che lascia addosso una domanda difficile da scrollarsi di dosso: siamo sicuri che la memoria debba consolare?
Cammini nel giardino e pensi che qui un bambino è stato tenuto prigioniero. Che è stato spostato, umiliato, spezzato lentamente. Che alla fine è stato ucciso e sciolto nell’acido. E intanto ascolti discorsi misurati, vedi corone di fiori, fotografie ufficiali, gesti corretti. Tutto è al suo posto. Anche l’orrore, sembra, ha trovato una collocazione. Tra il bisogno sacrosanto di ricordare e il rischio, sempre presente, di rendere la memoria praticabile, visitabile, quasi confortevole. Tra la violenza assoluta di ciò che è accaduto e la forma educata con cui lo raccontiamo trent’anni dopo. E lì, intorno a quel buco.
Sopra la cella con la rete del letto, i lumini, il cesso rifatto. In un giorno di freddo e tempesta, si sono ritrovate, venerdì pomeriggio, le massime autorità dello Stato per la commemorazione di Giuseppe Di Matteo nel trentennale del suo omicidio.
C’era tutta la destra di governo che conta. Deputati, senatori, sindaci. C’era la presidente della Commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo. C’erano il questore e il prefetto di Palermo. In meno di un’ora di interventi, la parola «legalità» è stata pronunciata ventisei volte. Quasi una ogni due minuti. Un mantra. Una formula. Una parola buona per ogni stagione, soprattutto per quelle commemorative.
C’erano tutti i sindaci della valle dello Jato e del Corleonese. Questa provincia nera di Sicilia che ha dato i natali agli stragisti, ai capi, agli esecutori materiali delle peggiori infamie e che ancora oggi fatica a liberarsi di quella macchia. E allora si ossequia il passaggio delle autorità, ci si inchina, si alza il registro, si trasforma ogni ricordo in cerimonia, ogni ferita in celebrazione della lotta alla mafia.
Ma qui non è successo un fatto simbolico. Qui è morto un bambino. È morto torturato un bambino. Ed è stato poi sciolto nell’acido. Qui. Qui dove parla il sindaco di San Giuseppe Jato, che, citando Giovanni Brusca e i suoi uomini – quelli che decisero, pianificarono ed eseguirono l’omicidio –, li definisce «inaffettivi». Qui dove parla il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, anche sindaco metropolitano di questa provincia, che plaude a manifestazioni come questa perché «alimentano il pensiero antimafia». E nel frattempo rivendica i successi della sua amministrazione sul fronte della legalità, in una città dove però la battaglia sulla sicurezza è arrivata a un punto grottesco: il Comune che si affida alle guardie private per vigilare il centro, la movida, le strade della notte. Ed è uno dei paradossi più clamorosi di questo tempo.
La mafia, negli anni Ottanta, cos’era se non una forza privata di controllo del territorio? Un potere che suppliva allo Stato, che decideva chi poteva stare dove, chi poteva aprire, chi doveva chiudere, chi doveva pagare. Trent’anni dopo l’omicidio di Giuseppe Di Matteo, a Palermo abbiamo completato il giro. Non è più la criminalità a sostituirsi allo Stato: è lo Stato che delega ai privati la vigilanza dei luoghi pubblici. E mentre tutto questo accade, sopra quella stanza, sopra quel buco, sopra il luogo dell’orrore assoluto, si parla di legalità come se bastasse pronunciarla. Come se ripeterla potesse neutralizzare le contraddizioni, coprire i cortocircuiti, rendere innocuo perfino il passato.
Gli altri interventi istituzionali, uno dopo l’altro, finiscono per esaltare il «lavoro della Commissione parlamentare antimafia» guidata da Chiara Colosimo e i «successi ottenuti». Viene spontaneo chiedersi quali siano, questi successi. E soprattutto in che direzione stiano andando.
Da mesi è evidente che l’Italia sta assistendo a un tentativo sistematico e tutt’altro che marginale di riscrittura della storia degli ultimi trent’anni. Una riscrittura che riguarda il cuore più delicato e tragico della nostra vicenda repubblicana: le stragi del 1992 e del 1993, il rapporto tra mafia, politica e pezzi dello Stato, le responsabilità accertate da sentenze definitive. Un’operazione portata avanti da esponenti della maggioranza proprio dentro la Commissione antimafia e amplificata da una certa stampa compiacente, con l’obiettivo non troppo nascosto di capovolgere verità giudiziarie ormai consolidate.
Mentre si riscrivono le stragi, mentre si annacquano le responsabilità, mentre si trasformano le verità giudiziarie in opinioni, il rischio è sempre lo stesso: che la parola «antimafia» diventi un involucro vuoto. Una bandiera buona per tutte le stagioni.
Poi parla lei, la presidente. Chiara Colosimo. Racconta di essere diventata da poco mamma e dice che per questo essere lì è ancora più emozionante. Subito dopo, però, il tono cambia. Si irrigidisce. Diventa accusa. Striglia i presenti. Chiede: voi dove eravate, cosa facevate mentre questo orrore si compiva davanti ai vostri occhi? Allarga il perimetro della colpa. Parla di complicità, di omissioni, di reticenze. Non di singoli, ma di un intero territorio. Di una comunità che avrebbe visto, saputo, taciuto. I sindaci applaudono. Applaudono convinti, compatti. Come se quella chiamata in correità, pronunciata trent’anni dopo, fosse una verità liberatoria. Come se bastasse riconoscerla oggi, a favore di telecamera, per mettersi definitivamente dalla parte giusta.
È un passaggio delicato, e anche violento. Perché mescola piani diversi: la responsabilità storica di un contesto, certo, ma anche la semplificazione comoda che scarica tutto su un «territorio», parola neutra che assolve i singoli e rende astratta la colpa. Un territorio colpevole, dunque nessuno colpevole davvero.
Alla fine, però, parla un’altra madre. Non era previsto. Non sale sul palco. Non prende il microfono con solennità. Parla dal pubblico, seduta. È Franca. La madre di Giuseppe. La sua voce è ferma, stanca, senza retorica. «Vorrei spiegare, signor sindaco, da lei e da tutto lo Stato, com’è il discorso». Quale discorso. «Mi dicono che Brusca è qui. I signori Brusca a San Giuseppe Jato vanno e vengono. C’è gente che parla, che fa sapere che ci sono i parenti. Queste persone qua non devono venire. Non devono mettere piede».
È una richiesta concreta, immediata, quasi disperata. È una madre che, trent’anni dopo, chiede ancora protezione. Non per sé, ma per la memoria del figlio. Perché chi lo ha ucciso, o chi ne porta il cognome, non attraversi liberamente lo stesso paese dove suo figlio è stato distrutto. La risposta del sindaco è incerta. Tentennante. «Non lo so», dice. Poi aggiunge che lui, quando nota qualcosa che non va, va sempre dai carabinieri. E infine prova a spostare la questione su un altro piano: si potrebbe proporre ai parlamentari una legge per impedire che i mafiosi tornino in Sicilia. Il confino, insomma.
Ed è qui che tutto si stringe, si chiude, quasi si ribalta. Perché nel luogo in cui si celebra la memoria di un bambino sequestrato, torturato e ucciso dalla mafia, la risposta dello Stato a una madre è un’ipotesi astratta, lontana. Un «si potrebbe». Un domani. Un’altra cerimonia, forse. Lei, invece, parlava dell’oggi. Di nomi che circolano. Di presenze che fanno rumore. Di un dolore che non ha mai smesso di essere concreto. E in quel momento la distanza tra la commemorazione e la realtà diventa enorme. Quasi insopportabile.
Perché finché l’antimafia resta un discorso, una formula, una parola ripetuta ventisei volte in un’ora, può anche permettersi di accusare territori interi. Ma quando una madre chiede conto allo Stato, non parla di legalità. Parla di giustizia. E sono due cose che, sempre più spesso, non coincidono più.
L'articolo La memoria addomesticata dell’antimafia, e l’orrore dell’omicidio di Giuseppe Di Matteo proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0




























































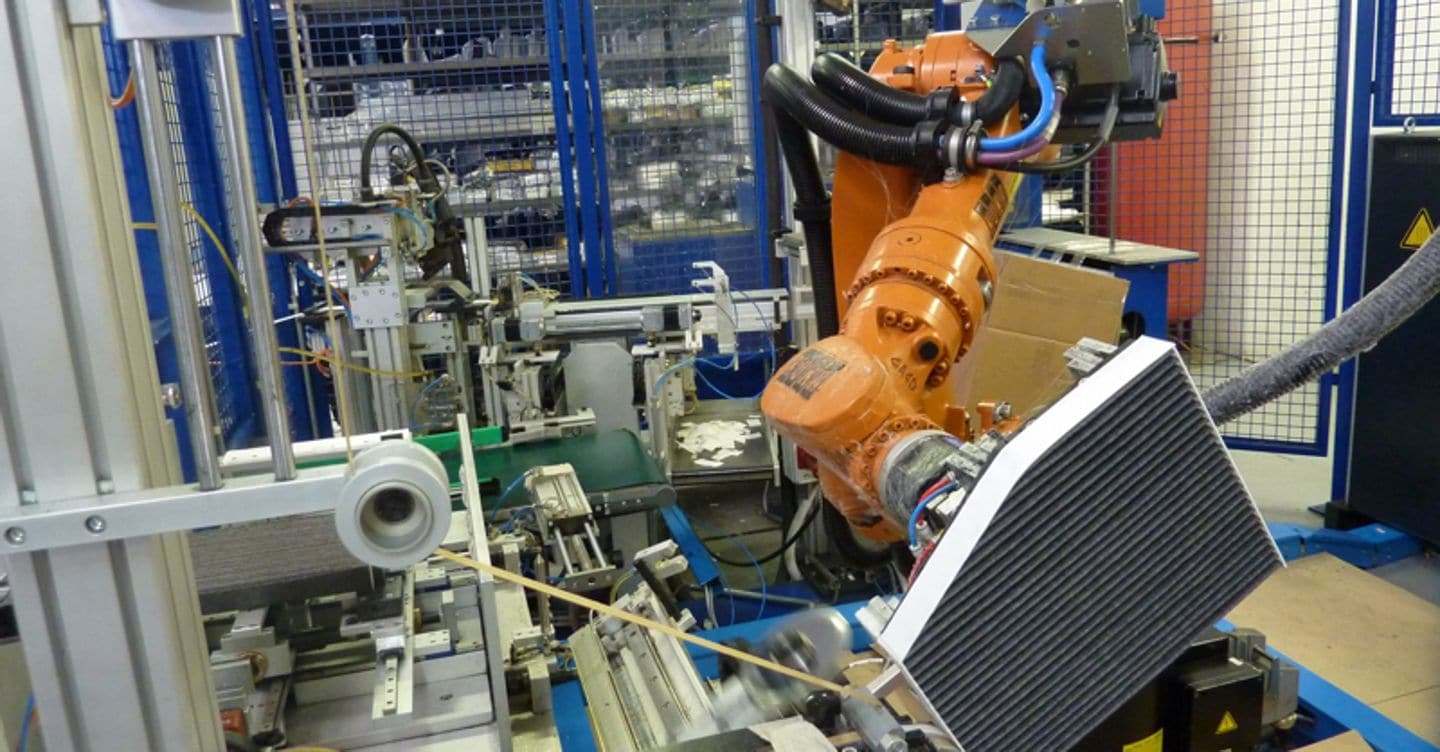
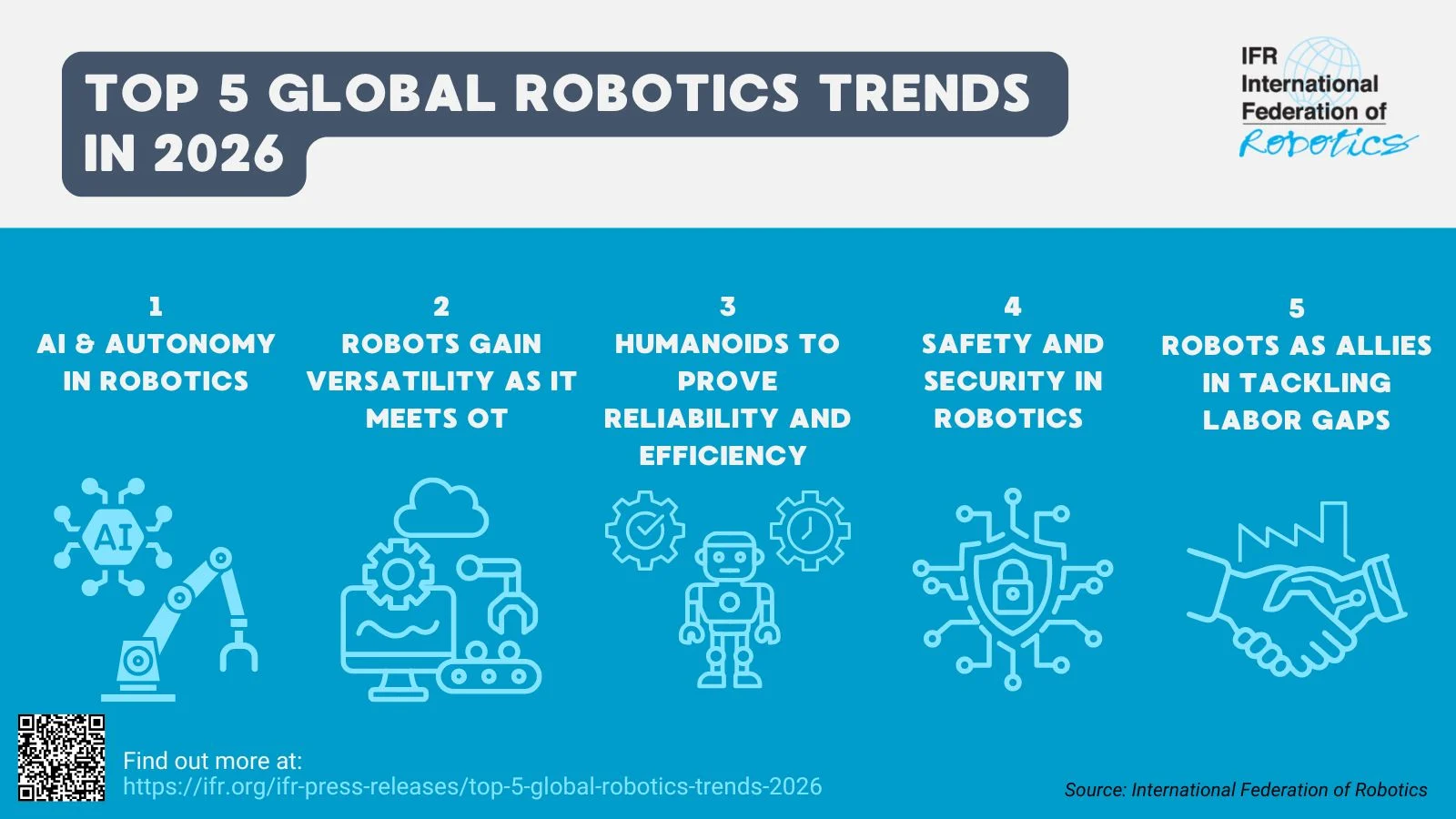

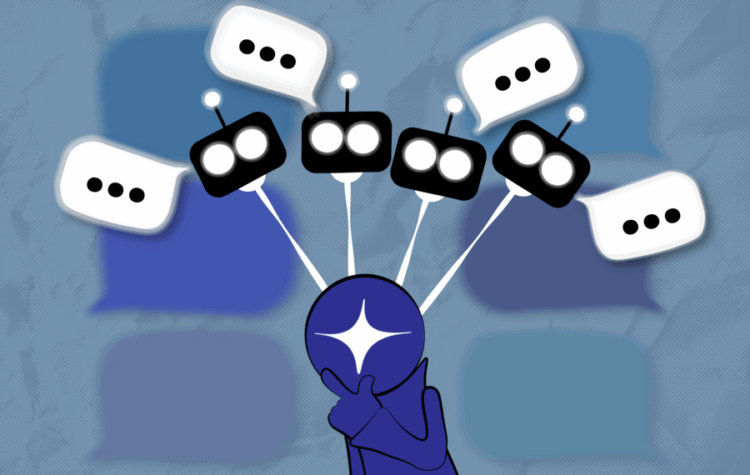

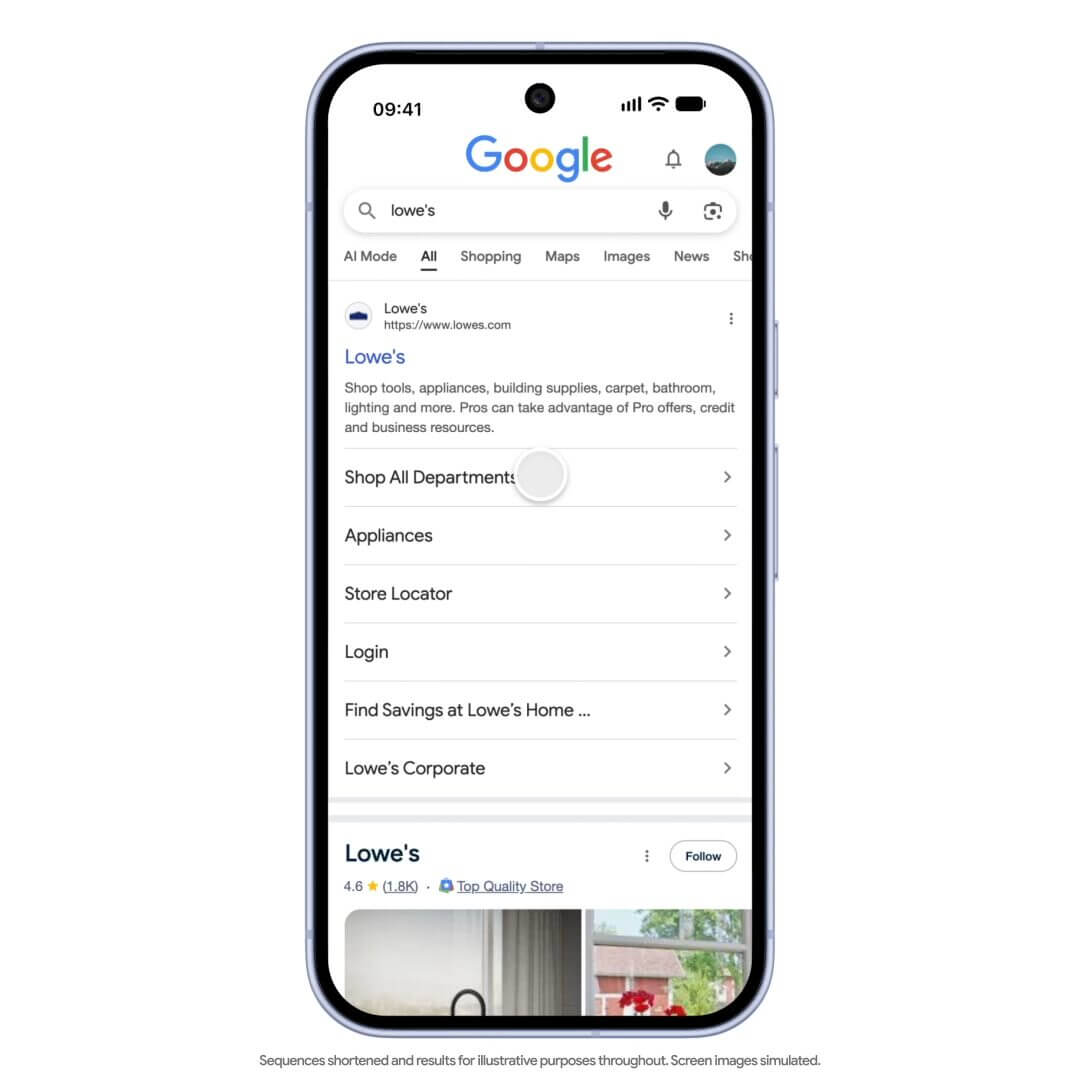



















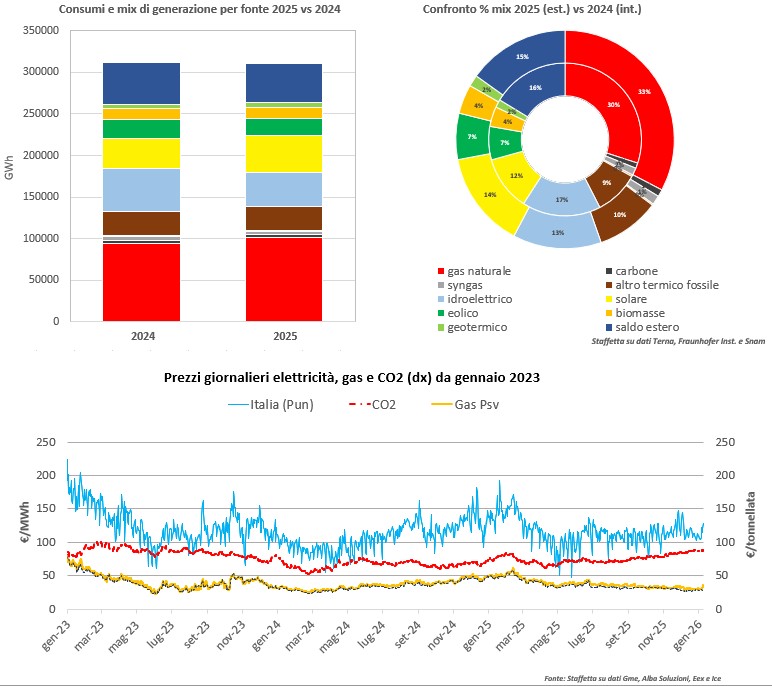


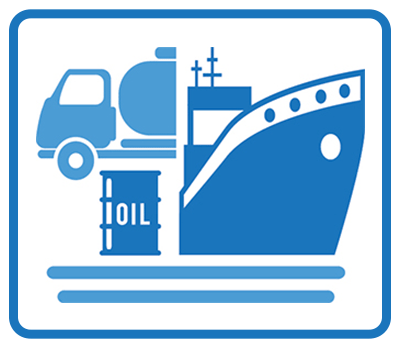








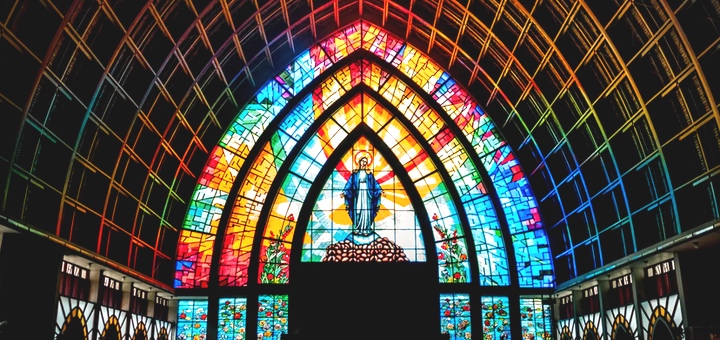
































































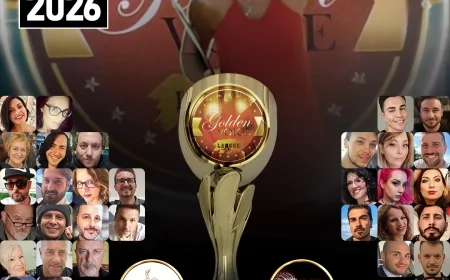




















_(20)-1768127423519.jpg--controlli_in_zona_aurora__sequestri_di_droga_e_alimenti_abusivi.jpg?1768127423667#)
_(17)-1768123566628.jpg--fringe_benefit_2026__bonus_confermati_fino_a_2_000_euro__stop_all_agevolazione_per_i_neoassunti.jpg?1768123566762#)
_(21)-1768128936706.jpg--incendio_boschivo_a_condove__fiamme_domate_grazie_all_intervento_coordinato_dei_soccorsi.jpg?1768128936869#)