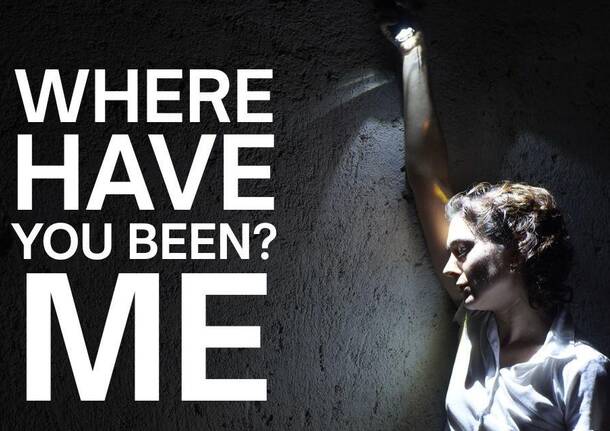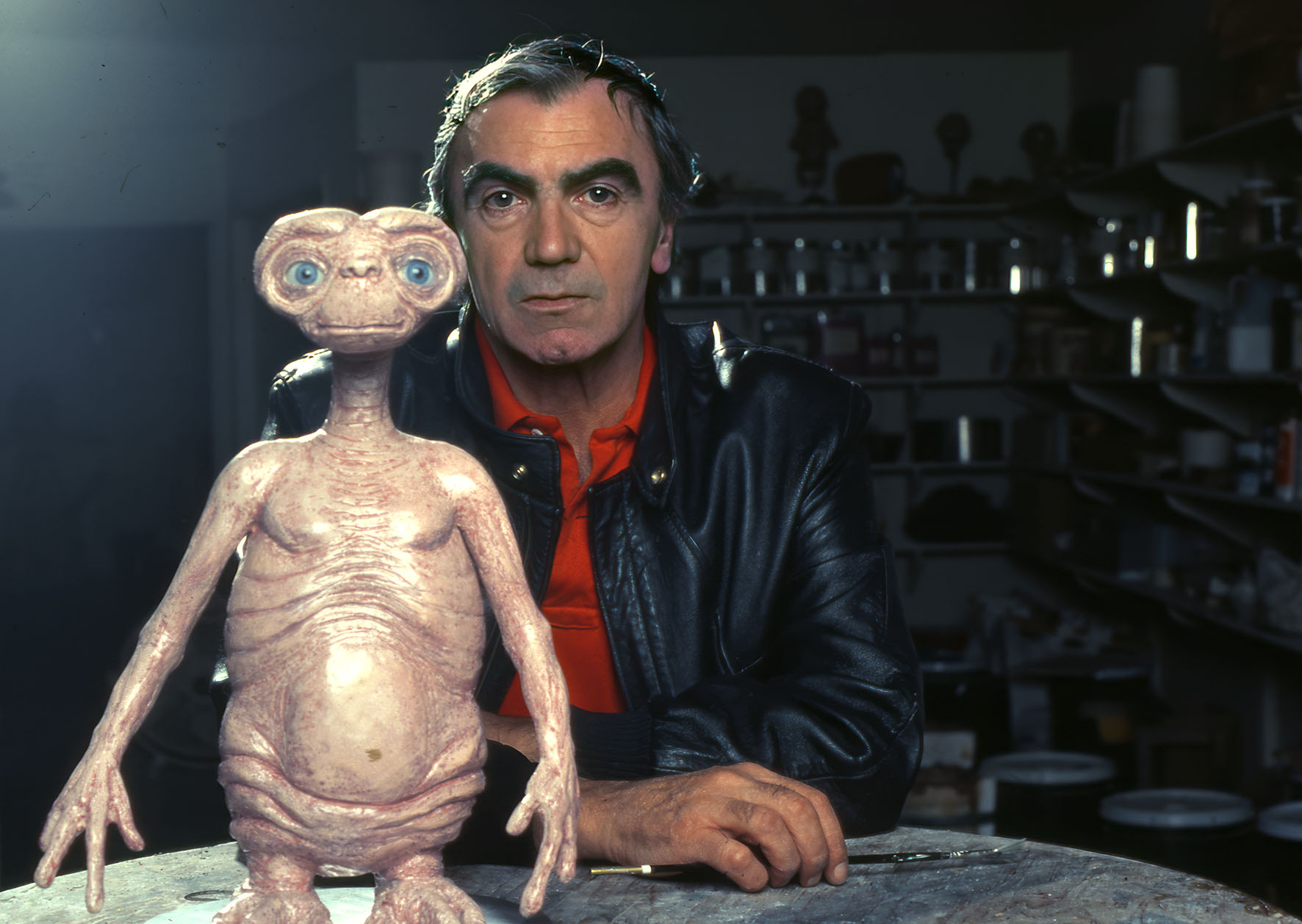Meno beneficiari e meno impatto: così l’assegno di inclusione crea nuovi esclusi

Nuclei familiari nei quali non sono presenti figli minori, persone con disabilità o anziane vengono escluse dal nuovo schema di reddito minimo. Gli stranieri sono ancora svantaggiati da requisiti economici e anagrafici più stringenti, nonostante un parziale allentamento della regola sulla residenza. Sono queste le categorie più penalizzate dalla misura dell’assegno di inclusione. Al contrario, alcune tipologie di famiglie (quelle con figli molto piccoli o monogenitoriali o con disabili) risultano favorite da coefficienti di equivalenza più vantaggiosi. È ciò che emerge dall’VIII Rapporto sul monitoraggio delle politiche contro la povertà di Caritas Italiana Assegno di inclusione, un primo bilancio. Tra dati, esperienze e possibili scenari futuri.
In forte calo i beneficiari
«Il numero di beneficiari del reddito minimo si è ridotto in seguito all’introduzione del requisito categoriale e alla modifica della scala di equivalenza, che esclude dal conteggio tutte le persone adulte e senza carichi di cura nel nucleo, incrementando il reddito equivalente dei nuclei in cui sono presenti tali persone», dice Nunzia De Capite, curatrice del rapporto.
I dati Inps mostrano che dal picco di circa 1,4 milioni di nuclei beneficiari raggiunto tra l’aprile del 2021 e il gennaio del 2022, si è scesi ai circa 650mila nuclei del 2024, in lieve crescita nel 2025.
L’assegno di inclusione purtroppo non solo raggiunge meno persone in povertà, ma l’effetto della misura sul dato di povertà assoluta è più basso Nunzia De Capite, curatrice del rapporto Caritas
«L’assegno di inclusione purtroppo non solo raggiunge meno persone in povertà, ma l’effetto della misura sul dato di povertà assoluta è più basso. Non ci dovremo meravigliare se, nei prossimi anni, la povertà assoluta non viene intaccata perché abbiamo una misura che incide meno su di essa».

La misura taglia fuori le famiglie senza minori
Con l’assegno di inclusione «si è scelto un approccio orizzontale, che ha ristretto la platea con criteri categoriali (presenza di figli minori, di persone con disabilità e non autosufficienza, over 67 anni), indipendentemente dal livello di povertà e lasciando così nuclei fragili scoperti», prosegue De Capite.
«Questa misura crea nuove forme di esclusione e mantiene delle diseguaglianze che già c’erano con la precedente misura. I problemi che avevamo con il reddito di cittadinanza non li abbiamo risolti. L’assegno di inclusione crea nuovi esclusi perché adotta dei criteri e dei requisiti di accesso che sono fondamentalmente basati sulle condizioni familiari. C’è una quota di popolazione, soprattutto famiglie senza figli minori, che è completamente “tagliata fuori” dalla misura: sono le persone che il governo definisce occupabili, ma che sono occupabili in teoria, ma di fatto sono impossibilitate ad essere reinserite nel mercato del lavoro».
Nel Nord si trova oggi il 41% delle famiglie povere assolute, ma solo il 15% delle famiglie che ricevono l’assegno di inclusione. Nelle regioni meridionali vive il 45% dei nuclei in povertà assoluta, ma il 68% delle famiglie che percepiscono l’assegno di inclusione Nunzia De Capite, curatrice del rapporto Caritas
«In molte famiglie senza figli minori non sono presenti forme di invalidità o di disabilità certificate, che è l’altro grosso vincolo che adesso è richiesto dall’assegno di inclusione. Infatti, si può accedere alla misura se si hanno figli minori, carichi di cura di anziani non autosufficienti e persone con disabilità, o se si hanno delle forme di disabilità e di disagio sociale certificate dalle pubbliche amministrazioni», prosegue De Capite.
«Il cinquantenne che non lavora più come manovale perché ha problemi alle articolazioni non è un invalido civile, quindi non prende la pensione, ma non può accedere all’assegno di inclusione, viene dirottato verso misure come il Supporto formazione lavoro, che però è una misura problematica perché è legata ai corsi professionalizzanti, che a volte sono partiti in ritardo e che non hanno avuto finora sbocchi professionali per chi li ha seguiti. Quindi, ripeto, abbiamo una fascia di popolazione di adulti senza figli minorenni, singoli o in coppia, che non sono più tutelati e che difficilmente possono, in molti casi, nella platea di persone che incontriamo, ricollocarsi sul mercato del lavoro».
Riduzione del 40% dei beneficiari tra gli stranieri
Per i cittadini extracomunitari il reddito di cittadinanza richiedeva 10 anni di residenza in Italia, di cui gli ultimi due continuativi. «Con l’assegno di inclusione il requisito è stato ridotto a cinque anni, ma nonostante questo miglioramento gli stranieri restano sottorappresentati tra i beneficiari, benché il loro tasso di povertà sia nettamente superiore a quello delle famiglie italiane. La nuova scala di equivalenza penalizza fortemente le famiglie numerose, spesso straniere, e questo effetto ha più che compensato l’allentamento del vincolo sulla residenza», sottolinea la curatrice del rapporto.
«Purtroppo i criteri categoriali e familiari stanno escludendo moltissimi cittadini stranieri che non hanno figli e, quindi, non rientrano nei nuovi requisiti previsti dalla misura. E l’impatto sui cittadini stranieri è stato molto forte. I dati ce lo dicono. Tra luglio 2023, con il reddito di cittadinanza, e giugno 2025, con l’assegno di inclusione, la riduzione percentuale nel numero di nuclei beneficiari è stata maggiore per gli stranieri (-40%) rispetto agli italiani (-35%), indicando una maggiore penalizzazione del primo gruppo rispetto al secondo con le nuove misure».
Tra luglio 2023, con il reddito di cittadinanza, e giugno 2025, con l’assegno di inclusione, la riduzione percentuale nel numero di nuclei beneficiari è stata maggiore per gli stranieri (-40%) rispetto agli italiani (-35%) Nunzia De Capite, curatrice del rapporto Caritas
Discrepanza geografica dei poveri e dei beneficiari
Si conferma poi, come già accadeva con il reddito di cittadinanza, una forte discrepanza tra la distribuzione geografica dei poveri e quella dei beneficiari. «Nel Nord si trova oggi il 41% delle famiglie povere assolute, ma solo il 15% delle famiglie che ricevono l’assegno di inclusione. La scelta di criteri uniformi penalizza le famiglie residenti nelle regioni settentrionali e nelle grandi città perché la misura non è calibrata sul costo della vita, e può generare “falsi positivi” (non poveri che ricevono il trasferimento), in particolare al Sud. Nelle regioni meridionali vive il 45% dei nuclei in povertà assoluta, ma il 68% delle famiglie che percepiscono l’assegno di inclusione (contro il 66% con il reddito di cittadinanza)», continua De Capite.

Le persone “invisibili”
Dai focus group di Caritas emergono alcune figure “invisibili”, “zone grigie” che rischiano di sfuggire del tutto alle nuove misure. «Sono le donne vittime di tratta, spesso senza dimora e fuori dai circuiti ufficiali, per le quali l’accesso al supporto per la formazione e il lavoro o all’assegno di inclusione è praticamente impossibile. Oppure persone con pendenze penali o in misure alternative alla detenzione: ex detenuti, affidati in prova, che formalmente fanno ancora parte di nuclei familiari (magari lontani) e per ragioni tecniche risultano esclusi dall’assegno di inclusione, oppure non vengono considerati “attivabili” in modo adeguato».
Un altro caso citato nel rapporto è quello dei nuclei familiari “spezzati” dalle regole Isee: ad esempio genitori single con figli a carico non riconosciuti come nuclei monogenitore a causa della presenza formale di un altro adulto nello stato di famiglia, o famiglie allargate i cui componenti vengono considerati insieme ai fini economici pur vivendo separati. «Il risultato di queste esclusioni è palpabile nei centri Caritas: persone che fino al 2023 contavano sul reddito di cittadinanza ora si riversano nuovamente nei centri Caritas», continua De Capite. Queste persone che sono nelle “zone grigie” «magari non sono state prese in carico dai servizi pubblici, sono state aiutate dal Terzo settore o dalle realtà associative e non hanno invalidità o disabilità certificate. Quindi è un limbo che rimane completamente scoperto o che sta facendo dei tentativi per la certificazione della condizione di disagio, che è molto problematica».
Sempre più “paracadute”
Un dato trasversale emerso dal rapporto è che, anche chi percepisce regolarmente l’assegno di inclusione o il supporto per la trasformazione e il lavoro, continua a rivolgersi alle Caritas. «I nostri operatori raccontano di famiglie che tornano a presentarsi più spesso di prima. Intravediamo il grosso rischio di uno schiacciamento su richieste di beni materiali e assistenziali. Nel rapporto abbiamo usato un’immagine forte. Veniamo vissuti come “paracadute”, cioè come aiuto di ultima istanza. Questo va bene, ma non riusciamo più, come un tempo, a fare progetti promozionali, a fare da “trampolino”: diventa sempre più difficile dare un aiuto personalizzato e promozionale alla persona. È molto più frequente che ci troviamo a dover “tamponare” e a mettere delle toppe perché sono numerose falle si stanno aprendo nel sistema pubblico».
Ci sono persone che, in alcuni centri di ascolto Caritas, chiedono un pacco viveri aggiuntivo a metà mese perché hanno già terminato l’assegno di inclusione, oppure famiglie che domandano piccoli aiuti economici per evitare distacchi di luce e gas Nunzia De Capite, curatrice del rapporto Caritas
Il rapporto spiega che, in alcuni centri di ascolto Caritas, l’affluenza è aumentata significativamente e gli empori solidali registrano un balzo di accessi. Ci sono persone che chiedono un pacco viveri aggiuntivo a metà mese perché hanno già terminato l’assegno di inclusione, oppure famiglie che domandano piccoli aiuti economici per evitare distacchi di luce e gas. Emblematico il caso riportato a Roma, dove per molti nuclei l’assegno di inclusione è l’unica fonte di reddito e il bisogno più urgente segnalato ai centri della capitale è ottenere un alloggio.
«C’è anche una difficoltà maggiore, da parte dei proprietari di casa, ad affittare a chi prende l’assegno di inclusione. Inoltre, abbiamo richieste di aiuto sempre più continuativo, sempre più frequente e prese in carico complesse», precisa De Capite. «Stiamo registrando un aumento fortissimo di casi di disagio psicologico, di persone borderline, che non sempre riescono a essere seguite adeguatamente dai servizi e che le Caritas devono gestire con grande fatica».
Proposte di miglioramento delle misure
Dalle voci degli operatori Caritas emergono diverse indicazioni su come migliorare assegno di inclusione e supporto per la formazione e il lavoro, a partire dall’esperienza quotidiana con le persone in difficoltà. «Ampliare i criteri di accesso e la platea è la prima indicazione. In molti auspicano che l’assegno di inclusione diventi più inclusivo, includendo le fragilità non certificate (ad esempio, invalidità sotto il 67% ma di fatto invalidanti, disagio psichico senza riconoscimento e rivedere criteri anagrafici troppo rigidi. Un’altra indicazione emersa è la necessità di strutturare équipe multidisciplinari, ciò permetterebbe alla Caritas e ad altre associazioni del territorio di intervenire e di fare ognuna la propria parte di lavoro, in un quadro integrato e multidisciplinare rispetto all’intervento pubblico».
Foto di apertura LaPresse – Matteo Corner, Inaugurazione emporio della solidarietà di Caritas ambrosiana a Lambrate. Grafici tratti dall’VIII Rapporto sul monitoraggio delle politiche contro la povertà di Caritas
L'articolo Meno beneficiari e meno impatto: così l’assegno di inclusione crea nuovi esclusi proviene da Vita.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0










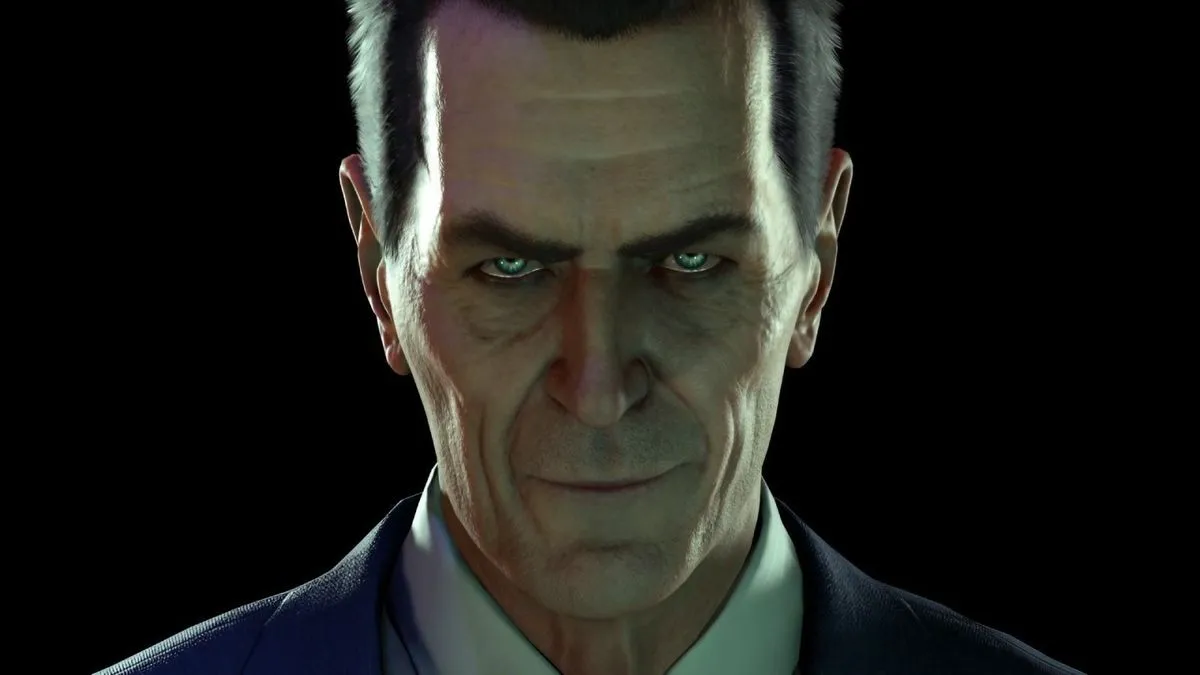







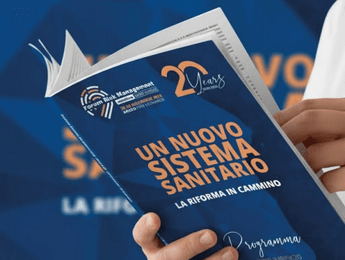























.png)











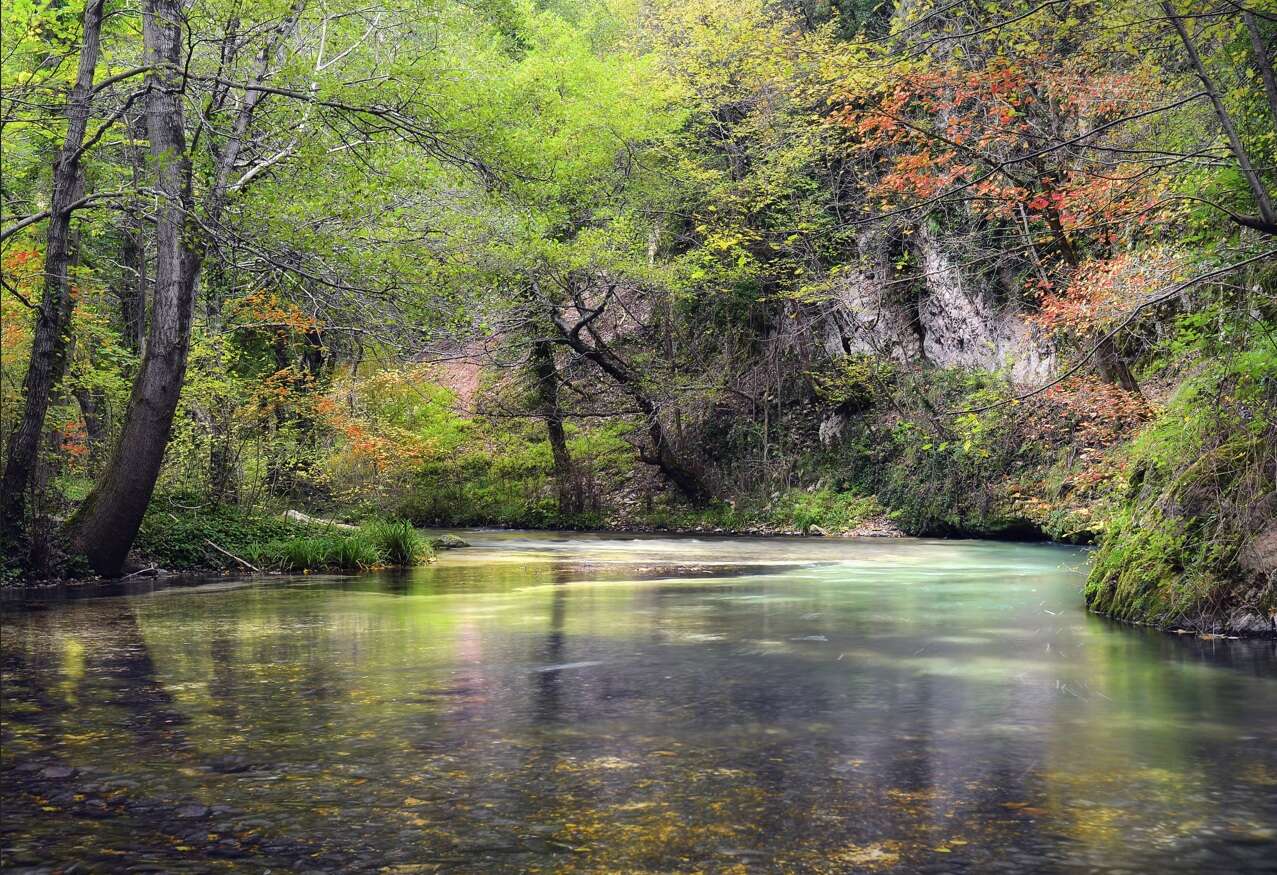




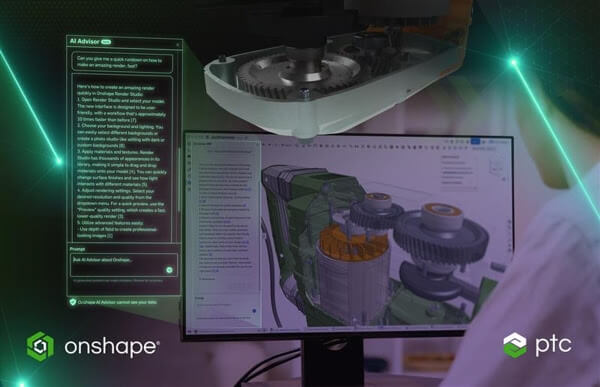





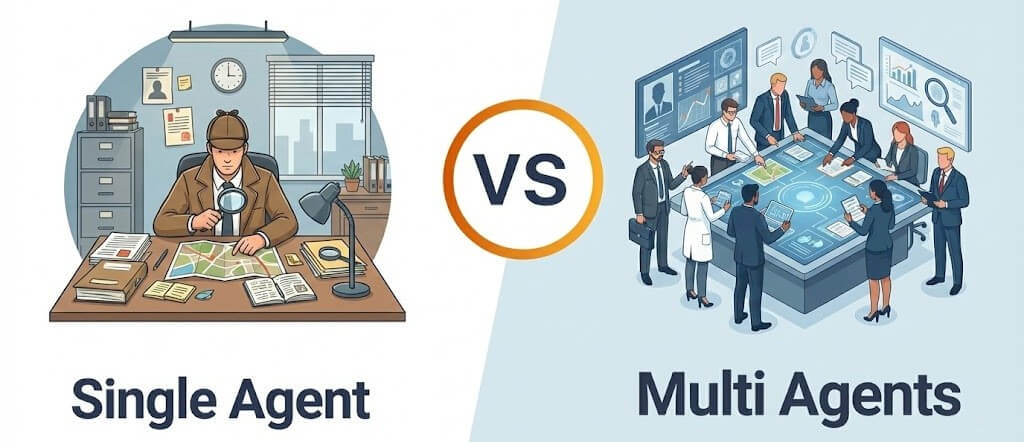

















/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/11/uomo-felice-guarda-laptop-personale.jpg)





















































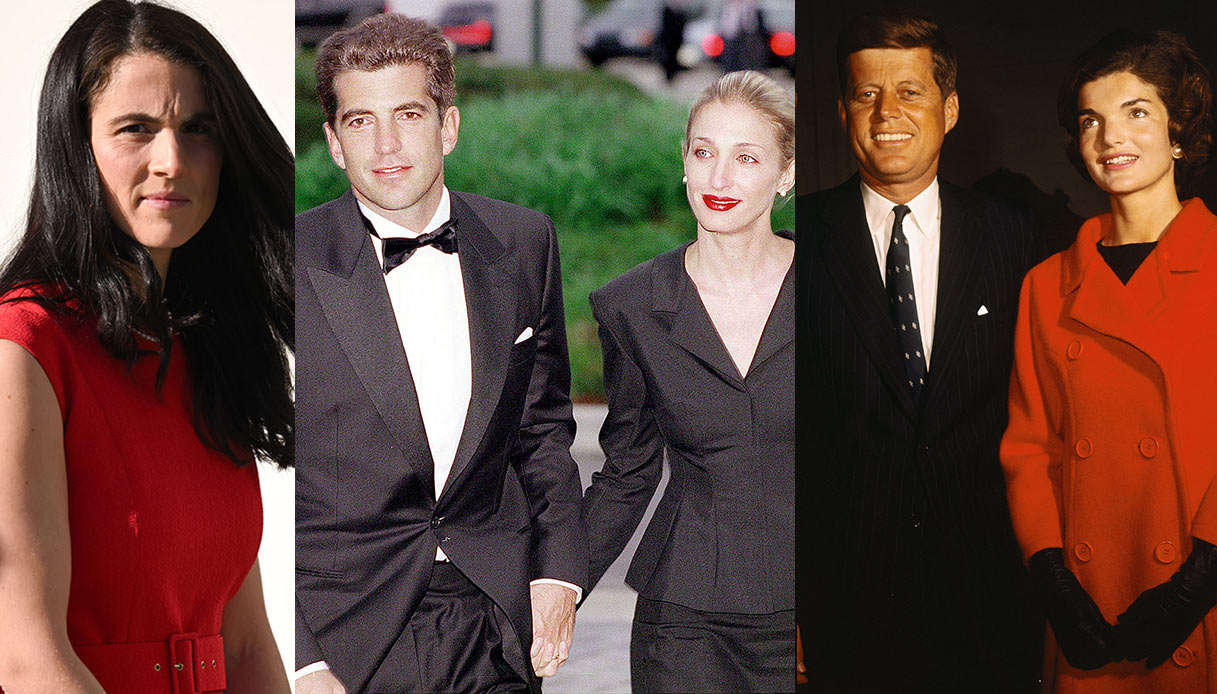




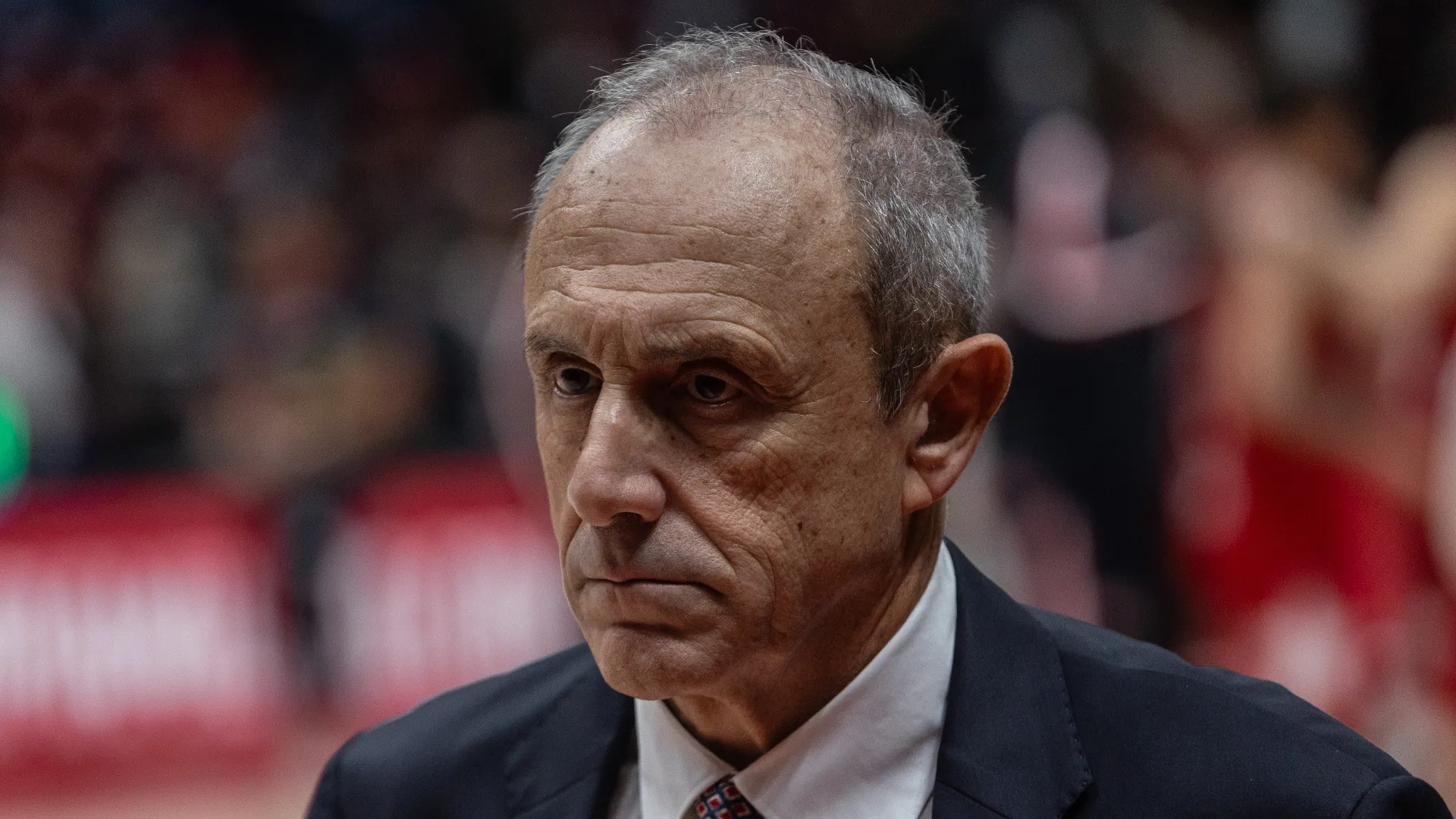























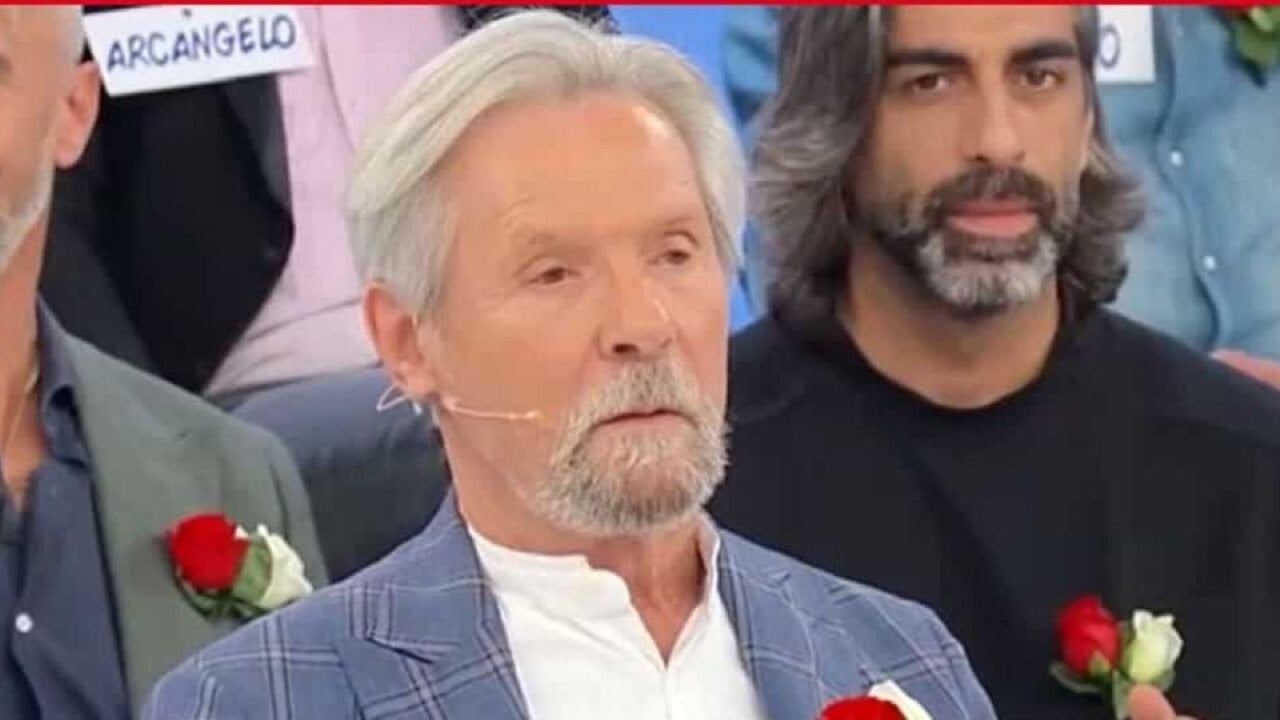

















ddd-1763990389998.jpeg--una_partita_di_monopoly_a___torino__da_oggi_e_realta.jpeg?1763990390034#)






-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)