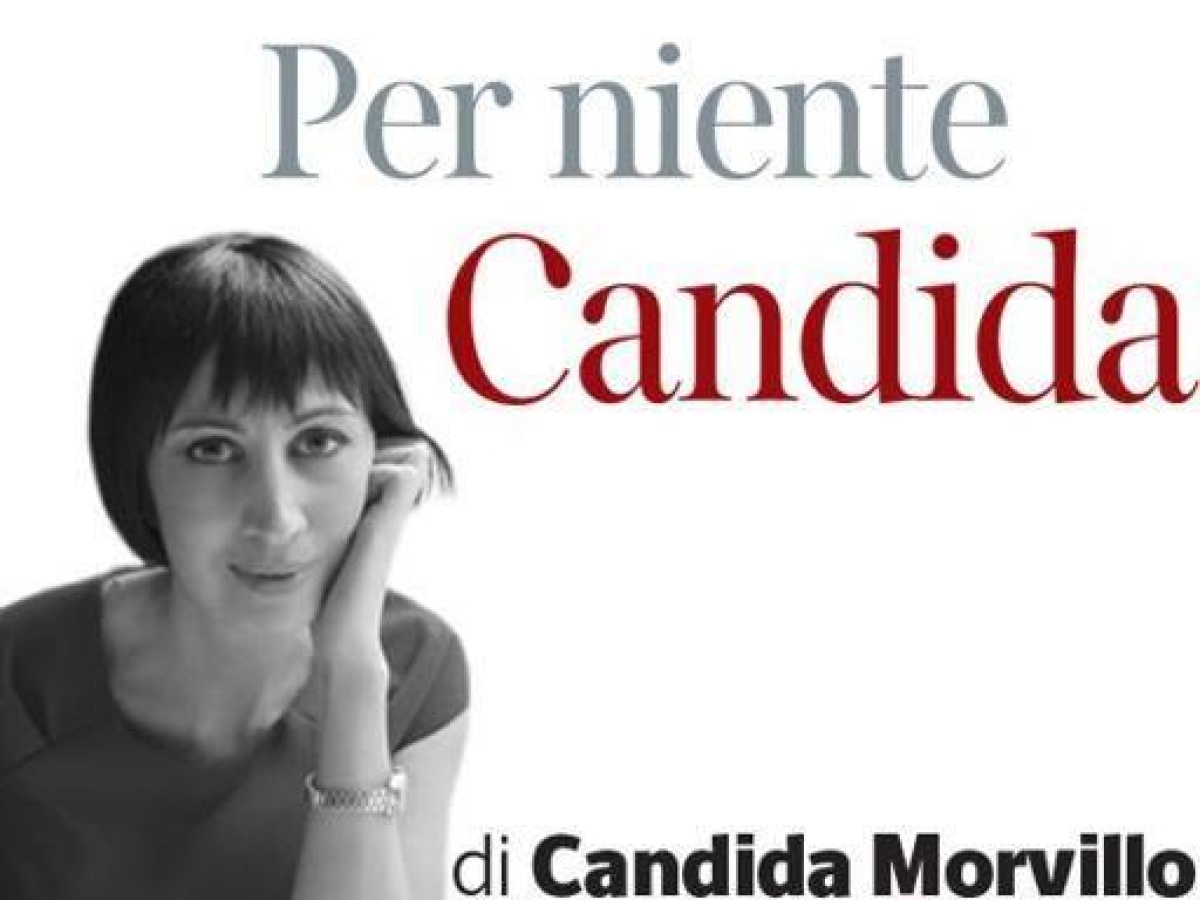Quando l’incubo della crisi climatica dà vita all’utopia anarchica


«La vera rivoluzione deve cominciare dentro ciascuno di noi», sussurra con bocca mezza sdentata l’anziana signora Giovanna durante l’assemblea. È fra i fortunati superstiti della catastrofe climatica che s’è appena abbattuta su Milano a seguito di una crisi energetica planetaria, un blackout mondiale. Di un cataclisma che, fra i danni e le vittime, ha però anche fatto riemergere i corsi d’acqua che erano stati sepolti da catrame e cemento, restituendo all’acqua dei canali il colore cristallino ormai perduto da anni; all’aria un profumo finalmente pulito e respirabile. Dopo il disastro è tempo di ripensare a un mondo nuovo, tutti riuniti in assemblea. E la vera ripartenza deve prendere avvio nell’anima di ogni singolo.
«Ho recuperato la tesi anarco-primitivista della rivoluzione che deve avvenire in interiore homine da La vita agra di Luciano Bianciardi», racconta Luigi Vittoria, autore del testo di Benvenuta catastrofe! (Regia di Mario Gonzalez), lo spettacolo di cui è anche unico interprete in scena, e che ha partecipato all’ultima edizione del festival teatrale Fringe Milano Off. Il racconto è liberamente ispirato a L’Apocalisse rimandata di Dario Fo, «un testo che ha scritto quando era ormai molto vecchio e che non ha mai messo in scena», prosegue Luigi. «Da lui ho preso l’idea portante, quella del blackout da crisi energetica che improvvisamente blocca tutto».

Come nella drammaturgia di Fo, anche in Benvenuta catastrofe! dalla situazione tragica iniziale pian piano si passa alla realizzazione dell’utopia anarco-comunista: spazzato via dal cataclisma il modello economico capitalistico, gli ecosistemi tornano a prosperare rigogliosi e l’umanità ritrova l’armonia con la natura, nutrendosi dei frutti della Terra e auto-organizzandosi in modo più equo e giusto intorno alla massima «da ciascuno secondo le sue capacità, a ognuno secondo i suoi bisogni».
La tesi di Bianciardi, il fatto che ogni scelta privata abbia delle ripercussioni economiche e politiche, attraversa tutto lo spettacolo sin dall’inizio. Abat-jour accese, pubblico semi-illuminato in sala e quarta parete assente, l’incipit è infatti un chiaro esempio del cosiddetto butterfly effect: la teoria secondo cui il battito d’ali d’una farfalla possa indirettamente provocare un uragano. In altre parole: anche un fatto piccolo e apparentemente insignificante può avere conseguenze macroscopiche, anche se non le vediamo.
«È mezzogiorno. Hai fame, ma in casa non hai niente da mangiare. Che fai? Scendi al supermercato e compri una vaschetta di prosciutto. Tutto normale, no?», inizia il racconto in forma di dialogo. Certo, tutto normale, se non fosse che quella carne probabilmente viene dall’allevamento intensivo di qualche multinazionale, e gli allevamenti intensivi sono fra le prime cause al mondo di deforestazione. Inizia così una lunga catena di cause ed effetti degna di Ci vuole un fiore di Sergio Endrigo – ma nella sua versione tossica e distruttiva, dove la fine si ritorce contro l’inizio.
La deforestazione, infatti, ha un impatto negativo sull’effetto serra, una cappa di calore e inquinamento: le sostanze nocive si legano al vapore acqueo delle nuvole e cadono sotto forma di piogge acide. In questo ciclo dell’acqua malato, le precipitazioni bruciano alberi, penetrano nelle falde sotterranee e finiscono nei ruscelli, che a loro volta si convogliano in torrenti. Questi scorrono giù a valle, fluiscono nei canali che passano vicino ai nostri condomini, nelle fogne, si riversano nei fiumi. Fiumi nei quali le industrie hanno vomitato veleni, fiumi che poi si gettano nel mare. Un mare inquinato da petroliere, navi da guerra, yacht e tanto altro, acqua che a sua volta intossica i pesci che poi ci troviamo nel piatto. Tutto cominciato con una vaschetta di prosciutto a mezzogiorno.
Se questa è la realtà – alla quale ciascuno di noi contribuisce (o meno) con le proprie scelte quotidiane – il sogno si trasforma in una forma di evasione per poterne uscire. Sono le undici del mattino, hai dormito tanto, è l’ora di alzarsi. Schiacci il tasto dell’interruttore, clic, clic, ma niente, non si accende la luce. In cucina il frigo è spento e il gas non esce dai fornelli. L’ascensore non funziona, bisogna usare le scale. Ed ecco la scoperta: in strada una grande folla che grida al blackout generale, mondiale. «Lo sapevamo benissimo che una crisi energetica sarebbe arrivata, prima o poi!», grida una ragazzina, forse allegoria di Greta Thunberg.

Nella calca del panico generale si stagliano alcuni personaggi, tutti interpretati in pantomima da Luigi Vittoria: la vecchia signora Giovanna, serafica e ottimista, che accoglie l’inaspettata battuta d’arresto come un’occasione di pausa collettiva dalla frenesia, una pausa che pulirà l’aria: «Tra qualche settimana ci sembrerà di stare in montagna!», esulta; il signor Cheng, stakanovista proprietario di un bar-tabacchi, è disperato perché nel collasso della società il denaro non ha più alcun valore, e il crollo finanziario globale ha mandato in fumo i risparmi di tutta una vita, bruciati nella caduta della borsa di Hong Kong. Ora le sigarette si possono acquistare solo col baratto o “pagando” in lavoro come lavapiatti sul retro.
In questa sequela di figure che ricordano gli incontri de Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry – la cui bellezza sta proprio nella recitazione dell’attore – è quindi il turno del milionario, che dall’ultimo piano di uno dei due palazzi del Bosco Verticale si spoglia di tutti i suoi averi. Come nella scena di San Francesco, ma stavolta a causa della bancarotta del modello economico capitalistico, eccolo gettare dall’alto le chiavi delle sue Porche-Lamborghini-Bugatti e delle sue ville al mare; eccolo gettare i suoi oggetti di design; eccolo gettare i suoi stessi vestiti. «Gli unici che possono ridere, oggi, sono quelli che non avevano niente!», urla prima di buttarsi nel vuoto, nudo come un verme. E poi salvarsi con rimbalzi rocamboleschi.
Infine c’è Salvatore, detto Siddy. Un bravo ragazzo, ma malvisto in quartiere per via dei tanti tatuaggi che tappezzano corpo e faccia. Quello che chiamano con disprezzo “il drogato”, “lo zarro”, è però l’unico ad avere ancora l’elettricità, con la quale pompa musica dalle casse, e la gente balla sotto casa sua: da anni ha ricoperto balcone e tetto di pannelli fotovoltaici, e ora è autosufficiente.
Inizia così l’esodo dalle città: «Per la prima volta negli ultimi secoli il processo di inurbamento di rovescia. Si svuotano le città e si riempiono le campagne». L’aria è già molto più pulita, più tersa: ma ecco che quando sembra tutto stia prendendo una piega bucolica, tutto a un tratto nel cielo si addensano nubi nerissime e minacciose, il vento sfera le case e rovescia le tegole, comincia il diluvio universale. Erompono boati dal sottosuolo, riemergono i torrenti, le strade si trasformano in fiumi impazziti, Milano ora sembra Venezia.
L’uragano porta via tutto: i grattacieli di piazza Tre Torri, i palazzi di lusso di City Life, e pure un signore affacciatosi alla finestra per gridare: «Vai, strappa tutto! Ci stai ridando la nostra città… Benvenuta, catastrofe!», e poi via nel vento come uno straccio urlante.

I sopravvissuti si riuniscono per ricostruire la società, per ripensarla dalle fondamenta, dar vita a un mondo nuovo, più giusto e finalmente in armonia con la natura. Fra i superstiti c’è la vecchia signora Giovanna, che si auspica il cambiamento parta dall’interiorità di ciascuno; Cheng, che per la prima volta ha chiuso il bar-tabacchi: «La gente deve imparare a non produrre più niente del necessario, a non farsi nascere bisogni nuovi. E anzi: dobbiamo imparare a rinunciare a molti “bisogni” che abbiamo già», dichiara in assemblea.
All’economia di mercato si sostituirà quella del baratto. Ancora meglio: quella del donativo, all’interno di comunità dove ciascuno diverrà maestro in ciò che più gli piace, e il lavoro non sarà più dovere alienante, ma espressione delle inclinazioni più profonde del proprio Io.
Anche in Africa, nel frattempo, è scoppiato il cataclisma, ma ora la natura è rigogliosa, la madre Terra potrà provvedere alla vita di tutti, in un continente finalmente libero dagli imperialisti occidentali, fuggiti su una nave. Ecco allora che tutti coloro che avevano raggiunto l’Europa in pericolose traversate del Mediterraneo iniziano a fare ritorno alle loro terre grazie a pittoreschi veicoli aerei a retrocarica, a molla o mossi da altri strani congegni.
Suona la sveglia. La luce si accende, il frigorifero funziona, il gas esce dai fornelli. Era tutto un sogno. Ma manca una scena, l’ultima. «Oltre all’idea centrale, anche la scena finale è direttamente ripresa dal testo di Dario Fo», racconta a Linkiesta Luigi Vittoria: la metafora degli gnu.
A un certo punto della loro esistenza, si dice che gli gnu, spinti da una sconosciuta follia, inizino a correre con il resto della mandria lungo le distese della prateria, finché talvolta non arrivano sul ciglio di un burrone. Nessuno del brano frena, nessuno si arresta, e così un’immensa voragine si spalanca davanti alle loro zampe impazzite: è una sequenza infinita di caute, di salti nel vuoto, un precipitare di massa nell’abisso. «Questa mandria di gnu lanciati verso il baratro siamo noi, tutti noi». E quando arriverà l’apocalisse, «in tanti grideranno: “No, no! Vogliamo vivere!”. È troppo tardi, coglioni».
L'articolo Quando l’incubo della crisi climatica dà vita all’utopia anarchica proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0









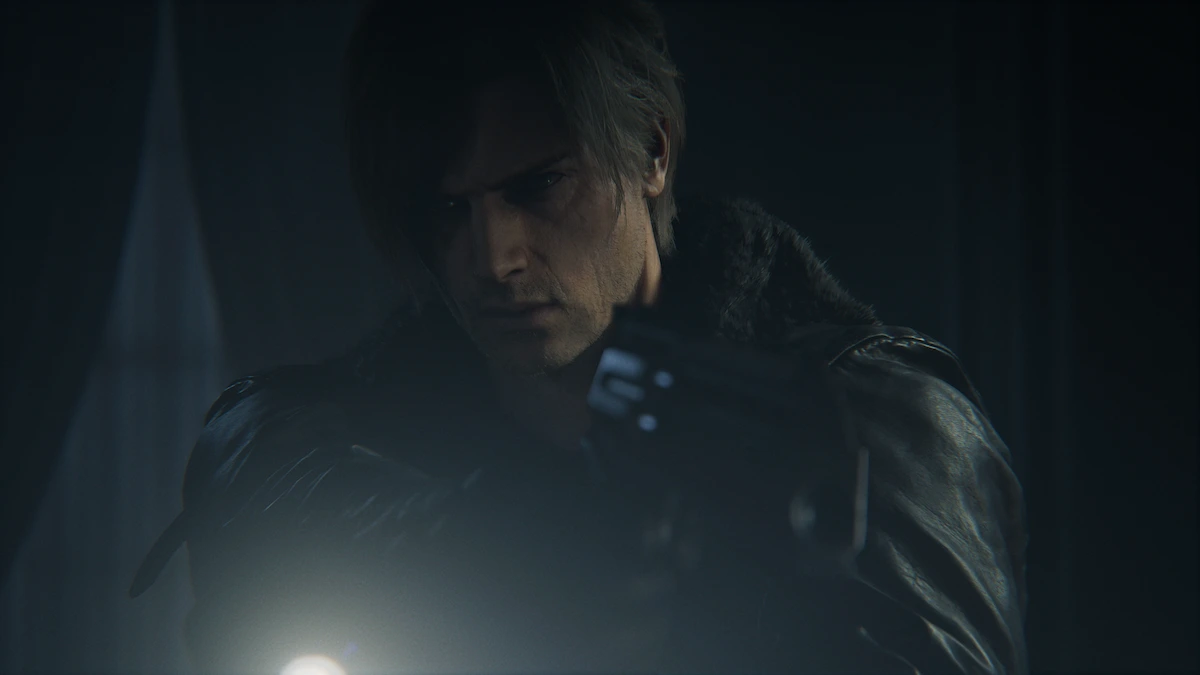























![Mondiale WRC 2026. Nel bene e nel male sarà stagione cruciale. Allora, vogliamo essere seri? [VIDEO]](https://img.stcrm.it/images/48295138/1200x/si202510171702.jpg)































 Fonderie Ariotti S.p.a.-U88165282343aAr-1440x752@IlSole24Ore-Web.jpg?#)



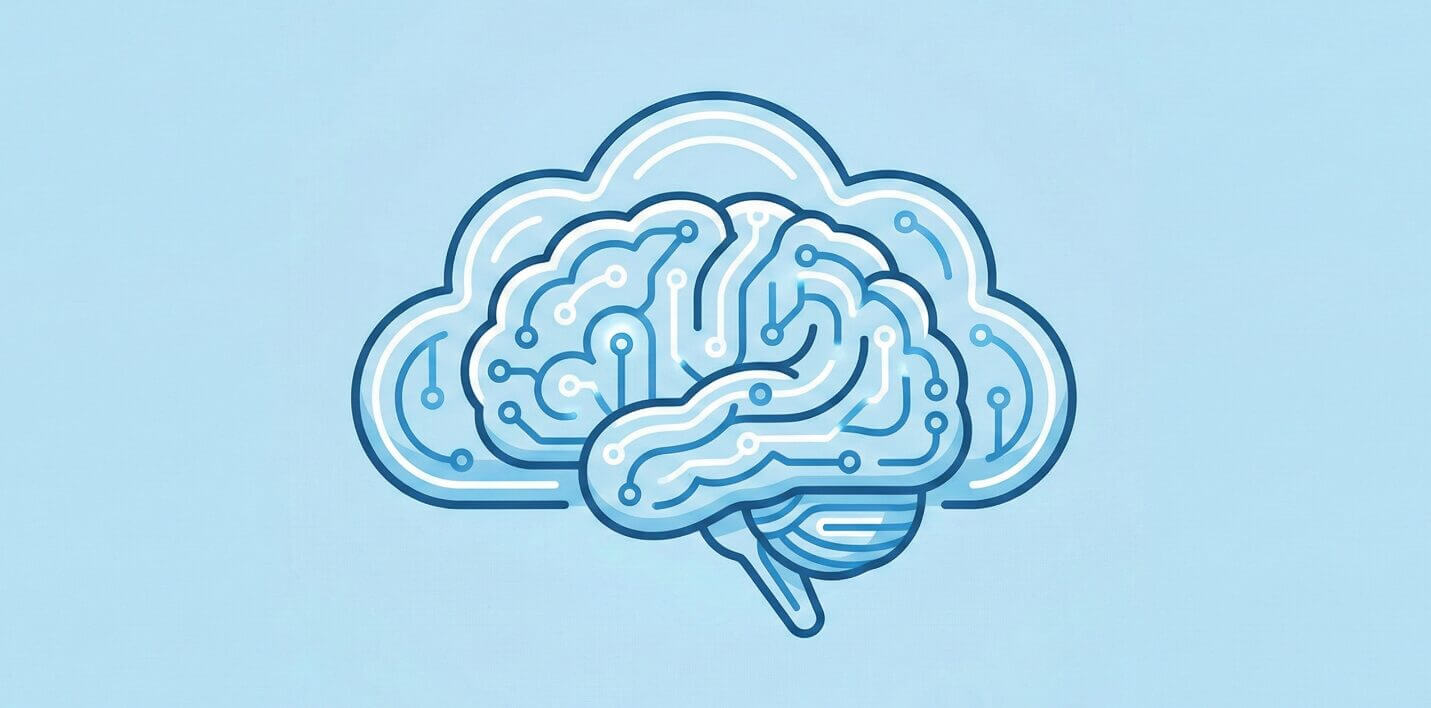









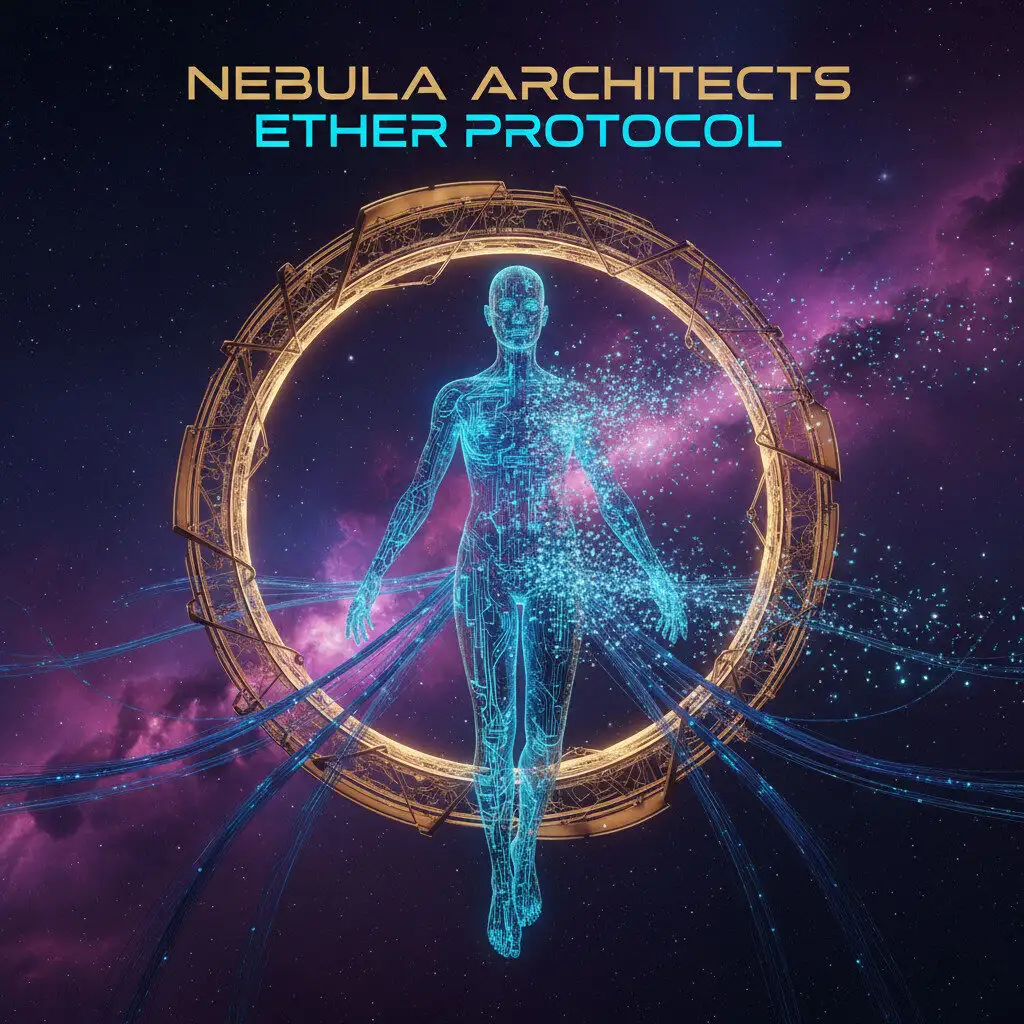



/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/12/offerte-attuale-coinbase-incredibile-approfittane-subito.jpg)























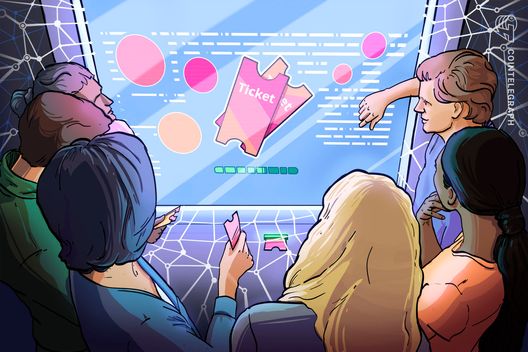






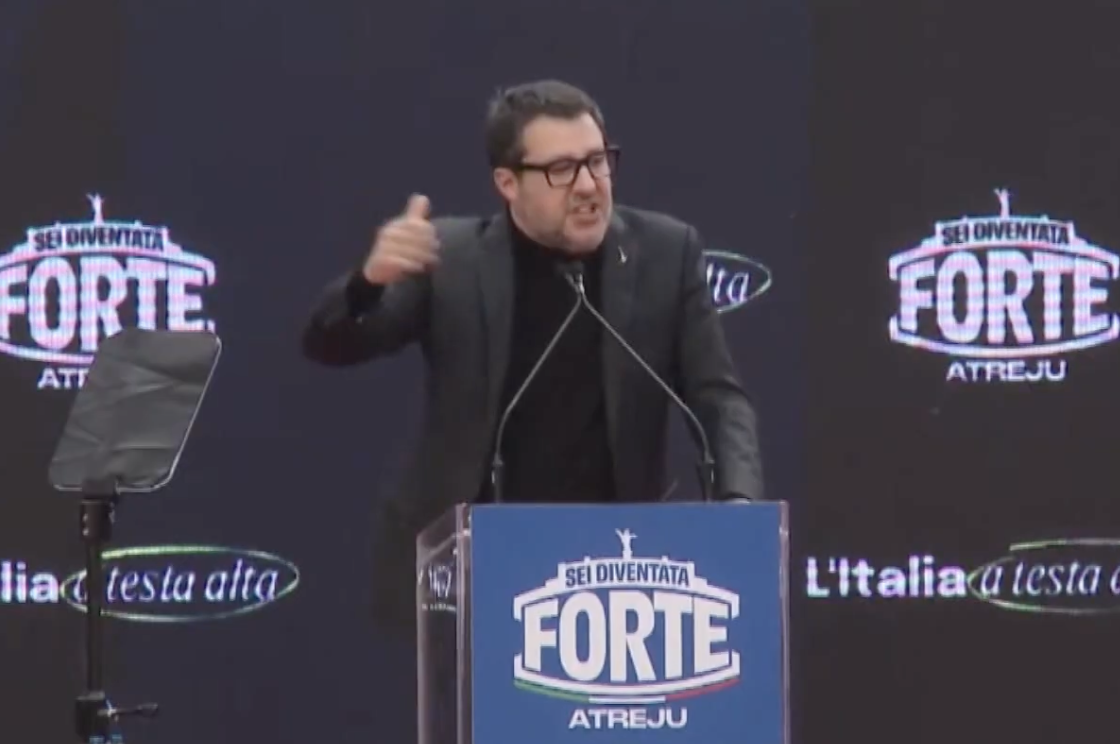












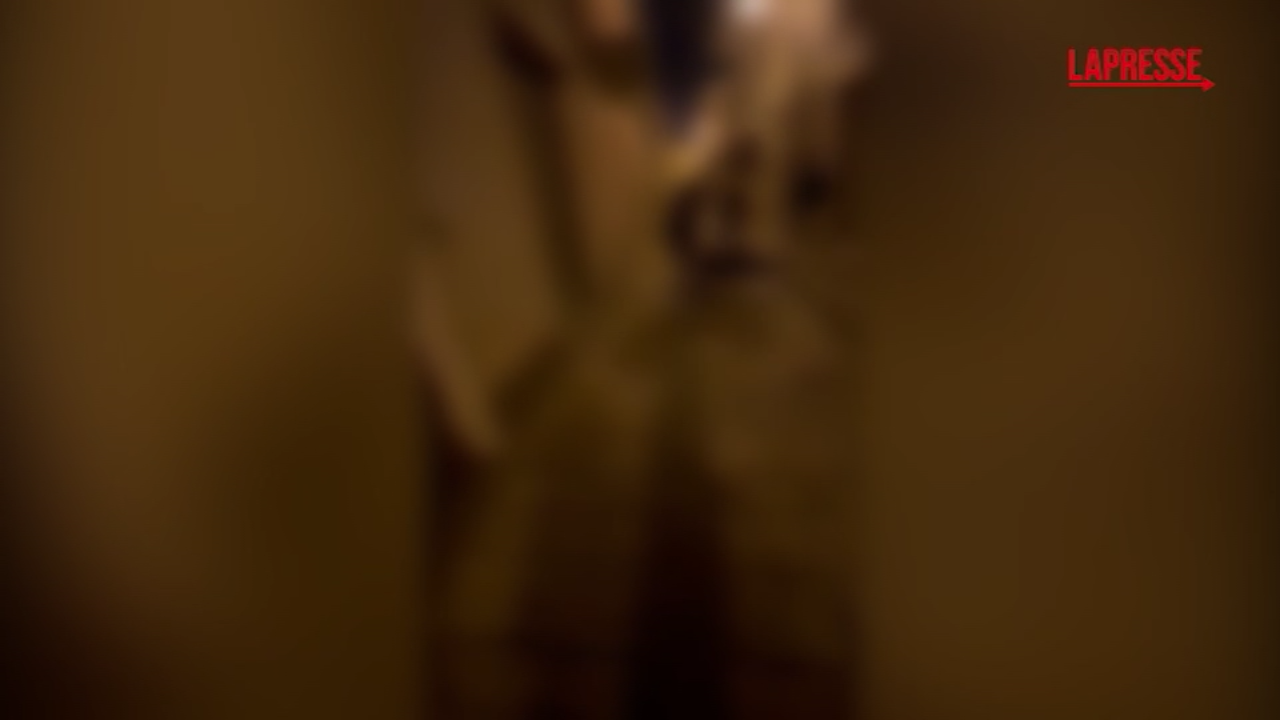































































-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)