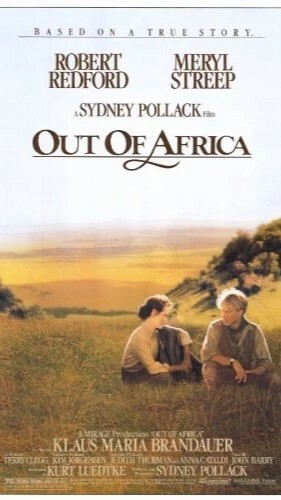Thomas Hobbes e il potere del Leviatano

Nel cuore dell’Inghilterra del XVII secolo, in un’epoca segnata da guerre civili, conflitti religiosi e profonde trasformazioni sociali, emerse una delle figure più affascinanti e controverse della filosofia politica moderna: Thomas Hobbes. Pensatore lucido, rigoroso e talvolta inquietante, Hobbes interpretò la società umana come un campo di forze dominato dalla paura, dal desiderio e dal bisogno di sicurezza. Nel suo capolavoro, il Leviatano (1651), egli propose una visione rivoluzionaria del potere politico, fondandolo non su principi religiosi o morali, ma sulla necessità di ordine e sopravvivenza. La sua analisi della natura umana e della genesi dello Stato resta una delle pietre miliari del pensiero occidentale, e la sua influenza si estende ben oltre la filosofia, toccando la sociologia, l’economia e persino la psicologia contemporanea.
Le origini di un pensatore del disordine

Thomas Hobbes nacque nel 1588, un anno simbolico per l’Inghilterra: quello dell’invasione dell’Armada spagnola. Egli stesso amava dire di essere venuto al mondo insieme alla paura, perché la notizia dell’attacco spinse sua madre a un parto prematuro. Questa aneddotica, oltre a essere curiosa, anticipa quasi profeticamente il tratto dominante del suo pensiero: la paura come fondamento della convivenza umana. Proveniente da una famiglia modesta, figlio di un vicario, Hobbes studiò a Oxford, dove si formò in logica, filosofia naturale e latino, per poi entrare al servizio della famiglia Cavendish, aristocratici illuminati che gli permisero di viaggiare in Europa e di entrare in contatto con il pensiero di Galileo, Descartes e Francis Bacon.
Fu proprio attraverso questi viaggi che Hobbes maturò una prospettiva nuova, scientifica e meccanicistica, applicandola anche allo studio dell’uomo e della società. Ma il suo pensiero nacque soprattutto dall’osservazione del caos politico inglese. La guerra civile tra re e parlamento, la decapitazione di Carlo I nel 1649, l’instaurazione del Commonwealth e la dittatura di Cromwell segnarono per lui un’epoca di disgregazione. In questo contesto, Hobbes non vide solo un conflitto politico, ma il rischio reale di un ritorno allo stato di natura: un mondo senza regole, in cui la vita dell’uomo è “solitaria, povera, cattiva, brutale e breve”.
La visione dell’uomo: homo homini lupus
Al centro della filosofia di Hobbes vi è una concezione fortemente pessimistica della natura umana. Secondo il filosofo, ogni individuo è mosso da passioni e desideri che, in assenza di regole, lo portano a entrare in conflitto con gli altri. La celebre espressione latina “homo homini lupus”, “l’uomo è un lupo per l’uomo”, riassume questa visione: l’essere umano, guidato dall’istinto di sopravvivenza e dal desiderio di potere, tende naturalmente alla competizione e alla sopraffazione.
In questo stato di natura, come lo definisce nel Leviatano, non esistono leggi né giustizia, poiché ciascuno ha diritto a tutto, compresa la vita altrui. Il risultato è un conflitto permanente, una “guerra di tutti contro tutti” (bellum omnium contra omnes). Tuttavia, Hobbes non considera l’uomo un essere malvagio per natura, ma semplicemente un essere razionale e interessato al proprio benessere. Proprio questa razionalità diventa il punto di svolta del suo sistema politico: l’uomo comprende che la pace è preferibile al pericolo costante, e che solo un potere superiore può garantirla.
A differenza di pensatori come Rousseau, che un secolo dopo esalterà lo “stato di natura” come simbolo di purezza perduta, Hobbes vede in esso una condizione primitiva e intollerabile, da superare mediante un patto collettivo. È qui che nasce la sua teoria del contratto sociale, uno dei contributi più duraturi alla filosofia politica moderna.
Il contratto sociale e la nascita del Leviatano
Per uscire dallo stato di natura, gli uomini decidono di stipulare un patto tra loro, rinunciando a parte della loro libertà in cambio di sicurezza. Questo accordo non si fonda sull’amore o sulla moralità, ma su una logica utilitaristica: ciascuno accetta di sottomettersi a un’autorità superiore per evitare la morte violenta e vivere in pace. Il soggetto a cui viene trasferito questo potere assoluto è lo Stato, rappresentato nella celebre metafora del Leviatano, il mostro biblico simbolo di forza e potenza.

Il Leviatano (1651), pubblicato durante la guerra civile inglese, è un’opera monumentale che fonde filosofia, scienza e teologia in un’unica teoria del potere. Hobbes vi descrive lo Stato come un corpo artificiale, composto da tutti gli individui che lo formano, e il sovrano come la sua “anima”. Questo potere deve essere assoluto e indivisibile, poiché solo così può garantire la pace civile. Qualsiasi divisione del potere — tra Chiesa e Stato, o tra Parlamento e monarchia — genera conflitto e porta al disordine.
La figura del sovrano, per Hobbes, non è quella di un despota arbitrario, ma di un garante dell’ordine pubblico. Egli rappresenta la volontà collettiva e agisce per la sicurezza dei cittadini, i quali, avendo ceduto i propri diritti, non possono ribellarsi senza ricadere nell’anarchia. In questo senso, il pensiero hobbesiano anticipa sia l’assolutismo monarchico sia le teorie moderne dello Stato come contratto sociale, sviluppate in seguito da Locke e Rousseau, sebbene con esiti opposti.
La scienza politica come meccanica del potere
Uno degli aspetti più innovativi di Hobbes è il suo tentativo di applicare il metodo scientifico alla politica. Influenzato da Galileo, egli considera la realtà — compreso il comportamento umano — come un sistema meccanico di cause ed effetti. Le passioni, i desideri e le decisioni degli uomini obbediscono a leggi naturali, proprio come i corpi in movimento. Di conseguenza, anche la politica deve essere studiata con la stessa precisione della fisica o della geometria.
In questo senso, Hobbes è uno dei primi a concepire la società come un meccanismo artificiale, costruito per garantire la sopravvivenza collettiva. Lo Stato, come il corpo umano, è composto da organi interdipendenti che lavorano per un fine comune. Ma mentre il corpo naturale è guidato dall’istinto, quello politico è guidato dalla ragione e dal patto.
Il suo approccio razionalista e materialista si contrappone a quello di pensatori religiosi o idealisti. Per Hobbes, infatti, non esistono leggi morali assolute o divine: il bene e il male derivano dal patto sociale e dalle leggi emanate dal sovrano. Ciò che è “giusto” è ciò che contribuisce alla pace e all’ordine. Questa visione riduce la morale alla politica, ponendo lo Stato come fonte unica del diritto.
Religione, libertà e obbedienza
Una delle parti più discusse del Leviatano riguarda il rapporto tra Stato e religione. Hobbes visse in un periodo in cui le guerre di religione dilaniavano l’Europa, e fu convinto che la commistione tra autorità spirituale e potere temporale fosse una delle principali cause di disordine. Per questo sosteneva che anche la Chiesa dovesse essere sottoposta al potere civile. Solo così si poteva evitare che la fede diventasse strumento di divisione.
La sua concezione della libertà è altrettanto pragmatica. Hobbes non intende la libertà come assenza di vincoli, ma come sicurezza all’interno dell’ordine. L’uomo libero è colui che può agire senza impedimenti entro le leggi stabilite dal sovrano. L’obbedienza, in questa prospettiva, non è una forma di schiavitù, ma una condizione necessaria per vivere in pace. La ribellione, invece, porta inevitabilmente al ritorno dello stato di natura.
Molti critici hanno accusato Hobbes di giustificare il dispotismo, ma la sua intenzione non era quella di difendere un regime tirannico. Egli temeva soprattutto l’anarchia e il collasso dell’autorità, e il suo scopo era definire un modello di Stato capace di garantire stabilità. Come scrisse nel Leviatano, “senza una potenza comune che tenga tutti in soggezione, gli uomini si trovano in una condizione di guerra perpetua”.
L’eredità di Hobbes e la sua attualità
Il pensiero di Hobbes ebbe un impatto profondo e duraturo sulla filosofia politica moderna. Pur essendo stato duramente criticato da pensatori liberali e illuministi, egli pose le basi per il realismo politico e per la teoria del contratto sociale. Senza Hobbes, non ci sarebbero stati né Locke né Rousseau, né la riflessione moderna sul rapporto tra individuo e Stato.
La sua influenza si estende anche oltre la filosofia. Nella sociologia di Max Weber e Carl Schmitt, nella psicologia di Sigmund Freud e nelle teorie contemporanee del potere e della sicurezza, il suo pensiero continua a risuonare. In particolare, la sua idea di una società fondata sulla paura e sul bisogno di protezione trova un’eco evidente nelle dinamiche politiche del mondo moderno, dove la sicurezza — fisica, economica o digitale — è spesso invocata come giustificazione per l’espansione del potere statale.
Nell’era della globalizzazione e dei conflitti sociali, Hobbes resta sorprendentemente attuale. Le sue riflessioni sulla natura umana, sulla competizione e sulla necessità di un’autorità centrale aiutano a comprendere le sfide del nostro tempo: dalla polarizzazione politica alla crisi della fiducia nelle istituzioni.
Domande frequenti su Thomas Hobbes
Chi era Thomas Hobbes?
Fu un filosofo inglese nato nel 1588, considerato il padre della filosofia politica moderna.
Qual è la sua opera principale?
Il Leviatano (1651), in cui elabora la teoria del contratto sociale e la giustificazione dello Stato sovrano.
Cosa significa “homo homini lupus”?
Significa “l’uomo è un lupo per l’uomo” e indica la tendenza naturale degli uomini al conflitto in assenza di leggi.
Perché il Leviatano è così importante?
Perché rappresenta la prima sistematizzazione moderna della teoria dello Stato come costruzione artificiale basata sul consenso.
Qual è l’attualità del suo pensiero?
Hobbes è ancora oggi un punto di riferimento per la riflessione sul potere, sulla sicurezza e sul rapporto tra libertà e autorità.
Le immagini utilizzate sono su Common free license o tutelate da copyright. È vietata la ripubblicazione, duplicazione e download senza il consenso dell’autore.
The post Thomas Hobbes e il potere del Leviatano first appeared on Londra Da Vivere : il più grande portale degli italiani a Londra.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0

































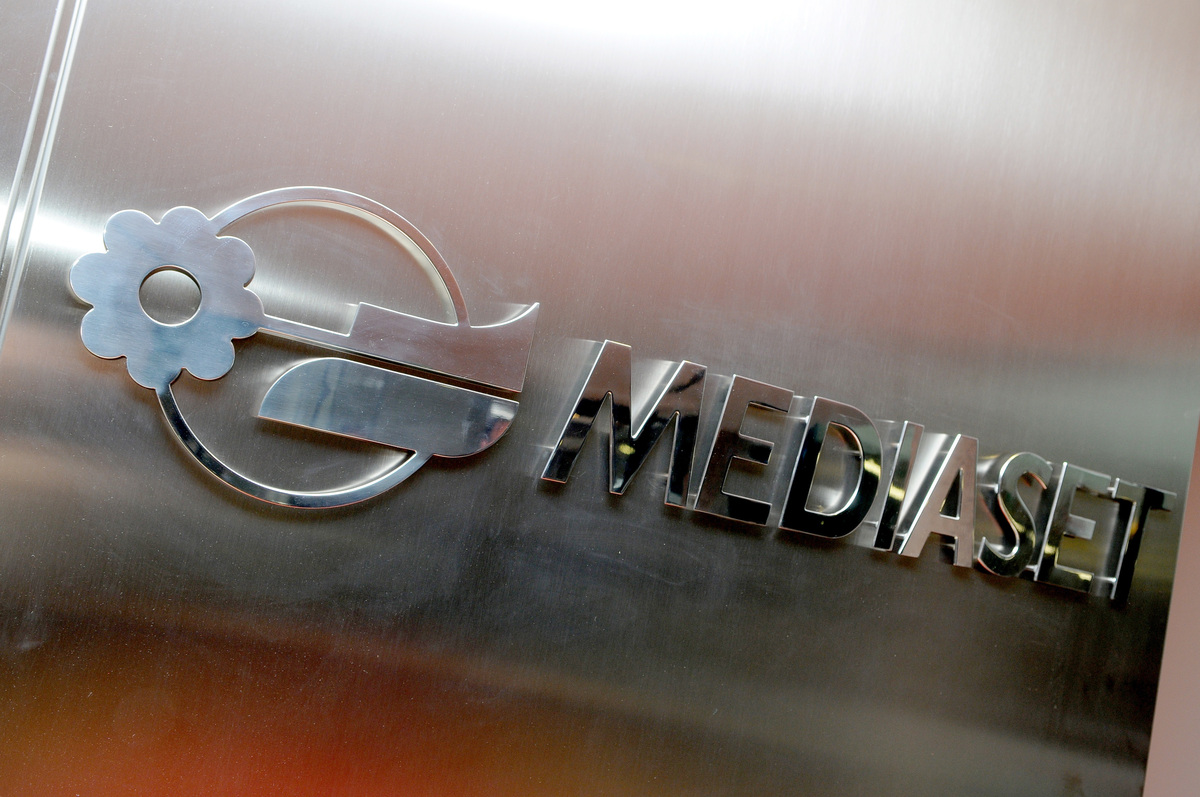























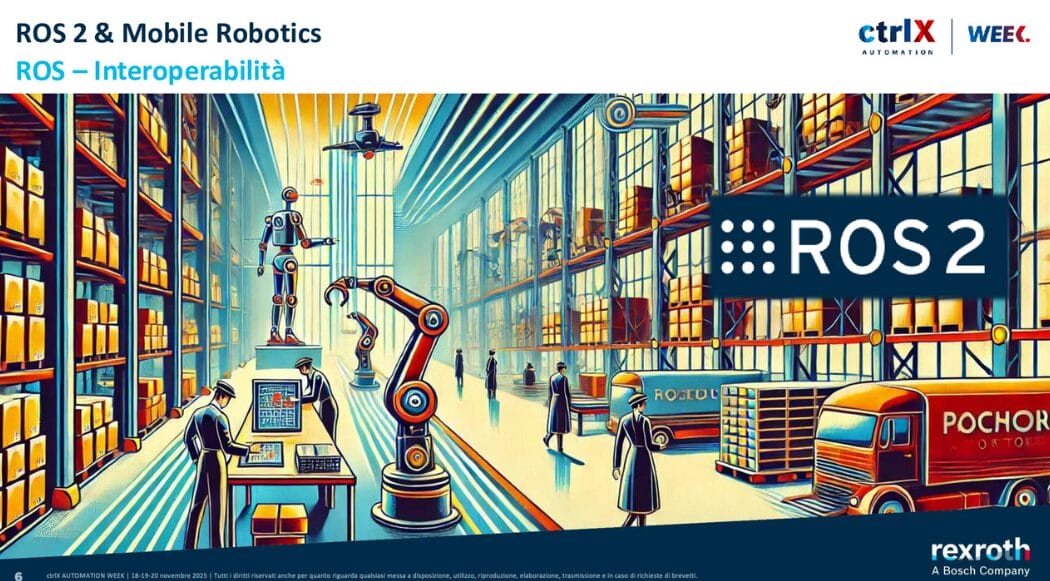















































































































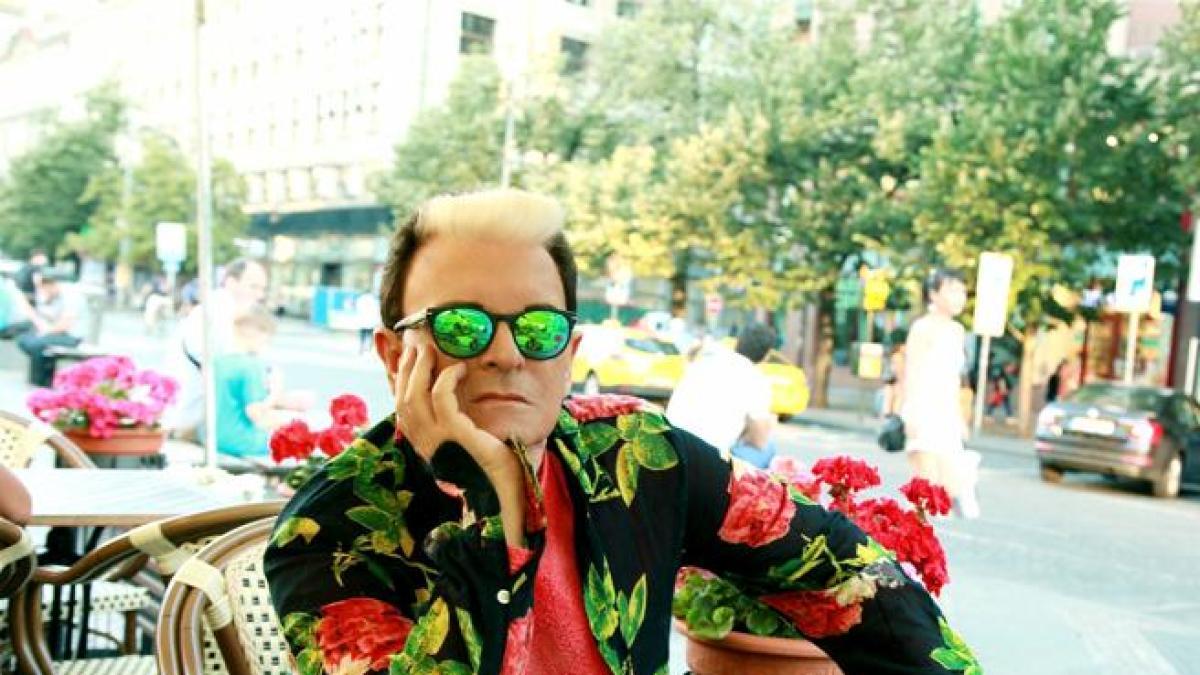

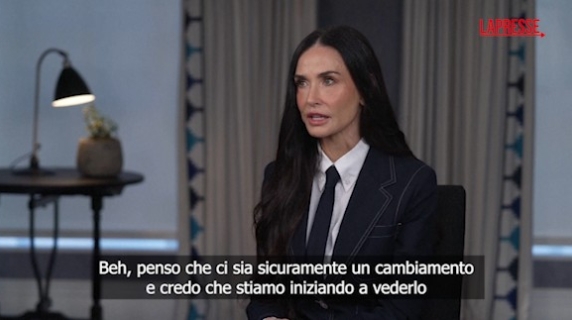
















-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)