Capitolare del Duomo, un’opera e il suo messaggio

 Foto Veneranda Fabbrica
Foto Veneranda Fabbrica«Il restauro è utile non solo per conservare un monumento, ma per rendere viva una chiesa: tutto quello che si fa è per la gloria di Dio e per l’edificazione del popolo cristiano, non per esibire un’abilità. Per questo esprimo il mio apprezzamento alla Veneranda Fabbrica del Duomo e alle maestranze che hanno lavorato. Siamo qui non solo per apprezzare un’opera raffinata, ma per entrare nel messaggio che questa stessa opera vuole raccontare».
Queste le parole con cui l’Arcivescovo ha salutato la prima riapertura della Sacrestia meridionale, detta “Capitolare”, del Duomo. Uno dei “cuori pulsanti” della Cattedrale, un «libro di pietra e di colore che attendeva di essere riletto e che torna nella sua splendida magnificenza». La Capitolare, appunto, che – negli anni successivi alla conclusione dei restauri che hanno riguardato la sacrestia settentrionale o “Aquilonare” – per volere della Veneranda Fabbrica, dal 2021 è interessata da un radicale intervento di restauro. Destinata in modo specifico all’Arcivescovo e al Capitolo Metropolitano (da qui il suo nome), la Sacrestia – i cui lavori termineranno nella parte finale nel 2026 – ha aperto le sue porte offrendo a circa 200 persone l’occasione di salire sui ponteggi per ammirare le scoperte artistiche svelatesi con gli interventi messi in opera.

I “gioielli” della Sacrestia
E non poteva mancare l’Arcivescovo che – accompagnato dall’arciprete monsignor Gianantonio Borgonovo e dal presidente della Fabbrica Fedele Confalonieri -, salendo tra tubi e impalcature, è entrato nella “sua” Sacrestia, passando dal portale di ingresso sovrastato da una delle più straordinarie opere scultoree del Duomo: il manufatto articolato e complesso dal punto di vista artistico e dell’interpretazione teologica, realizzato alla fine del XIV secolo, tra il 1390 e il ’96, da Hans von Fernach e dalla sua bottega e dedicato a episodi della vita della Vergine Maria e alle storie dell’infanzia di Cristo. Un’opera finalmente tornata a splendere grazie al restauro (in questo caso appena concluso), durato due anni e condotto da “Aconerre” (Marilena Anzani e Alfiero Rabbolini), dopo essere stata troppo a lungo coperta dalle patine di ossidazione e calcificazione, causate sul marmo dall’umido e dai fumi del Duomo. Così come le volte della Sacrestia, pesantemente annerite e scurissime, poiché il pittore Gustavo Noyer, che decorò questi ambienti nell’Ottocento, usò tonalità marroni, a imitazione del marmo di Candoglia visibile in quel momento storico, già coperto da strati e strati di polveri e grasso.

Veramente unici i particolari recuperati all’interno della Sacrestia, come il “tetramorfo”, chiave di volta di Giovannino de’ Grassi, che riporta i simboli degli evangelisti e che l’Arcivescovo ha potuto intravvedere da vicino accompagnato dalle spiegazioni di Elisa Mantia, coordinatrice dell’area cultura della Veneranda Fabbrica.
All’interno, contrapposto al portale, magnifico anche il lavabo trecentesco di Giovannino de’ Grassi, una miniatura fatta scultura, in dialogo con le decorazioni ottocentesche delle volte, opera di Giuseppe Knoller. Il restauro delle quali, particolarmente complesso (affidato ad Anna Lucchini in associazione con Francesca Siena), ha posto all’attenzione il tema, spesso trascurato, del restauro dei motivi decorativi, come è stato osservato nel convegno di studi, svoltosi presso la cappella feriale della Cattedrale, che ha preceduto la visita.

Visite guidate e podcast per raccontare i restauri
Insomma, un gioiello che affonda le sue radici nella storia più antica della “casa di tutti i milanesi”, «se già nel mese di marzo del 1393, meno di 7 anni dall’inizio della costruzione del Duomo, una planimetria del progetto che si stava realizzando segnava con grande chiarezza lo spazio ampio e arcuato dell’abside in costruzione. Tale progetto prevedeva due ingressi perfettamente simmetrici e di grande impatto visivo, posti l’uno di fronte all’altro, prima dell’invenzione seicentesca del tornacoro di Federico Borromeo: quelli delle sacrestie, i primi ambienti edificati in Duomo dopo la definizione dell’area dei muri perimetrali e di fondazioni, di cui nel 1386 venne posata la prima pietra».
Intensa la policromia emersa all’interno dell’ambiente in una sorta di horror vacui per cui dorature, modanature, colori e volti – particolarmente intensi i rosa e gli azzurri – si intersecano nelle ricche vesti delle figure, negli incarnati, nella decorazione, arricchendo le pareti e la volta della sacrestia di un racconto visivo che lascia senza fiato.
Tutto ciò che potrà essere visto per tre fine settimana consecutivi, fino al 29 novembre, alle 15.00, con visite guidate esclusive accompagnati dai restauratori che hanno curato i lavori. Per approfondire vari aspetti, la Veneranda Fabbrica, inoltre, in vista del Natale, realizzerà uno speciale podcast in più episodi dedicato alla “Capitolare”, all’interno della rubrica «Il Duomo racconta», dove sarà possibile ascoltare direttamente dalle voci di studiosi e restauratori il racconto, i dettagli e le più recenti e curiose scoperte emerse durante i lavori di ripristino e valorizzazione (il podcast sarà disponibile sulla piattaforma Spotify del Duomo di Milano). Gli interventi, realizzati con la sorveglianza della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano, sono stati possibili anche grazie al contributo di tutti i sostenitori dell’Ente, tra cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lombardia.
Pubblicato anche un volume dal titolo Alle origini della scultura del Duomo di Milano (Silvana Editoriale) pure presentato durante la serata.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0

































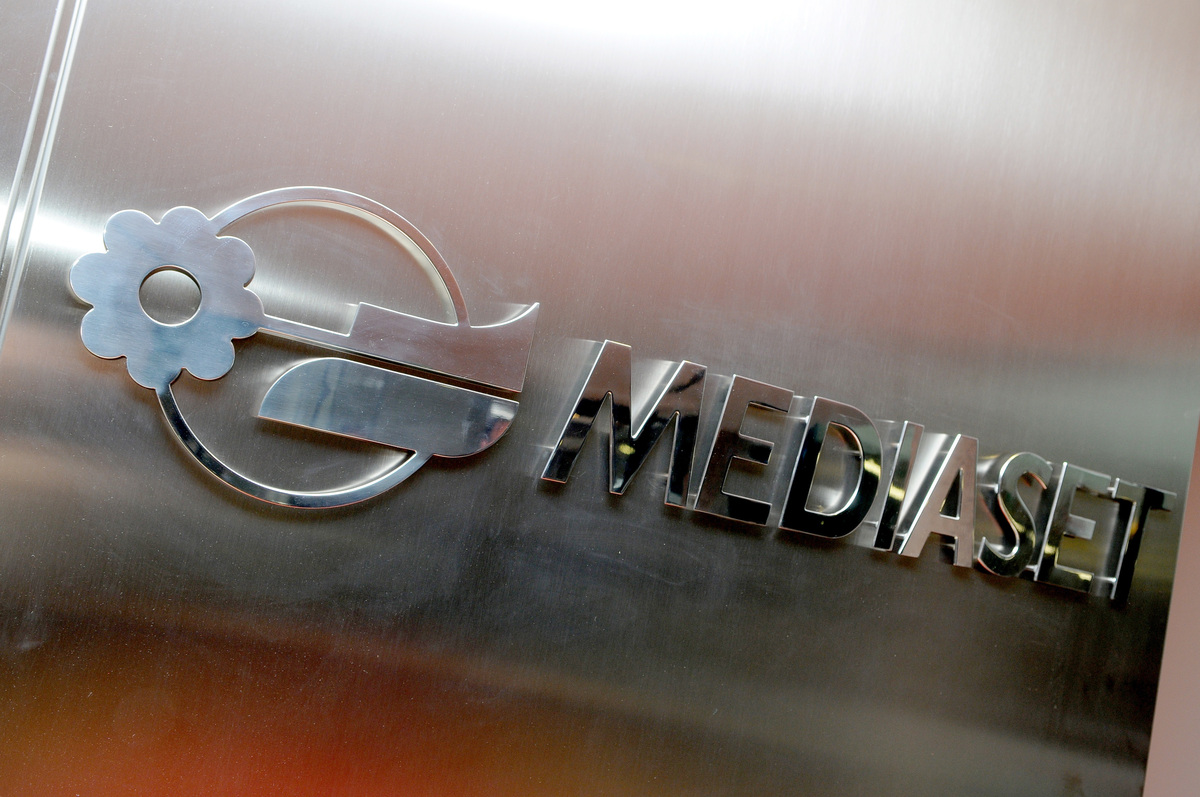























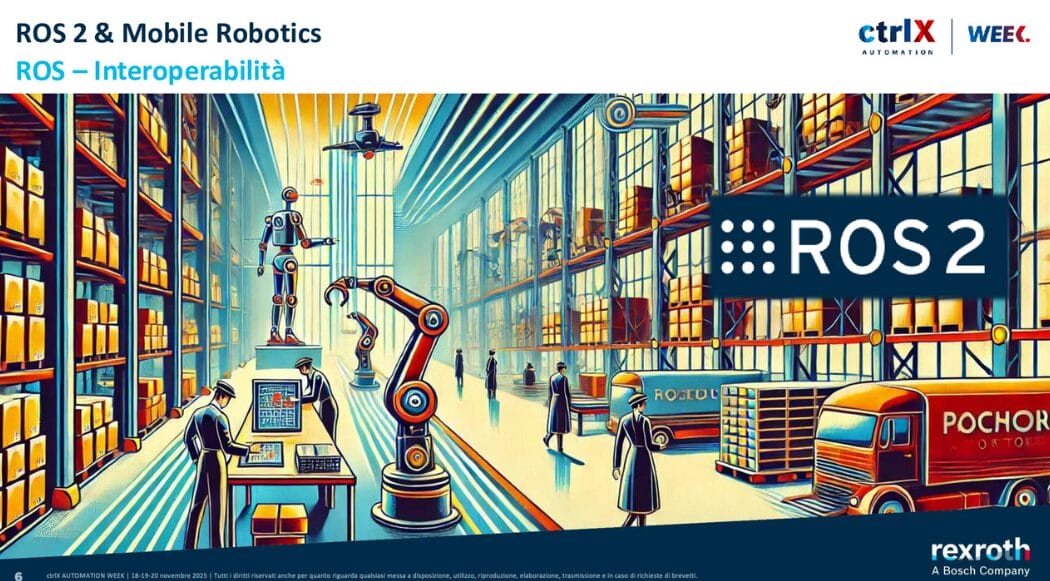















































































































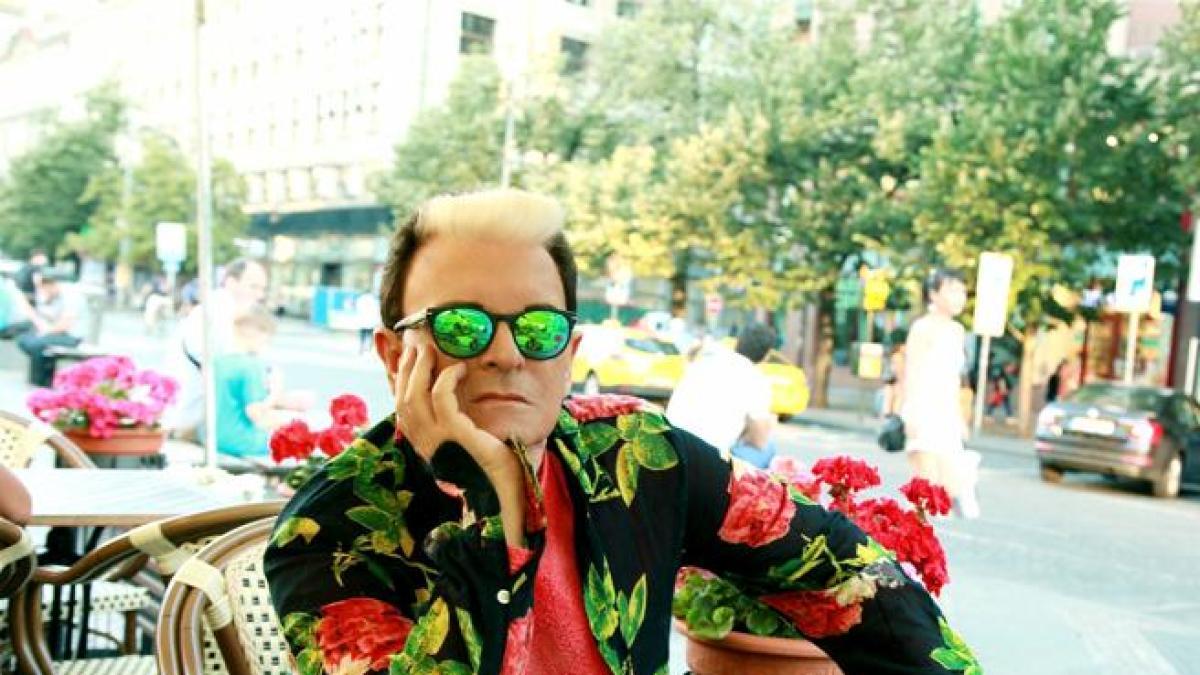

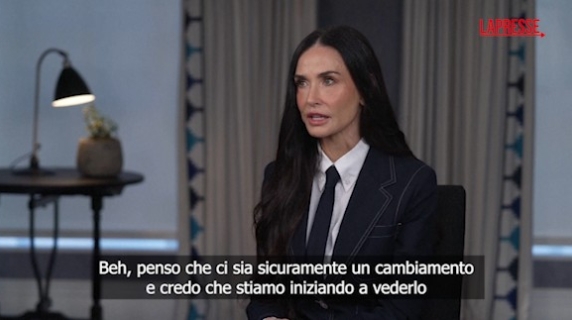
















-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)















































































