Così nei posti di lavoro si sprecano i talenti migliori


In una nota intervista, il cestista statunitense Kobe Bryant chiariva un principio semplice: la differenza di livello, nel tempo, non dipende solo dal talento, ma dalla sua applicazione nel tempo. Bryant raccontava che, mentre la maggior parte dei giocatori si allenava due volte al giorno, lui programmava invece quattro sessioni svegliandosi molto presto al mattino. In una singola giornata lo scarto è minimo, ma in anni di continuità diventa uno scarto irrecuperabile. Non è un fatto emotivo o motivazionale. È matematica applicata al tempo.
L’ecosistema delle organizzazioni, purtroppo, non è assimilabile al mondo dello sport. Consideriamo ad esempio un professionista appassionato del proprio lavoro, magari pendolare. Questo professionista utilizzerà il tempo di spostamento per leggere e studiare. Non utilizzerà i social per scopo ludico, non perderà tempo a scrollare reel su TikTok, o a controllare gli endorsement su Instagram, ma indagherà le comunità professionali on line per trovare contenuti di valore. Si circonderà di persone con la stessa passione con le quali, pur divertendosi, non perderà le nottate al Fantacalcio ma a discutere di organizzazione e strategie. Supponiamo pure che questo stesso professionista pratichi sport di endurance: dato che lavorare è anche elaborare e pensare, la corsa, il nuoto o il cammino saranno spazi di elaborazione cognitiva. Non si tratta di lavorare di più, ma di utilizzare il tempo “non strutturato” come tempo di costruzione. Nel medio periodo, questo genera un vantaggio cumulato: maggiore capacità di analisi, più visione, più padronanza delle relazioni tra fenomeni. Il gap di Kobe rispetto agli altri atleti, appunto.
La differenza è che le organizzazioni non valorizzano automaticamente questo vantaggio. La competenza non è solo capacità tecnica: è potere simbolico. Quindi succede che quando il knowledge holder diventa «too valuable to promote», cioè troppo di valore per essere promosso in un’altra posizione più alta, la competenza non si traduce in riconoscimento ma in un vincolo organizzativo. La persona viene «nascosta» perché, se promossa, potrebbe essere sostituita da qualcuno che non ha altrettanto valore. La sua posizione è quindi necessaria a sostenere l’operatività e, al tempo stesso, la legittimazione del proprio superiore.
Quando accade che la persona diventa riferimento interno, l’equilibrio di legittimazione in effetti cambia. Chi ha interesse a crescere tende ad avvicinarsi. Ma per chi è competitivo, il best performer mette in luce le insufficienze. I livelli apicali possono percepire l’eccesso di riconoscimento diffuso come minaccia rispetto alla gerarchia formale. Il risultato frequente è che la persona competente viene isolata.
Quando il detentore del «vantaggio cumulativo» riconosce questa dinamica, può tentare un adattamento. Il primo passaggio consiste nel trasformare la propria competenza in leva generativa, facendo crescere altri in modo strutturato. Il secondo è consolidare il riconoscimento: partecipazioni istituzionali, tavoli, pubblicazioni, reti, in modo da trovare all’esterno la protezione alle rappresaglie interne. Il terzo consiste nello spostarsi dalla risoluzione diretta dei problemi alla definizione delle cornici che permettono agli altri di risolverli, diventando architetto della grammatica organizzativa, anziché semplice esecutore esperto. Sono strategie di redistribuzione del valore per ridurre l’attrito interno.
Dal punto di vista della proprietà, però, la questione è diversa rispetto alla percezione dei manager intermedi. Il consiglio d’amministrazione non ha interesse a proteggere l’equilibrio organizzativo, ma a massimizzare la capacità competitiva complessiva. Chi ha ormai scavato un gap di competenza non colmabile, ovvero il detentore del gap, quando non valorizzato, rappresenta una perdita secca: capitale cognitivo non convertito in capacità organizzativa, rischio elevato di turnover qualificato, rafforzamento dei meccanismi di autoconservazione dei ruoli. In questi casi, il problema non è la persona, ma la governance.
La distinzione tra settore privato e settore pubblico rende ancora più chiaro l’effetto degli incentivi. Nel privato, le metriche sono più visibili e lo spreco di talento è più difficilmente giustificabile. Nel pubblico, dove la stabilità degli equilibri interni pesa più della performance, la competenza eccedente può essere percepita ancora di più come fattore di squilibrio. Ne deriva una selezione avversa: chi può andarsene, se ne va. Si sente più utile altrove. Chi ha interesse a proteggere il proprio ruolo, rimane. Nel tempo, la produttività cala, la capacità di innovazione si riduce e la qualità decisionale si appiattisce. Guarda caso è quanto sta accadendo proprio nella pubblica amministrazione italiana.
Il paradosso è chiaro e non riguarda le persone, ma le strutture: quando un’organizzazione non è in grado di dare forma istituzionale al «vantaggio cumulativo», quel vantaggio invece di diffondersi, si disperde. Se il detentore del gap è isolato, non produce valore: produce uscita. Non si perde solo un lavoratore, ma un potenziale moltiplicatore di valore. La conclusione, per chi governa, è lineare: o il sistema riconosce e usa il gap, oppure il gap si trasferisce altrove. E ciò che se ne va non è un talento, ma una possibilità di futuro.
L'articolo Così nei posti di lavoro si sprecano i talenti migliori proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0
































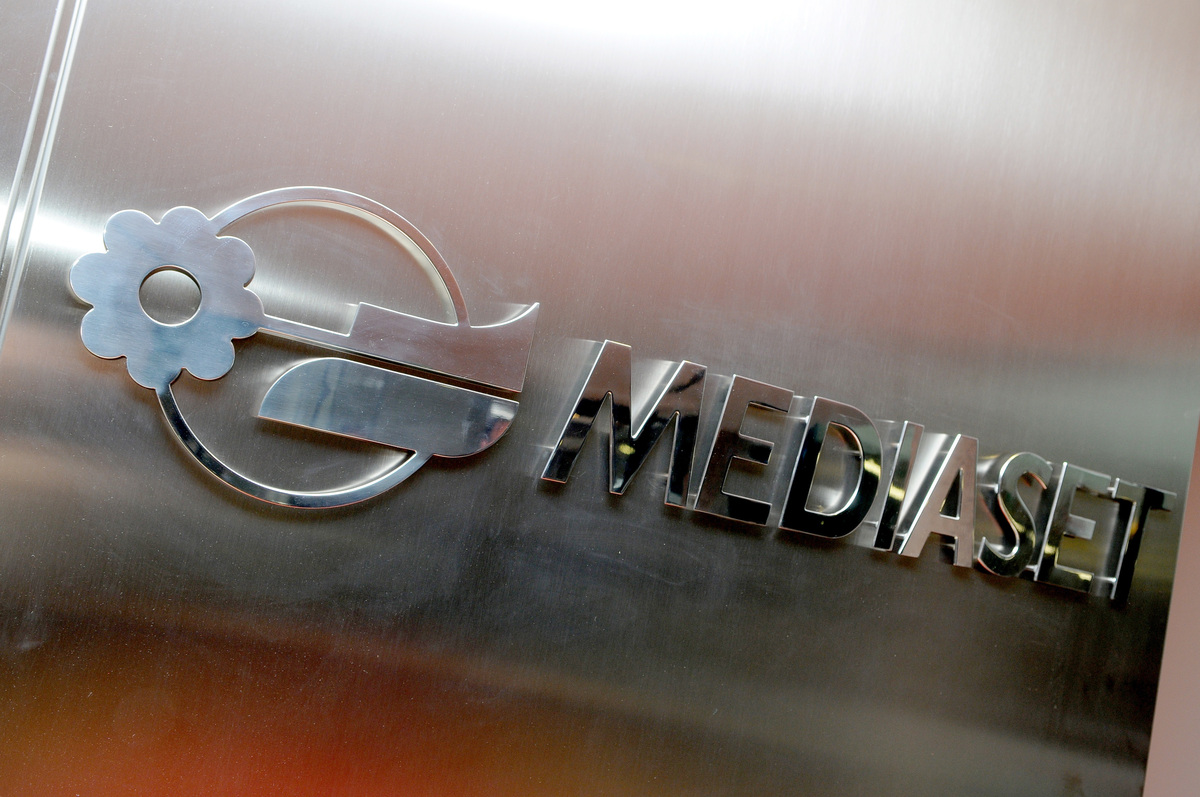


















































/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/11/trade-republic-conto-canone-zero-offre-2-percento-liquidita.jpg)




















































































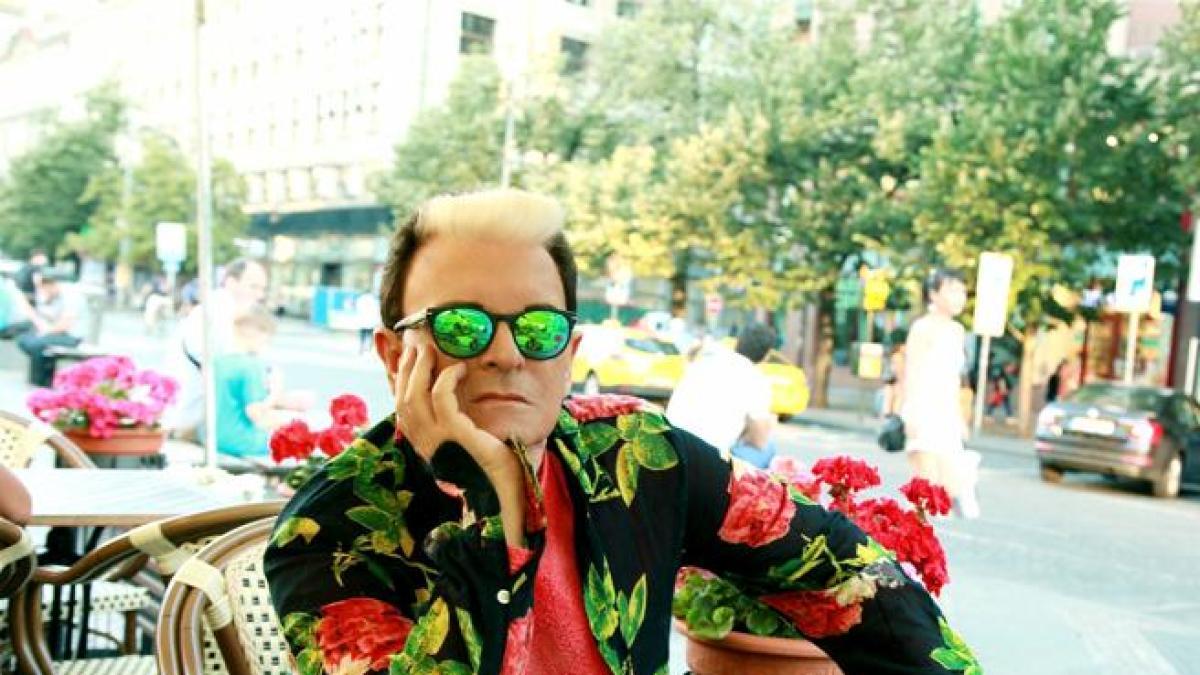

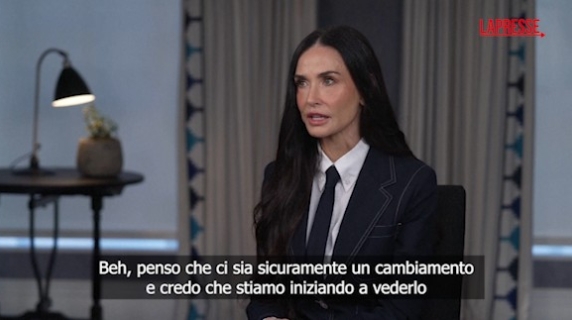
























-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)
























































