I dati positivi sull’abbandono scolastico non risolvono le disuguaglianze


Nel 2024 per la prima volta in Italia il tasso di abbandono scolastico è sceso sotto il dieci per cento. È un dato significativo perché è un passo di avvicinamento all’obiettivo fissato dall’Unione Europea per il 2030: ridurre al di sotto del nove per cento la quota degli Early Leavers from Education and Training, cioè i giovani tra i diciotto e i ventiquattro anni che hanno completato al massimo la scuola secondaria di primo grado senza proseguire gli studi.
Lo scorso anno la media europea si attestava al 9,3 per cento: l’abbandono riguardava il 10,9 per cento degli uomini contro il 7,7 per cento delle donne. Tra i Paesi dell’Unione, la Croazia registrava il tasso più basso (due per cento), mentre la Romania quello più alto (16,8 per cento). L’Italia, che nel 2020 aveva mancato l’obiettivo europeo del dieci per cento, oggi mostra un trend in miglioramento: secondo le proiezioni dell’ultimo rapporto INVALSI, la dispersione scolastica attesa per i giovani tra i diciotto e i vent’anni si aggira intorno all’8,3 per cento.
Negli ultimi anni, il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è impegnato nella lotta alla dispersione scolastica, per esempio inserendo strumenti premianti e fondi aggiuntivi per le scuole che registrano un miglioramento nei tassi di frequenza e di conseguente riduzione dell’abbandono scolastico. Per monitorare questi parametri esistono inoltre meccanismi di valutazione – come per esempio il Rapporto di Autovalutazione – e di rendicontazione sociale che possono contribuire a costruire una reputazione positiva della scuola, che se ottiene risultati positivi godrà di possibili benefici indiretti in termini di fondi, progettualità o iscrizioni.
«Bisogna però sottolineare che non esiste un sistema automatico e trasparente di “premialità diretta” e misurabile esclusivamente legato alla riduzione dell’abbandono – afferma Orazio Giancola, Professore Associato di Sociologia dei Sistemi educativi e di Metodologia e tecnica della ricerca sociale applicata presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche di Sapienza. Le premialità non sono quindi sempre economiche, né garantite, e sono spesso collegate a bandi competitivi o a progettualità, come quelle legate al Pnrr o ai Fondi Strutturali Europei». Giancola spiega che riconoscere il raggiungimento di tali obiettivi non è sempre formalizzato a livello ministeriale, e può avvenire più facilmente a livello regionale o tramite reti di scuole e dirigenti.
Accanto a questi strumenti istituzionali per arginare il fenomeno dell’abbandono scolastico, si moltiplicano anche i progetti locali, portati avanti da associazioni o enti del terzo settore. Ne è un esempio “Futuro Prossimo” di Save the Children (attivo dal 2017 al 2022 a Napoli, Sassari e Venezia) e “Op-Ed. Orientamento e Partecipazione per l’Educazione” di ActionAid, che coinvolge ragazze e ragazzi tra gli undici e i diciassette anni a Palermo, Siracusa e Reggio Calabria.
Giancola sottolinea come anche la normativa scolastica più stringente abbia inciso positivamente sulla dispersione scolastica: «L’introduzione del biennio obbligatorio dopo la terza media ha garantito una continuità che prima mancava, riducendo l’emorragia di studenti e favorendo inclusione sociale, occupabilità e coesione del Paese».
La fondazione indipendente Openpolis, che ha elaborato i dati, sottolinea tuttavia delle “contraddizioni di fondo”. L’indice ufficiale dell’abbandono scolastico sarebbe in grado di fotografare solo la dispersione esplicita, cioè il tasso di persone che lasciano la scuola dopo la terza media. Non riuscirebbe invece a documentare quella implicita, composta da studenti e studentesse che, pur adempiendo l’obbligo scolastico, non raggiungono competenze adeguate, come dimostrano anche i risultati dell’ultimo rapporto INVALSI.
«È come osservare le stelle – commenta Giancola –: i dati sull’abbandono arrivano a posteriori dall’indagine trimestrale Istat, mentre quelli sulla dispersione implicita, raccolti da Invalsi, sono in tempo reale». Il professore parla di una sorta di “inclusione al ribasso”: per trattenere gli studenti, spesso si accettano livelli di performance insufficienti.
Gli studenti con basse competenze restano infatti i più esposti al rischio di abbandono. «Se da una parte miglioriamo, dall’altra il quadro è preoccupante: rischiamo di alimentare la povertà educativa. Una persona può adempiere l’obbligo scolastico senza però saper leggere un testo», spiega Giancola.
Giancola sottolinea come chi ha ottenuto risultati bassi tenda ad abbandonare la scuola più spesso degli altri. Se da una parte i dati migliorano, dall’altra il discorso è preoccupante, perché si rischia di cadere nella trappola della povertà educativa. «Una persona può adempiere l’obbligo scolastico senza essere in grado di leggere un testo. Le basse competenze sono infatti il primo fattore di riproduzione di disuguaglianze, e la povertà educativa diventa così una trappola di povertà», con giovani bloccati nel mercato del lavoro, che spesso finiscono per svolgere lavori precari e usuranti. «Le persone educativamente povere che non leggono, non si informano, non partecipano alla vita civica saranno a loro volta genitori non attrezzati da un punto di vista culturale – commenta Giancola –. Questo crea una catena di trasmissione intergenerazionale della povertà educativa, che si trasmette come la povertà materiale».
L'articolo I dati positivi sull’abbandono scolastico non risolvono le disuguaglianze proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0
































![Cupra Formentor VZ5: il ritorno del cinque cilindri che emoziona (e che forse non rivedremo più) [VIDEO]](https://img.stcrm.it/images/48012354/1200x/formentor-vz5_10.jpg)





.jpeg)














































/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/11/600-euro-buoni-amazon-aprendo-conto-credit-agricole.jpg)

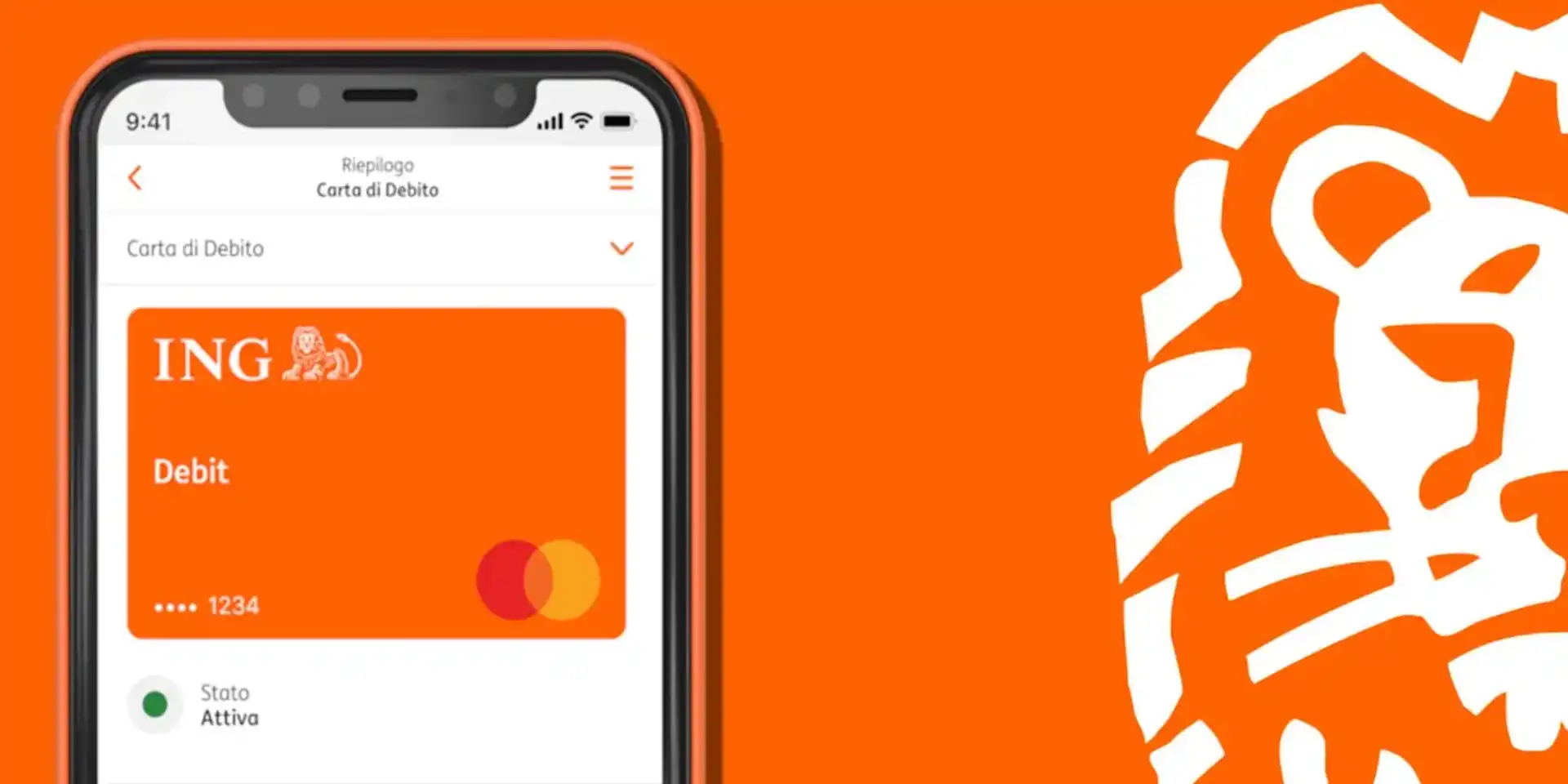










































































































-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)
























































