I primi quarant’anni di Dungeons & Dragons


Nel 1985, l’Editrice Giochi portava sugli scaffali di una manciata di negozi specializzati la scatola rossa con l’iconica illustrazione di Larry Elmore del primo e più famoso gioco di ruolo: Dungeons & Dragons. Circa dieci anni prima, nel 1974, i due autori, Gary Gygax e Dave Arneson, avevano gettato le basi di un fenomeno destinato a rivoluzionare il panorama ludico e l’immaginario collettivo. Questo gioco ha ibridato narrazione, improvvisazione e strategia in un’esperienza immersiva che ha attratto generazioni di giocatori, lasciando un impatto sociologico ancora da esplorare. D&D continua a esercitare un’influenza culturale straordinaria, celebrata da riviste come Time, che gli ha recentemente dedicato un numero speciale intitolato «Il gioco che ha cambiato il mondo».
Dungeons & Dragons è emerso originariamente come un progetto semi-amatoriale, inizialmente basato su tre manuali che rappresentavano una prima sistematizzazione di regole e meccaniche, per evocare narrazioni ispirate ad autori come Robert E. Howard, Fritz Leiber e Jack Vance (come raccontato nella famosa Appendice N). Questi mondi fantastici, popolati da eroi e creature mitiche, offrono ai giocatori la libertà di esplorare identità e avventure tramite l’interpretazione di ruoli.
Sotto la guida di un Dungeon Master (DM), possono affrontare sfide, esplorare dungeon e raccogliere tesori, mettendo alla prova la propria creatività in storie condivise. Come si legge nella presentazione: «D&D è un fantastico, eccitante e immaginifico gioco di interpretazione di un ruolo. Ogni giocatore crea uno o più personaggi, che possono essere nani, elfi, halfling o combattenti, incantatori, chierici e astuti ladri. I personaggi si tufferanno poi in un’avventura in una serie di segrete, tunnel, caverne, condotta da un altro giocatore: l’arbitro, anche chiamato Dungeon Master. I dungeon sono pieni di mostri paurosi, tesori favolosi e terribili pericoli. Se i giocatori partecipano a più partite, i loro personaggi crescono in potere e abilità, gli incantatori imparano altre formule magiche, i ladri crescono in astuzia e abilità, guerrieri, nani, elfi e halfling combattono con accuratezza sempre più letale e diventano più difficili da uccidere. Presto gli avventurieri osano andare ogni partita sempre più in profondità nei dungeon, affrontando mostri sempre più terribili e, naturalmente, raccogliendo tesori più grandi e favolosi! Il gioco è limitato solo dall’inventiva e dall’immaginazione».
Una delle descrizioni più evocative del valore dell’esperienza ludica viene dalle parole del sociologo Roger Caillois nel suo saggio Les Jeux et les Hommes, dove identifica quattro dimensioni del gioco: Agon (Competizione): stimola innovazione tra i giocatori non solo contro gli avversari, ma anche contro se stessi per migliorare abilità e strategie. La competizione è sublimata in una logica collaborativa. Alea (Caso): introduce elementi di rischio e sorpresa, creando tensione attraverso il lancio dei dadi per risolvere le diverse azioni. Mimicry (Travestimento): i giocatori incarnano personaggi, addestrando la propria intelligenza emotiva e le proprie abilità comunicative e relazionali. Infine, Ilinx (Vertigine): affronta situazioni complesse e inaspettate, consentendo l’esplorazione del rischio in un contesto sicuro.
Il termine Dungeon non ha una traduzione immediata in italiano: si avvicina alla parola medievale dongione, che definisce una torre destinata a ospitare la residenza del signore feudale. Nel gioco, invece, è un gruppo di stanze e corridoi in cui possono essere trovati mostri e tesori, ovvero una struttura di ambienti, ma anche di situazioni collegate insieme, con un ingresso e un punto di arrivo in cui organizzare l’esplorazione di un gruppo di avventurieri-incursori alla ricerca di nemici e ricchezze. È sinonimo di avventure, simbolo di esplorazione e ricerca e, allo stesso tempo, rimanda alla matrice dell’inconscio junghiano popolato da archetipi.
Accanto al dungeon, Gary Gygax e Dave Arneson scelsero, come simbolo del gioco, il mostro dei mostri, il drago, immagine universale. D&D ha beneficiato inoltre del contributo di illustratori come il già citato Larry Elmore e Jeff Easley, che hanno reso plasticamente visibili i mondi evocati. Ma ciò di cui stiamo discutendo non è più solo un gioco, ma un fenomeno culturale che ha influenzato profondamente la nostra società. La sua esplosiva diffusione nei campus universitari ha creato comunità interattive dove i giochi di ruolo sono diventati strumenti di socializzazione e scambio di idee.
Come sottolinea il giornalista James Poniewozik, la narratività non lineare di D&D ha finito per riflettere la struttura originaria del web. Questo tipo di cultura underground – interattiva, personale e mimetica – ispirata alla creazione di nuovi mondi, divenne il mood dominante della controcultura, ma soprattutto dei primi creatori della tecnologia informatica. Sulle primitive reti, insieme ai documenti e alle mailing list dedicate a Star Trek (e più tardi anche a Guerre Stellari), gli scambi riguardanti D&D divennero esponenziali.
Negli ultimi anni, il fantasy ha raggiunto una dimensione mainstream, consolidata da opere come «Il trono di spade» di George R.R. Martin. Questa immensa attenzione e il rinnovato entusiasmo per il fantastico si riflettono anche nel mondo dei giochi di ruolo. Serie come Stranger Things ne hanno celebrato il potere, rendendo evidente la loro rilevanza nella cultura contemporanea.
Uno degli aspetti più innovativi di D&D è la sua natura di improvvisazione, dove i giocatori partecipano attivamente alla scrittura della storia. Questo consente di immergersi in storie complesse, trasformando ogni partita in un’opera d’arte collettiva.
Johan Huizinga, nel suo saggio Homo Ludens, descrive l’attività ludica come un bisogno primario dell’uomo. D&D, con la sua struttura flessibile, consente l’esplorazione di questioni più ampie, come dilemmi etici, offrendo spazi per riflessioni sulle proprie aspirazioni e paure.
Un’ulteriore svolta avvenne sempre in quel periodo che combacia con la fine degli anni Settanta e soprattutto gli Ottanta, con la nascita dei primi videogiochi commerciali, che assunsero caratterizzazione sempre più netta grazie all’esempio dei creatori di D&D: il loro set di regole e il loro universo fantastico plasmarono la base e lo standard sui quali costruire tutte le varianti che hanno riempito l’immaginario degli appassionati.
Infatti «i creatori del gioco di ruolo volevano che le persone condividessero esperienze, amando le storie che contribuivano a creare, senza che la piattaforma diventasse un ostacolo», ha spiegato l’esperto statunitense Nathan Stewart. Infatti, nelle intenzioni iniziali, Gygax e Arneson non volevano creare un gioco nuovo, ma una serie di regole che espandesse la loro esperienza ludica in un’avventura senza fine, basata sul racconto (oggi diremmo sullo storytelling).
Un’ulteriore evoluzione ci sarà nel 1981, quando le generiche ambientazioni ispirate all’immaginario fantasy dell’epoca e di tutto il mondo delle riviste pulp come Weird Tales lasciano il posto a universi più strutturati. Infatti, proprio quell’anno, la Chaosium – fondata da Greg Stafford e ancora operativa – affiderà a Sandy Petersen la scrittura de «Il richiamo di Cthulhu», che permette ai giocatori di confrontarsi con gli orrori del Ciclo di Arkham (o di Yog-Sothoth), che rappresentano il risultato più personale e famoso di H.P. Lovecraft: si tratta di storie ambientate nei paesaggi a lui familiari del New England che finiscono per espandersi – attraverso traiettorie aliene – fino a inglobare l’intero pianeta, contemplando il destino dell’universo.
Mentre l’umanità procede ignara, un’antica minaccia torna a tessere le proprie trame: creature crudeli e blasfeme si nascondono nelle viscere della terra, nelle profondità degli oceani e all’ombra dei grattacieli. I giocatori, interpretando coraggiosi investigatori dell’incubo, sono impegnati a svelare questi arcani misteri.
Per capire la portata del fenomeno, Michel Houellebecq, nel suo saggio del 1991 dedicato al Solitario di Providence Contro il mondo, contro la vita, racconta: «Durante gli incontri con i lettori vengo spesso avvicinato da ragazzi che mi chiedono di firmargli una copia di questo saggio. Sono ragazzi che hanno scoperto HPL soprattutto tramite i giochi di ruolo».
Come ha raccontato recentemente proprio Petersen: «Nel 1980, ho scritto il gioco di ruolo “Il richiamo di Cthulhu”. A quel tempo, tutti quelli che conoscevo e che avevano sentito parlare di Lovecraft lo conoscevano perché gliene avevo parlato personalmente. Lovecraft era straordinariamente sconosciuto. Mi aspettavo che “Il richiamo” vendesse un paio di migliaia di copie ai pochi appassionati nel mondo e poi svanisse nel nulla. Tuttavia, ci ho messo il cuore perché amavo davvero HPL. Invece, il gioco si è rivelato un mezzo per promuoverlo e diffondere la conoscenza delle sue opere. Tantissime persone lo hanno giocato. Molti di più non lo hanno giocato, ma sapevano di cosa si tratta. Ho incontrato letteralmente migliaia di persone alle convention che mi hanno detto di aver letto Lovecraft dopo aver giocato a “Il richiamo di Cthulhu”».
Sempre nel 1981 e sempre la Chaosium darà alle stampe «Stormbringer», un regolamento che permette di giocare nel super-ciclo inventato dallo scrittore inglese Michael Moorcock: The Tale of the Eternal Champion, che reinterpreta il tema dell’eterna contrapposizione tra Bene e Male all’interno di una concezione relativistica, nella quale queste stesse forze non combattono per prevalere, ma soltanto per assicurare il mantenimento dell’equilibrio, perché il caos stesso costituisce un elemento ineliminabile, imprescindibile per la stessa esistenza del multiverso.
Da questo momento in poi, forti di questi potenti ancoraggi letterari e narrativi, i giochi di ruolo sono stati in grado di esprimere tutto il proprio potenziale, permettendo alle persone di condividere esperienze, espandendo la propria consapevolezza ludica in un’avventura senza fine.
L'articolo I primi quarant’anni di Dungeons & Dragons proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0
































![Cupra Formentor VZ5: il ritorno del cinque cilindri che emoziona (e che forse non rivedremo più) [VIDEO]](https://img.stcrm.it/images/48012354/1200x/formentor-vz5_10.jpg)





.jpeg)














































/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/11/600-euro-buoni-amazon-aprendo-conto-credit-agricole.jpg)

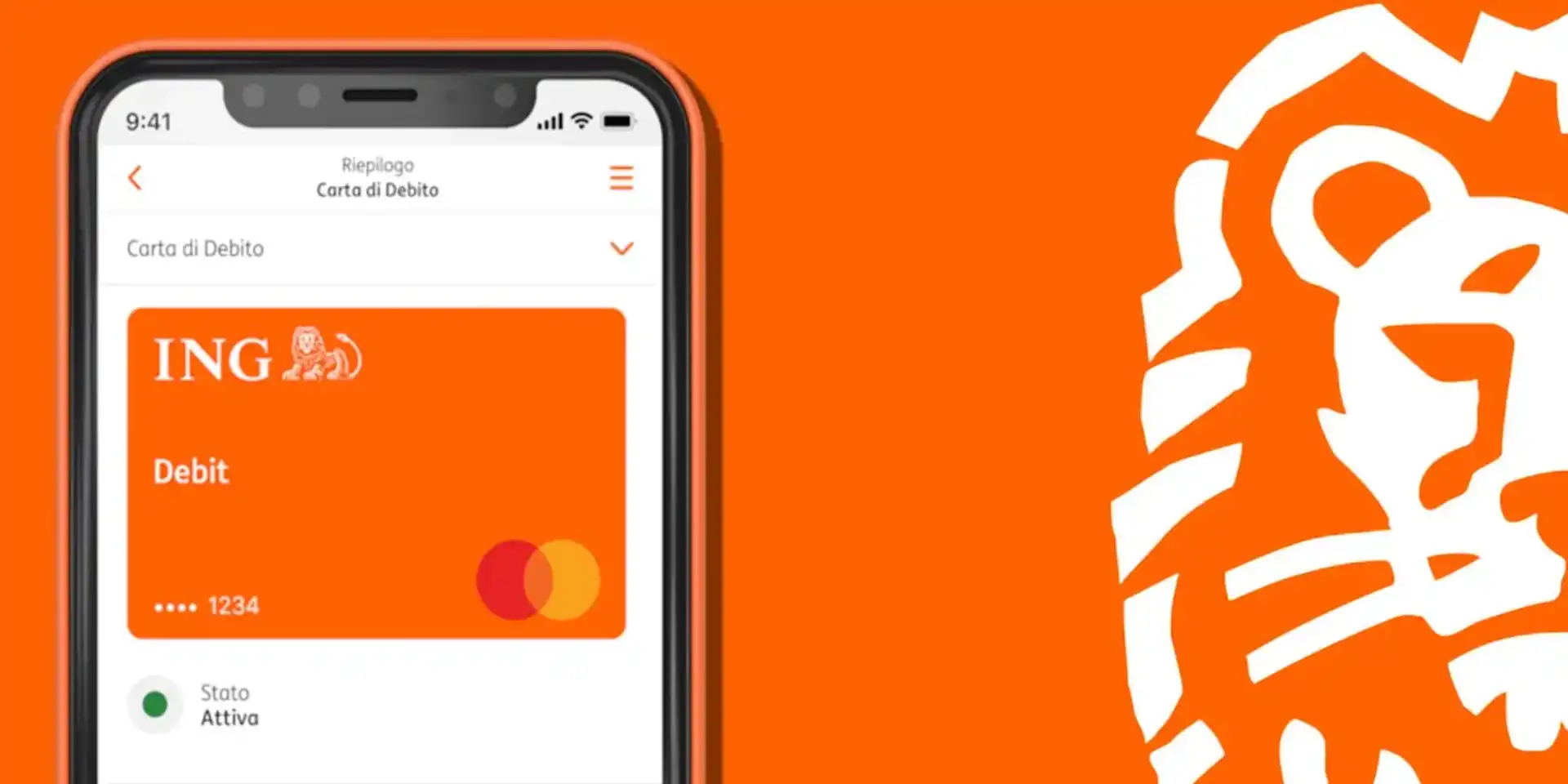










































































































-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)























































