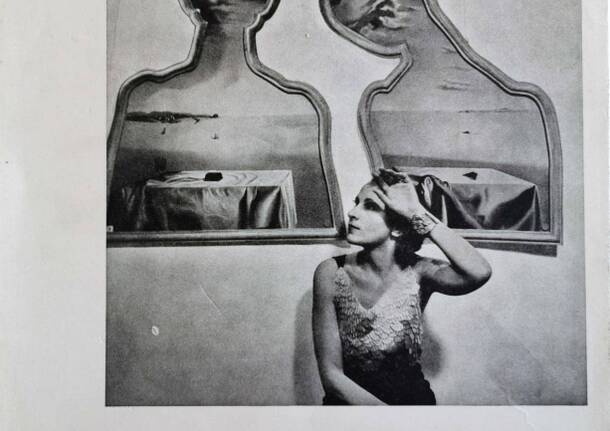Il vino del futuro ha bisogno di consapevolezza


Qual è il fil rouge che unisce le anfore di vinificazione e la kombucha, il vino dealcolato e l’auto elettrica, il tappo a vite e le fermentazioni spontanee, la biodinamica e il consumo di prodotti locali, l’impianto di un vigneto in montagna e la riduzione dei consumi di alcol negli Stati Uniti? Si potrebbe trovarlo nella parola “consapevolezza” che oggi chiama in causa ogni persona che scelga di dedicare al proprio non-ruolo di consumatore la stessa attenzione che viene dedicata alla ricerca spasmodica delle differenze (di genere, di razza, di patria, di censo) nella nostra società.
Consapevolezza significa riflessione e attenzione, significa non fare la scelta più semplice (e, per favore, nemmeno la più stilosa) e porsi l’interrogativo rispetto alle opzioni di vita e di consumo. Certo, la teoria dei giochi di Nash suggerisce che ogni nostro comportamento è indotto da una serie di fattori esterni (più o meno manipolati), però nei limiti dell’umano abbiamo un “libero arbitrio” tra calici e banconi, tra tavola e bar.
Il nodo diventa cruciale, perché se oggi il mondo del vino e il mondo degli spirits stanno attraversando una fase critica – con la disaffezione statisticamente percepita delle nuove generazioni – sembra arrivato il momento di un cambio di passo per l’intero comparto degli alcolici. Possiamo obiettare che il mutamento di scenario è indotto da processi guidati da grandi interessi globali – la crociata contro l’alcol sembra decisamente più agguerrita e ben armata di quella contro lo zucchero o i pesticidi – oppure possiamo prendere atto di una evoluzione dello scenario che richiede un nuovo approccio.
Un ritiro eno-rigenerante
È con questa ricerca di consapevolezza che AMProject ha ideato una giornata di confronto e approfondimento sotto il titolo di “Rigenerazioni”. Padrone di casa, a Castelvecchio di Caldaro, l’enologo e divulgatore Andrea Moser, che dal vigneto fino alle colonne di Gastronomika cerca di stimolare riflessioni e che talvolta lancia provocazioni. Come quella di un “ritiro per parlare di vino e di futuro”.
Qualcosa di simile ai ritiri spirituali che fanno i monaci e i credenti per fermarsi, alzare lo sguardo e guardare oltre l’immediato del quotidiano, ma dedicato al vino e alla vigna. «Le adesioni sono state tante, molto più di quanto avremmo mai potuto immaginare – dice Moser – e sono arrivate dagli orizzonti più diversi: produttori navigati, giovani imprenditori del vino, giornalisti, nuove generazioni nate e cresciute tra le vigne e ora in cerca della propria strada. A ciascuno era stato chiesto di portare una bottiglia. Non una qualsiasi, ma quella che, a loro parere, meglio rappresentasse il concetto di vino del domani: per i metodi di produzione, per la storia, per il gusto, le prospettive o magari la nicchia da cui proveniva».
L’idea era semplice: pranzare insieme intorno ai piatti di carne preparati da Damiano Fusina, serial griller per passione, degustare, aprire qualche discussione enologica e filosofica… e poi degustare ancora. «Tutti hanno accolto l’idea di sedersi intorno a un tavolo e ascoltarsi l’un l’altro mentre raccontavano il proprio pensiero sul vino – aggiunge Moser – sul suo fascino, sulla storia che li ha portati ad apprezzarne gusto, cultura e universo e appassionarsi tanto. Poi abbiamo iniziato a stappare le bottiglie, prima i bianchi, poi rossi e insieme, sempre, Kombwine, l’alternativa che abbiamo immaginato insieme a Legendary Drink (qui un articolo di approfondimento), che parte dal mosto e che impiega le tecniche della kombucha per imbottigliare una bevanda in grado di portare l’aroma del vino a un nuovo livello, senza alcool».
Durante la giornata si è parlato di vini fatti con processi sostenibili dalla vigna alla bottiglia, di etichette realizzate in comunità, di cantine che puntano tutto sulla trasparenza e sulla filiera e altre che hanno deciso di dare una seconda possibilità a un vitigno che stava per scomparire. «Per alcuni, il futuro è condividere una bottiglia riempita nel 1947. Per altri, è mettere sul tavolo una bottiglia ancora senza nome», scherza Moser.
Vino culturale e stili di vita
La riflessione sul vino finisce però per espandersi – se non al senso, certo agli stili di vita. Per esempio, sul rapporto tra alcol e salute (che inevitabilmente tira in ballo il rapporto tra vita e salute), ma anche sullo spazio che avranno i prodotti senza alcol nel futuro. E tornando all’economia del vino, il confronto si è spinto sugli espianti come soluzione al rallentamento del mercato oppure sulla resilienza dei piccoli produttori.
Sulle bevande prodotte dalla dealcolazione del vino si è trovata una convergenza nell’ammettere che non siano propriamente sostenibili – perché raddoppiano i processi e il consumo di energia rispetto alla produzione del vino, che diventa a sua volta materia prima da rilavorare – eppure che possano diventare un pezzo della filiera vitivinicola (guadagnandone le stesse garanzie di controllo, decisamente superiori ai soft drink). Perché va riconosciuto che, se il comparto vino è diventato un pezzo rilevante dell’economia globale, una serie di processi culturali, normativi, sociali sta mettendone a rischio la tenuta.
Ecco allora la riflessione spostarsi sui sostegni (con fondi pubblici) alla distillazione di emergenza – che chiude la filiera da generazioni, è vero, ma porta a una seconda lavorazione come i dealcolati – e soprattutto sui contributi per gli espianti di vigneti. Un paradosso per qualcuno, perché sono gli stessi vigneti impiantati con contributi pubblici, ma una spiacevole necessità per chi guarda alla necessità per i viticoltori di superare un momento di fragilità. Perché la viticoltura, è bene ricordarlo, non è solo produzione di vino: è anche cura e tutela del paesaggio, manutenzione idrogeologica, valorizzazione di contesti dedicati al turismo.
Se poi si caricano i vigneti di chimica per fare quantità massive di uva poco buona, anziché scegliere un approccio rigenerativo capace di restituire vigore naturale alle piante, e si comprano mosti e vini sfusi da Spagna o Romania per fare vini da supermarket… allora davvero poco si vuole interagire con chi sceglie il vino per consapevolezza.
Niente Occam né scorciatoie
In questo passaggio emerge la necessità cruciale di abbandonare una volta per tutte la visione del vino come commodity – da produrre in quantità esponenziale e da sussidiare con fondi pubblici alla maniera dell’automotive – per dare alla progettualità una visione. Ecco che il vino come cultura, come esperienza, come paesaggio, come incontro può avere un futuro anche e soprattutto tra i giovani. Solo che applicando le categorie desuete dell’economia orientata alla massa di consumatori inconsapevoli, le stesse che hanno portato alla crisi attuale, il vino perde di fronte alle lobby che fanno apparire la cola più salutare dell’olio extra-vergine o che normano in maniera sempre più radicale il benessere collegato all’alcol e in maniera molto soft (e diluita) quello collegato ai grassi saturi, ai polifosfati, al glifosato o alle microplastiche.
Il discorso è ampio, i nodi sono complessi e non ci sono scorciatoie, né bastano i rasoi di Occam per definire una risposta univoca. Però, appunto, la riflessione è necessaria.
«Rigenerazioni era nata come un ritiro creativo – conclude Moser – filosofico ma anche molto pratico. Un momento di respiro prima della vendemmia. Si è rivelata un’occasione preziosa per scoprire che i nodi su cui ci interroghiamo ogni giorno sono spesso condivisi da chi lavora nel mondo del vino. E che proprio quei nodi (le domande, le incertezze, le passioni) disegneranno il profilo del vino del futuro».
L'articolo Il vino del futuro ha bisogno di consapevolezza proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0















































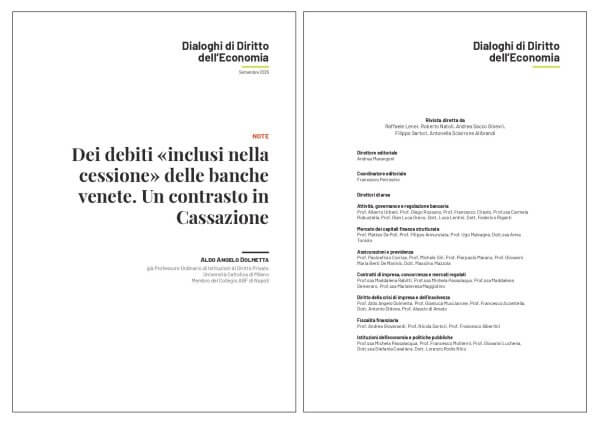
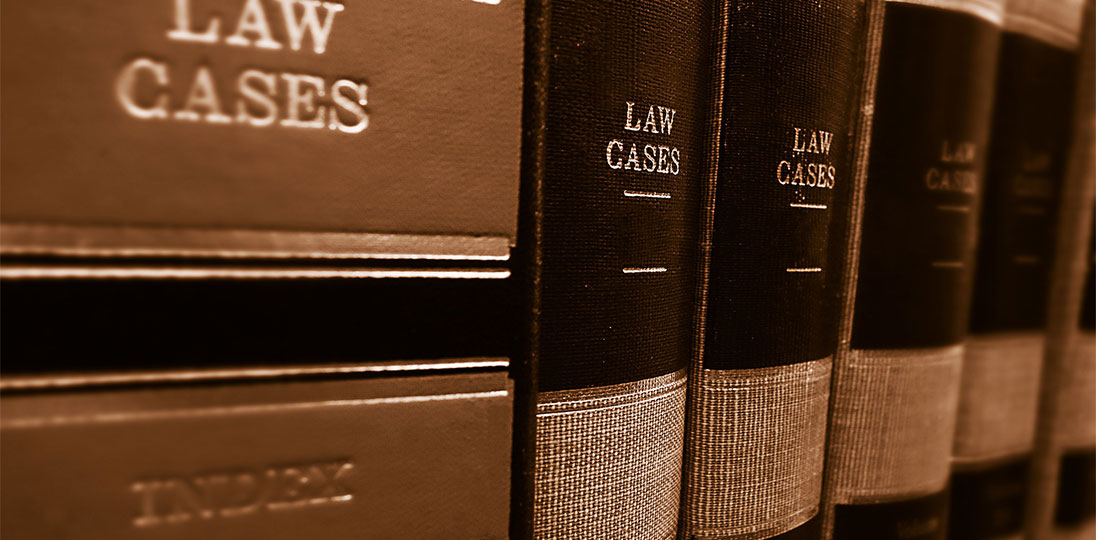



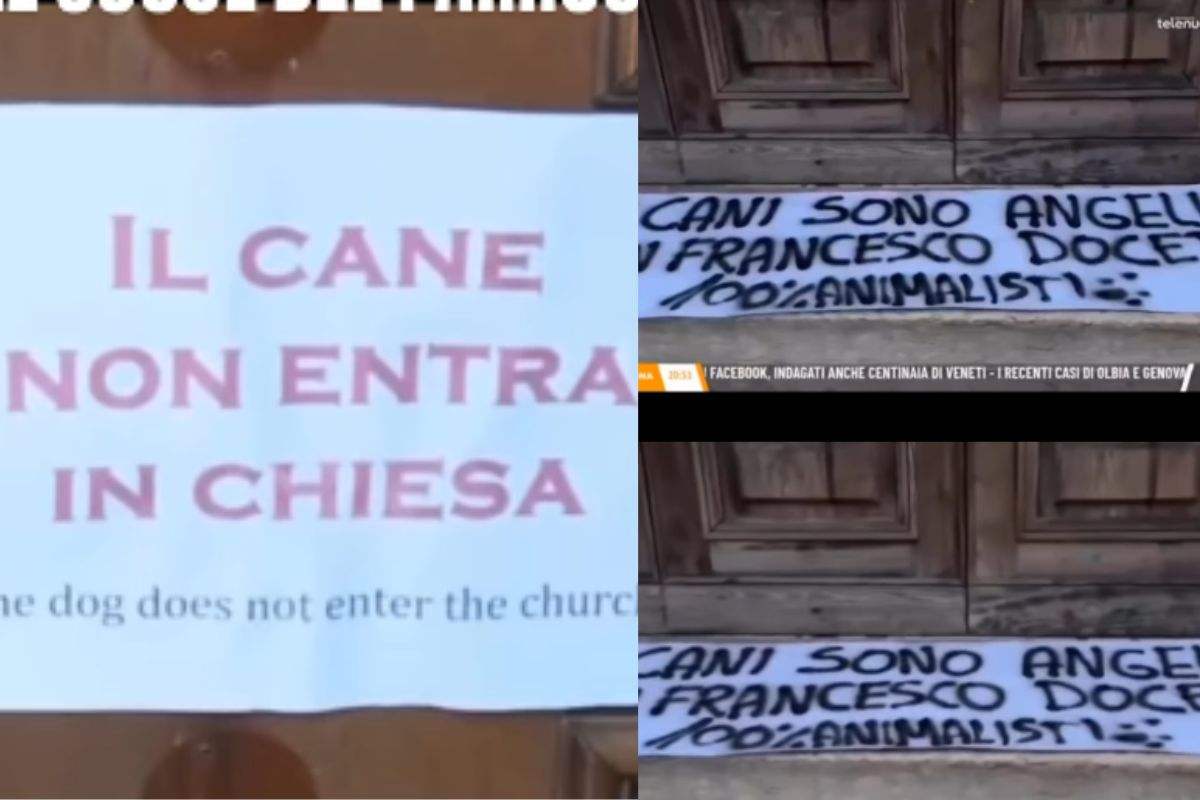

































/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/09/wp_drafter_181208.jpg)
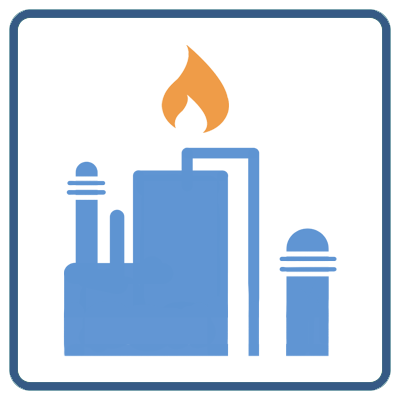


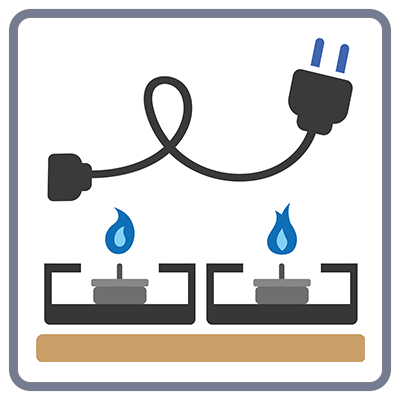


























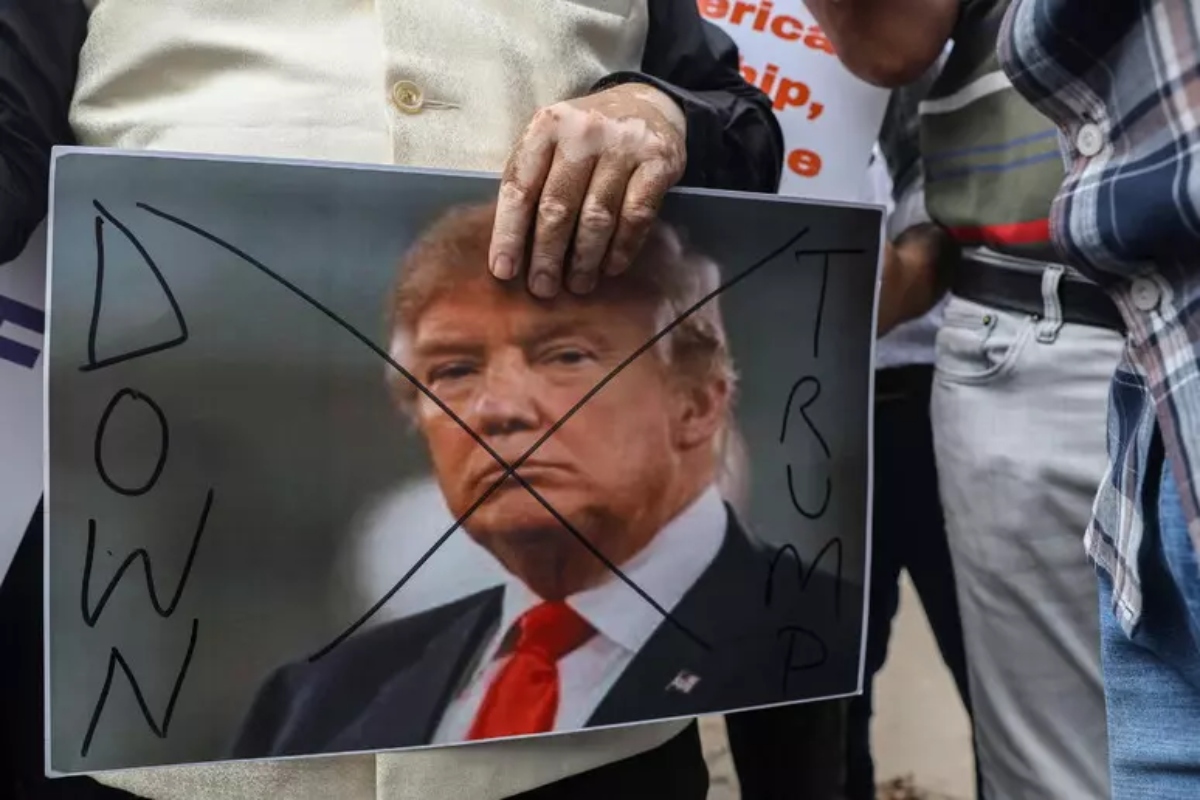





















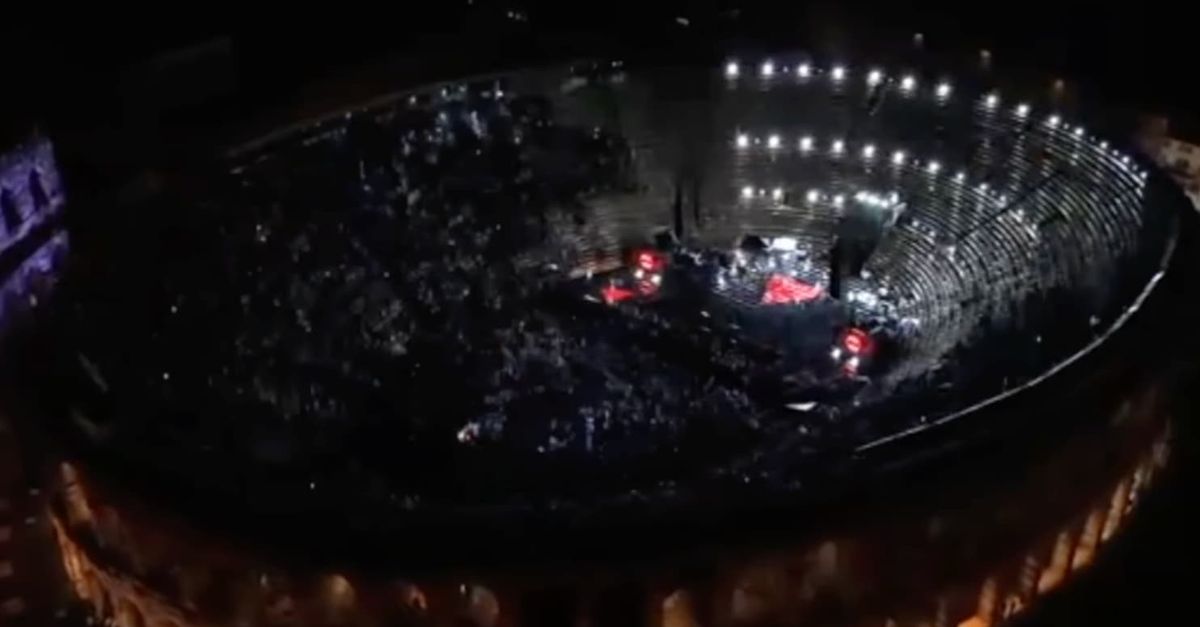






































%20Carole%20Bethuel.jpg)













-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)