INTERVISTA / Angelova (CESE): “L’Ue sostenga la ‘diplomazia blu’ e la cooperazione idrica nel mondo”

Bruxelles – Ormai da tempo, l’acqua è al centro, da un lato, di molti conflitti in diverse parti del mondo e, dall’altro, di nuovi movimenti migratori direttamente collegati agli effetti del cambiamento climatico. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha adottato lo scorso 18 settembre un’opinione sul tema, dal titolo “Diplomazia blu e cooperazione idrica“. La co-relatrice Milena Angelova (rappresentante del gruppo dei datori di lavoro all’interno del CESE, proveniente dalla Bulgaria) ne ha spiegato a Eunews i punti salienti.
Anzitutto, cosa dobbiamo intendere con queste espressioni? Angelova descrive la diplomazia blu come “un insieme di azioni che promuovono la cooperazione idrica, affinché l’acqua venga utilizzata come strumento di pace e stabilità anziché come un’arma”. “L’uso efficiente e sostenibile dell’acqua dovrebbe divenire una componente centrale della diplomazia comunitaria”, ribadisce, al fine di “ridurre la pressione sulle risorse idriche, mitigare gli effetti della siccità legata ai cambiamenti climatici e garantire la disponibilità di risorse idriche per le generazioni future”.
La rappresentante del Cese auspica “l’uso della politica per ridurre le tensioni sull’acqua e l’uso dell’acqua per ridurre le tensioni politiche, nel rispetto dei princìpi del diritto internazionale“. La questione, sottolinea, è rilevante tanto all’interno quanto all’esterno dei confini dell’Unione. Si tratta di promuovere pratiche di agricoltura sostenibile, o di politica commerciale responsabile, sia negli Stati membri sia a livello di partenariati con Paesi terzi (ad esempio lungo il bacino del Mediterraneo, soprattutto per quanto riguarda il cosiddetto nesso acqua-energia-cibo-ecosistema, noto con l’acronimo inglese WEFE).
Angelova suggerisce di “integrare quadri giuridicamente vincolanti che stabiliscano diritti e responsabilità chiari per le risorse idriche condivise, allineando al contempo le politiche nazionali nell’ambito di strategie mirate a livello di bacini idrici“. Soprattutto, ma non solo, quelli fluviali. Ci sono già casi di gestione coordinata dei fiumi, in cui “autorità congiunte” e “meccanismi di governance multi-stakeholder” favoriscono la corresponsabilità e riducono le tensioni “idropolitiche”.

Nel concreto, si tratta di condividere dati, istituire processi di notifica preventiva, introdurre consultazioni per la creazione di infrastrutture idriche, nonché prevedere investimenti condivisi per “mitigare i rischi di azioni unilaterali che potrebbero aggravare l’attuale stress idrico“. Nel Vecchio continente, un esempio alcuni esempi virtuosi sono quelli del Danubio – che lambisce ben 10 Paesi tra cui sette membri UE – e del Reno, che bagna sei Stati tra cui quattro UE.
Su questo versante, spiega Angelova, la politica estera a dodici stelle “dovrebbe promuovere iniziative diplomatiche a sostegno di accordi idrici resilienti rispetto al clima a livello di bacino e di meccanismi cooperativi di condivisione delle risorse idriche, con l’obiettivo finale di ridurre le tensioni tra gli Stati rivieraschi e promuovere la pace”. Il focus, specifica, va posto sulla “salvaguardia del diritto umano all’acqua e ai servizi igienico-sanitari e sulla protezione costante delle risorse idriche e delle infrastrutture idriche“, pure in tempo di guerra.
Dove? Soprattutto laddove “i cambiamenti climatici stanno accelerando le crisi idriche globali, aggravando siccità, inondazioni e scarsità d’acqua“, riflette la co-relatrice, indicando una serie di aree calde soprattutto nel cosiddetto “sud globale” (Africa sub-sahariana, Sudamerica, Asia centrale, Nordafrica e Medio Oriente, soprattutto). “La scarsità d’acqua e la cattiva gestione delle risorse sono diventate fattori chiave di sfollamento, in particolare nelle regioni fortemente dipendenti dall’agricoltura e dalla pesca e dove la desertificazione complica l’accesso all’acqua potabile”, chiosa.
Tali dinamiche non fanno che “aumentare la pressione migratoria” su vari livelli. Anzitutto domesticamente, dalle periferie ai centri urbani. Poi verso altri Paesi: quelli limitrofi, in primo luogo, e poi verso il “nord del mondo“. Inclusa l’Europa, che si fa sempre più “fortezza” e in questa fase storica non può – o non vuole – dedicarsi ad accogliere dignitosamente gli esseri umani che cercano di raggiungerla, preferendo espellerli. Si tratta, rimarca Angelova, di “una realtà già in atto che potrebbe presto raggiungere proporzioni senza precedenti, se non verranno adottate rapidamente misure politiche efficaci”.
Tra le cause delle recenti ondate migratorie da Afghanistan e Pakistan verso l’Ue, ad esempio, c’è proprio la desertificazione repentina in corso in questi Paesi. Allo stesso modo, continua, il progressivo prosciugarsi di bacini idrografici importanti come il lago Ciad nel Sahel o quello d’Aral in Asia centrale, o di fiumi come il Nilo e il Congo, sta “causando catastrofi ambientali di dimensioni storiche, che potrebbero destabilizzare le relazioni diplomatiche regionali e scatenare conflitti e ulteriori ondate migratorie“. Alcune stime, ci dice, parlano di 1,2 miliardi di persone sfollate per ragioni climatiche entro il 2050.
Tutto ciò lega indissolubilmente l’ambito idrico-climatico a quello della sicurezza in senso lato. “La politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell’UE e la strategia Global Gateway dovrebbero integrare esplicitamente la diplomazia blu come pilastro” delle loro attività, incalza Angelova. Ad esempio nella stipula di partenariati strategici con Paesi terzi (soprattutto dove i bacini fluviali transfrontalieri rappresentano potenziali focolai di conflitto), nel nuovo Patto per il Mediterraneo ma anche nell’uso di strumenti come la European peace facility (EPF) o nella definizione di accordi commerciali.

C’è contezza di tutto questo a Bruxelles? La co-relatrice cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno. “L’UE è già uno dei maggiori donatori mondiali per i progetti legati all’acqua e con la diplomazia blu si può allineare ulteriormente l’assistenza allo sviluppo con gli obiettivi geostrategici” dei Ventisette, sostiene. Concretamente, bisogna “concentrare i finanziamenti verso le regioni più fragili” e “aumentare gli investimenti nella gestione integrata delle risorse idriche“, accordando priorità alla resilienza idrica laddove la scarsità d’acqua è causa di crisi umanitarie, migrazioni e conflitti.
Del resto, ricorda la rappresentante del CESE, l’UE gioca un ruolo di leadership nella governance ambientale multilaterale e può dunque impegnarsi per “plasmare attivamente la diplomazia globale in materia di acqua” in sedi come le Nazioni Unite, il G20 e l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). L’Unione dovrebbe promuovere “un’iniziativa globale per la resilienza idrica“, prosegue, fissando standard elevati in materia per trattarla “con la stessa ambizione con cui affronta la decarbonizzazione, poiché quella dell’acqua è una questione che va oltre il semplice ambito ambientale e climatico”.
La “giustizia idrica” dev’essere la Stella Polare per l’UE, aggiunge, e la strategia in materia di resilienza idrica “dev’essere trasversale e includere anche le politiche industriali, l’agricoltura, la politica dei consumatori, l’energia e la salute e, naturalmente, le politiche esterne e di sviluppo”. Va bene, ma con quali risorse? Il Comitato, dichiara Angelova, “ribadisce la sua richiesta di adottare l’acqua come priorità strategica nel prossimo quadro finanziario pluriennale” (QFP) per il periodo 2028-2034, attualmente in discussione tra Commissione e co-legislatori (Consiglio ed Eurocamera).
Ci sono delle speranze, osserva, per il prossimo budget comunitario. La commissaria Jessika Roswall (responsabile per l’Ambiente, la resilienza idrica e un’economia circolare competitiva), sta compiendo un tour negli Stati membri per raccogliere le loro “esigenze più urgenti”, sulle quali verrà fatto il punto in occasione del primo Forum sulla resilienza idrica in calendario per il prossimo 8 dicembre a Bruxelles. Tutto questo, secondo Angelova, avrà un peso nelle discussioni sul nuovo QFP. Soprattutto, conclude, la resilienza idrica dovrebbe rappresentare uno dei pilastri del famigerato Fondo per la competitività, che dovrebbe essere dedicato alla sicurezza nel suo senso più lato.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0




































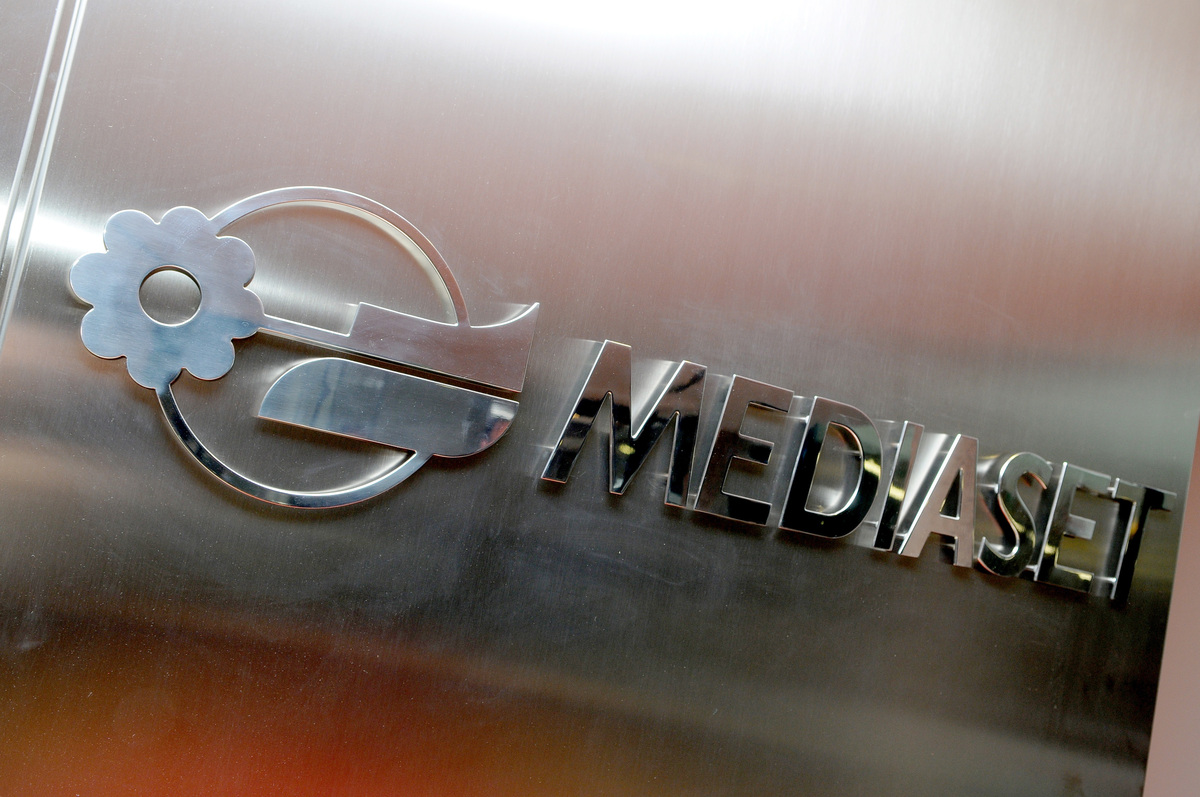



























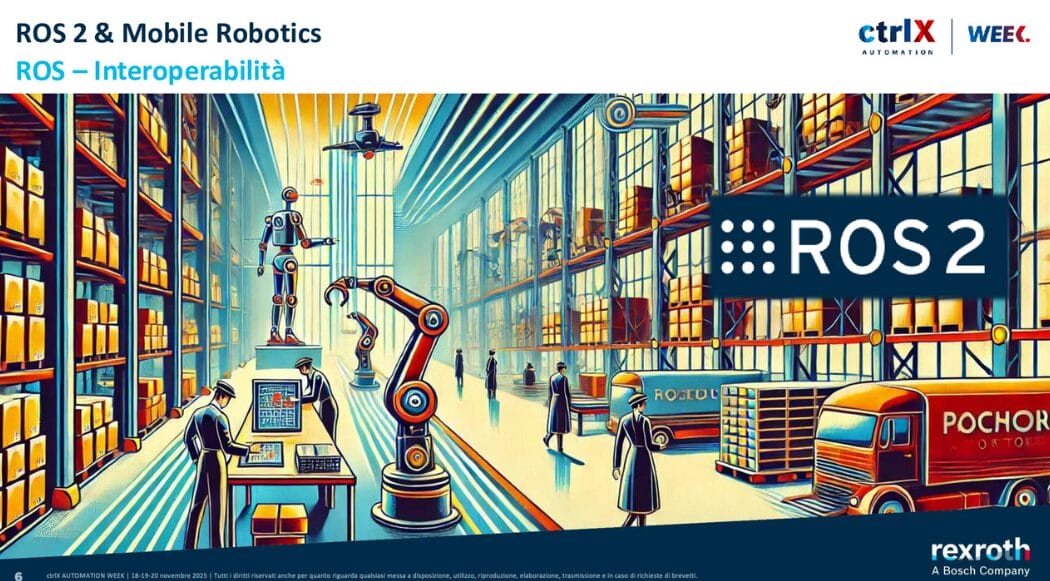












































































































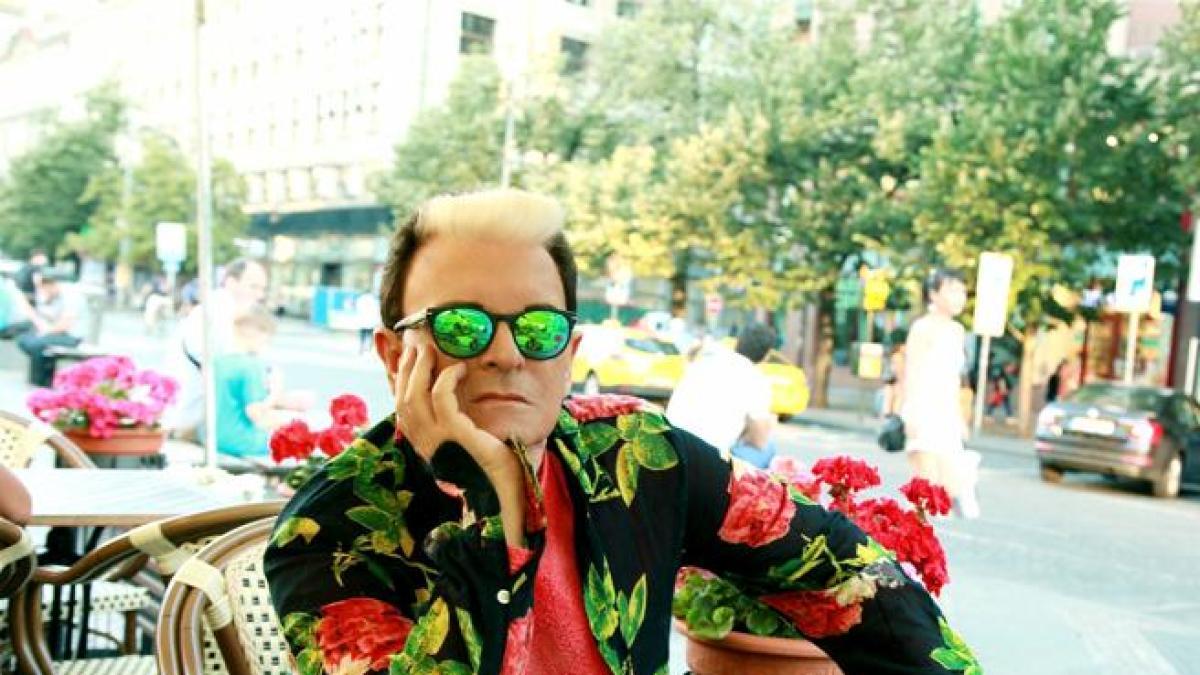

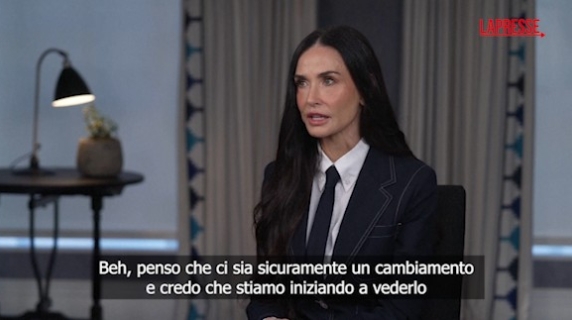




















-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)























































