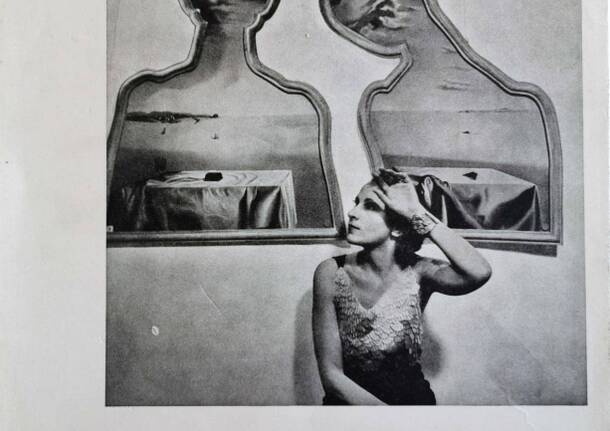L’acqua sarà la risorsa chiave del futuro. Ma l’Italia investe meno della metà del necessario

Articolo tratto dal numero di agosto 2025 di Forbes Italia. Abbonati!
Si discute spesso del ruolo della geografia – buona o cattiva – nel determinare il successo economico e sociale dei popoli. In questo discorso, l’acqua è protagonista assoluta: risorsa tanto geografica quanto strategica, ha diviso e unito comunità, influenzato guerre e tracciato i confini dello sviluppo agricolo, energetico e urbano.
La disponibilità di risorse idriche, unita alla fertilità dei suoli, ha storicamente determinato la nascita e la prosperità delle civiltà. Oggi, in un contesto di cambiamento climatico accelerato, la scarsità d’acqua è una minaccia non solo per le colture, ma anche per la produzione di energia idroelettrica, il turismo e la stabilità sociale in molte regioni del mondo.
Eppure, nonostante la siccità occupi sempre più spesso le prime pagine dei quotidiani, il problema più strutturale e per certi versi più preoccupante è quello della desertificazione.
Siccità e desertificazione
Per comprendere la sfida, bisogna distinguere tra siccità e desertificazione. La prima è un evento meteorologico transitorio, nonostante possa essere relativamente frequente. La seconda, invece, è un cambiamento climatico a lungo termine che riduce la capacità di un terreno di trattenere l’acqua, ovvero è un processo di progressiva erosione della fertilità e della capacità produttiva del suolo, che diventa sempre più inospitale per agricoltura, allevamento e insediamenti umani.
Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione, oltre il 40% delle terre emerse del pianeta è oggi deteriorato, ovvero desertificato, con un impatto diretto su oltre tre miliardi di persone. L’Ipcc (il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico) prevede che entro il 2050 almeno quattro miliardi di esseri umani vivranno in aree con grave stress idrico, mentre in Italia si stima che il 28% del territorio nazionale sia a rischio desertificazione. Le aree più colpite sono il Sud e le isole, ma anche le pianure irrigue del Nord iniziano a mostrare segnali di sofferenza.
Quanto costa la città
Per altri versi, la siccità non è solo un problema per i raccolti. Il Joint Research Centre della Commissione europea stima che ogni anno la carenza idrica costi all’economia europea oltre 9 miliardi di euro. In Italia, solo nel 2022 le perdite stimate per le aziende agricole ammontavano a oltre 6 miliardi, secondo Coldiretti. Ma le ricadute sono molto più ampie: pensiamo alla produzione industriale, in particolare in settori idrovori come la chimica, la carta o l’alimentare, o al turismo estivo, sempre più esposto a fenomeni di scarsità idrica e incendi boschivi.
Sprechi e investimenti insufficienti
In un contesto così preoccupante, da un punto di vista economico e anche sociale, ci si aspetterebbe una grande parsimonia e attenzione nell’uso delle risorse idriche, ma la realtà è ben diversa. In Italia circa il 42% dell’acqua immessa nelle reti di distribuzione va perduta. Una cifra che sale al 50% al Sud, mentre il Nord, pur avendo una performance migliore, ne perde comunque oltre un terzo. Recentemente l’Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) ha introdotto nuove regole tariffarie che premiano i gestori virtuosi nella riduzione delle perdite e nella sostenibilità ambientale del servizio idrico. Si tratta di un passo importante, probabilmente insufficiente, ma che certamente va nella direzione non solo di garantire una migliore redditività per gli operatori più attenti, ma anche in quella di sostenere finanziariamente quegli investimenti che vadano a migliorare l’efficienza delle reti.
La transizione ecologica passa infatti anche per l’acqua. Occorrono massicci investimenti in reti di distribuzione intelligenti, bacini di accumulo, sistemi di riutilizzo delle acque reflue, sensori per la gestione in tempo reale delle risorse. Secondo Utilitalia, il fabbisogno di investimento del sistema idrico italiano è di 7,5 miliardi di euro all’anno per i prossimi 20 anni. Oggi ne investiamo meno della metà. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) ha destinato 4,4 miliardi al settore, ma si tratta solo di un primo passo. In prospettiva, sarà decisivo affiancare all’investimento pubblico una chiara strategia di regolazione e incentivazione.
Le ripercussioni politiche della scarsità d’acqua
In uno scenario che si avvia a essere climaticamente problematico, è necessario riportare alla mente come i problemi non saranno solo economici, poiché, storicamente, la scarsità d’acqua ha causato conflitti. In Italia, le cronache medievali sono piene di dispute tra comunità per l’accesso a canali e rogge. A livello globale, i conflitti legati all’acqua sono già oggi una realtà: tra Israele e Palestina, lungo il Nilo tra Etiopia ed Egitto, tra India e Pakistan nel bacino dell’Indo. Sempre secondo l’Ipcc, entro il 2050 il rischio di conflitti per le risorse idriche aumenterà in modo esponenziale, soprattutto in Africa e Asia. Ma anche l’Europa, complice la crisi climatica e migratoria, potrebbe non esserne immune, almeno indirettamente.
La lotta al cambiamento climatico è uno degli assi portanti della politica economica europea. Ma questa battaglia non si vince senza una politica dell’acqua, che non può più essere data per scontata, né trattata come un bene infinito, nonostante la sua caratterizzazione di risorsa rinnovabile.
Che cosa fare
Cosa possiamo fare? La desertificazione non è un problema distante, è già qui, così come lo è, in tante regioni, la siccità. Può colpire i campi, i rubinetti e i bilanci delle famiglie e delle imprese. Serve un nuovo approccio, che veda l’acqua come capitale naturale da proteggere, gestire e valorizzare. Un approccio che certo premi la sostenibilità, che responsabilizzi i cittadini e che ponga al centro la manutenzione e l’innovazione delle reti idriche. Ma è pure necessario sostenere un settore industriale, quello della gestione dei servizi idrici, che è di fondamentale importanza in questa lotta e che per troppi decenni è stato trascurato.
Questo nuovo approccio non può essere space-blind, ma deve partire dalle specificità locali per definire una coerente politica industriale. La geografia non è, infatti, solo una mappa, bensì l’insieme delle relazioni esistenti tra persone, territori e risorse. L’acqua, in questo senso, è il più geografico dei beni e oggi, forse, anche il più strategico. Non riconoscerne tale caratteristica all’interno di necessari interventi di politica economica a sostegno di investimenti e innovazione tecnologica significa partire già con il piede sbagliato.
LEGGI ANCHE: Deloitte: entro il 2050 l’80% dell’elettricità nei paesi G20 proverrà da fonti non fossili
L’articolo L’acqua sarà la risorsa chiave del futuro. Ma l’Italia investe meno della metà del necessario è tratto da Forbes Italia.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0















































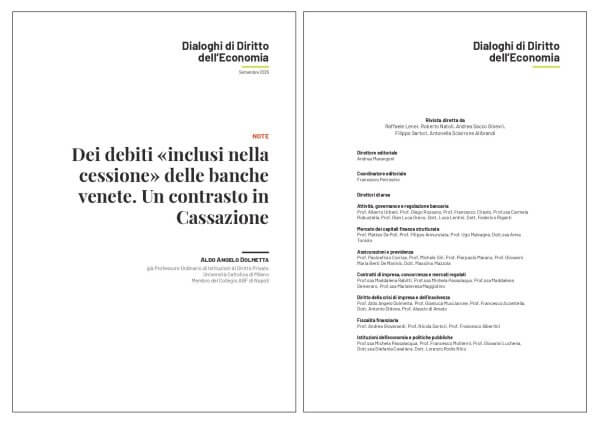
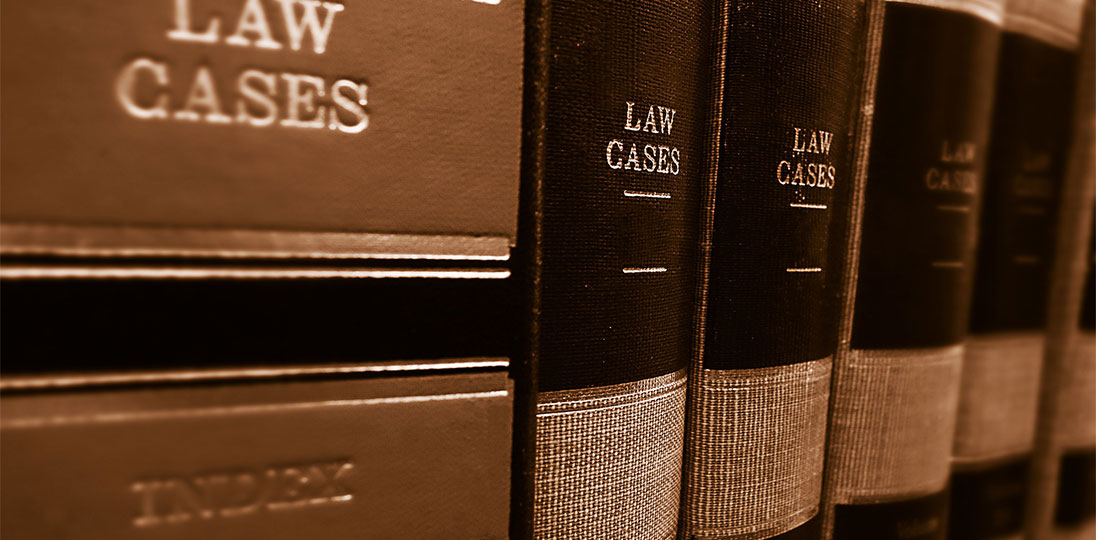



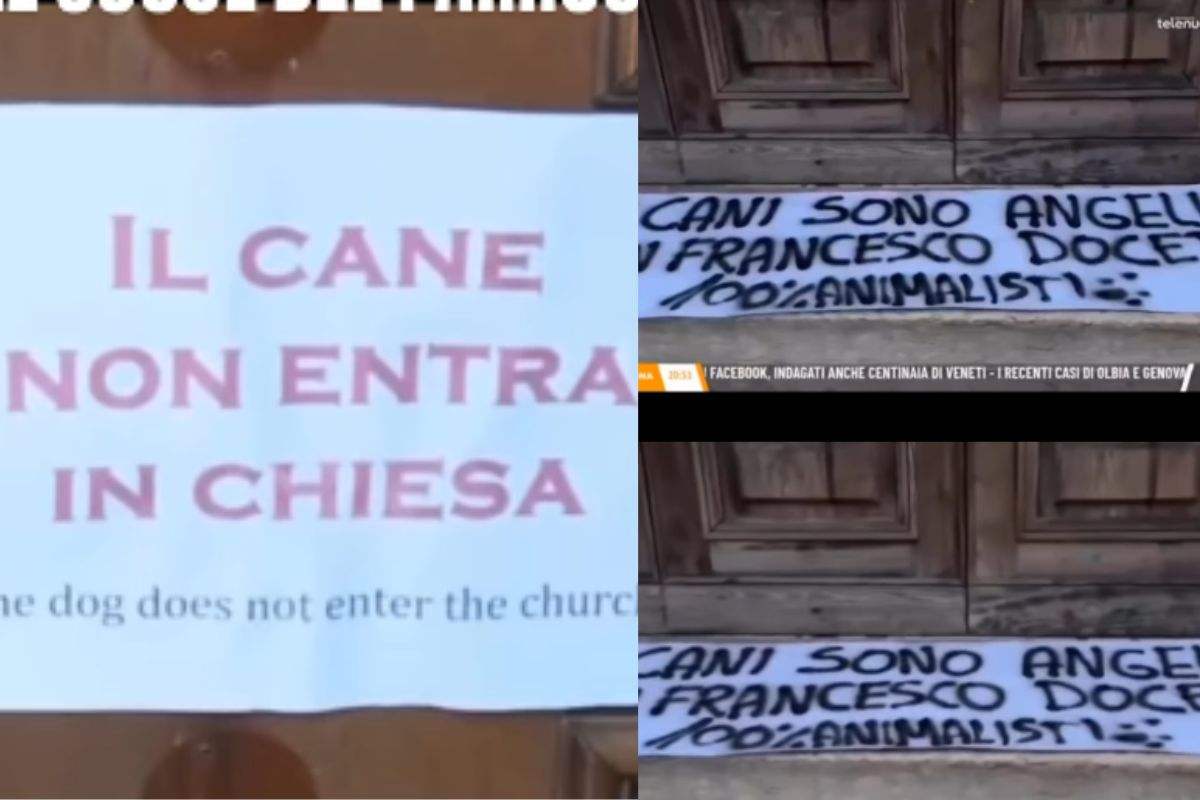

































/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/09/wp_drafter_181208.jpg)
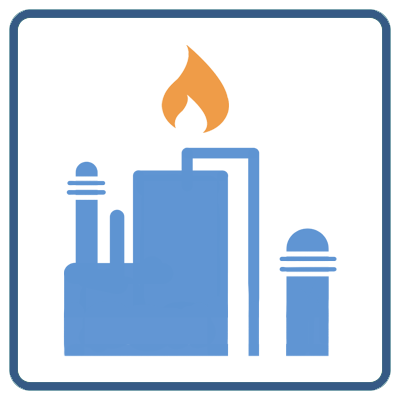


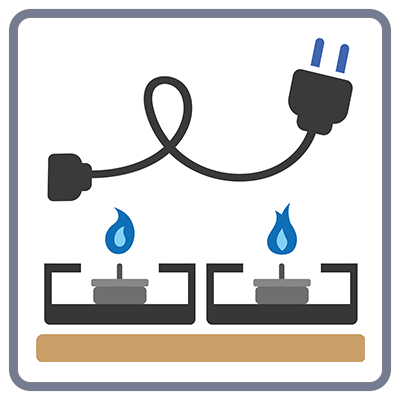


























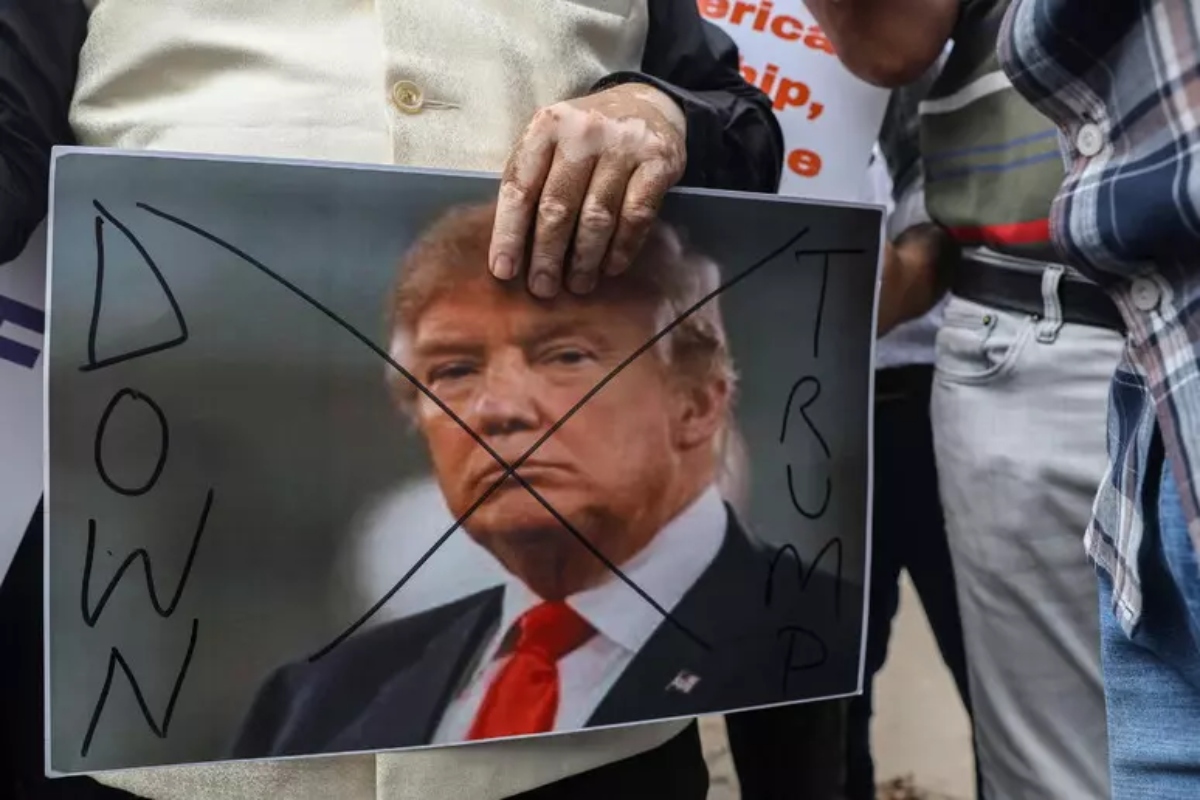





















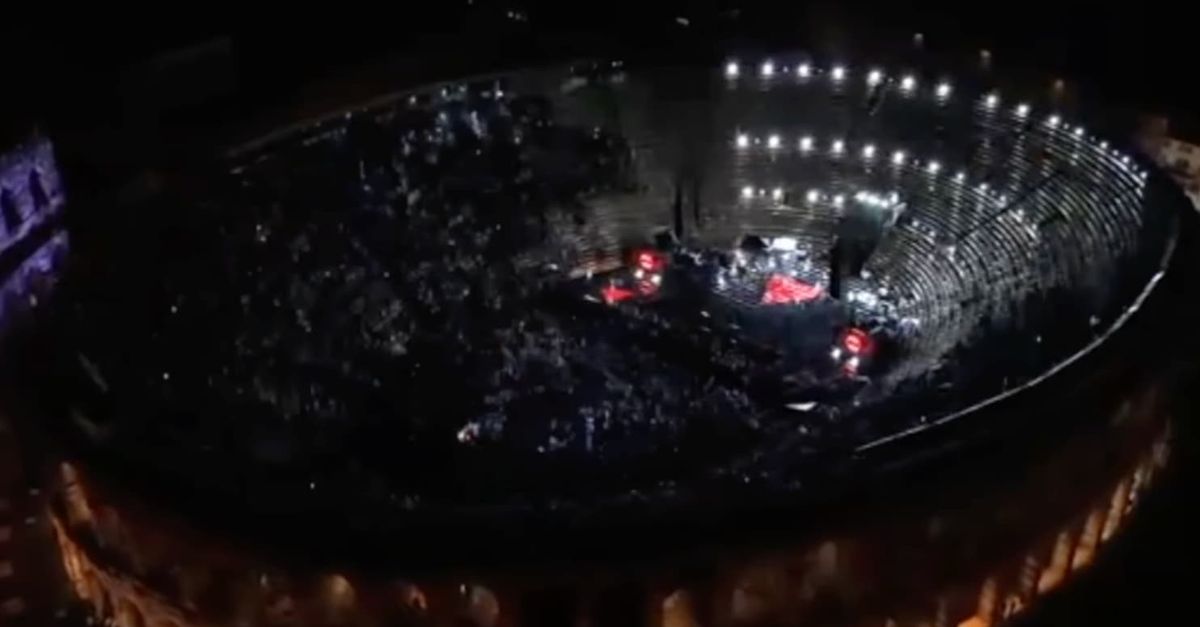






































%20Carole%20Bethuel.jpg)













-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)