L’Amarone alla tavola del mondo


C’è una pagina dell’“Atlante mondiale dei vini” (edizione 1995) che, riletta oggi, racconta un’epoca perduta, difficilmente comprensibile a noi contemporanei. L’Amarone è lì descritto come un vino forte e concentrato, il che è vero anche oggi; «culmine di ogni banchetto veronese», altro enunciato sincero trent’anni dopo; ma soprattutto come un vino che fuori dai confini veneti è «più ammirato che consumato». Tre decenni dopo lo scenario è differente e Santa Sofia festeggia i sessant’anni di Gioè e Montegradella spedendo circa il 75 per cento delle sue venete bottiglie in settanta Paesi del mondo, Islanda compresa.
È successo come? È successo lavorando duro per trent’anni, dopo i trenta precedenti. La famiglia Begnoni guida la casa dal 1967 e oggi Luciano Begnoni, patron e costruttore dell’export dell’azienda, ha riportato l’Amarone in tavola: «Mio papà ha fatto l’enologo in Santa Sofia per circa sessant’anni; io sono arrivato a metà anni Ottanta… e all’inizio ero il peggior figlio di un enologo, essendo astemio. Poi il vino è diventato una ragione di vita».

Santa Sofia lavora su circa settantotto ettari e produce attorno a settecentocinquantamila bottiglie l’anno, guardando più al futuro che al passato: alla sede storica nella villa palladiana di Pedemonte di San Pietro in Cariano se ne affiancherà infatti una nuova, con un’architettura che sarà «Palladiana in stile moderno: non “tipo Gardaland”, ma concreta… la vedrete», continua Begnoni. Un luogo di lavoro in grado di custodire una memoria familiare forte, nonché il sogno del padre, oggi novantenne e come accennato enologo per una vita, e della sorella Patrizia, cui il progetto è idealmente dedicato.
Ma parliamo di vino. Il Gioè nasce nel 1964 (e prende la sua forma definitiva nel 1967) unendo tre vitigni autoctoni – Corvina, Corvinone e Rondinella – provenienti da tre ettari nella parte alta del Monte Gradella. Venti edizioni in tutto, con il 2016 indicato dal Consorzio tra le annate eccezionali. Accanto a Gioè c’è il Montegradella, che oggi significa ventiquattro ettari in Valpolicella tra Fumane e Marano, su suoli calcareo-marnosi.

Dettagli alla mano, Gioè nasce tra i 195 e i 325 metri della parte alta del Gradella: le uve riposano per circa cento giorni prima della pigiatura, poi una macerazione di una trentina di giorni e un lungo passaggio di quarantadue mesi tra botti di Slavonia e tonneaux da cinquecento litri, quindi almeno quattro anni di bottiglia. Montegradella segue una via più rapida: appassimento intorno ai trenta giorni e affinamento di diciotto mesi, prima annata nel 1965. Il nome Gioè rimanda tradizionalmente a quella porzione alta del Monte Gradella che ne ha segnato l’identità. Non tutte le vendemmie diventano Gioè: in sei decenni le edizioni sono venti.
Chiedere a un Amarone di essere leggero è un controsenso, e anche quello Santa Sofia non è un Amarone “leggero” – non può esserlo – ma è un Amarone sotto stretta sorveglianza alcolica: mira ai 15 gradi, quando molti colleghi stanno decisamente più in alto, anche perché, conclude Begnoni, «Due persone che amano un vino rosso importante devono finire la bottiglia: siamo tra le poche cantine con l’Amarone ancora a 15 gradi in etichetta: vogliamo che si arrivi al terzo, al quarto bicchiere». È una scelta tecnica e culturale coerente con i tempi in cui viviamo, figlia di un’idea di bevibilità che guarda alla cucina di oggi e a un pubblico che beve meno e soprattutto meno alcolico.

L'articolo L’Amarone alla tavola del mondo proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0
































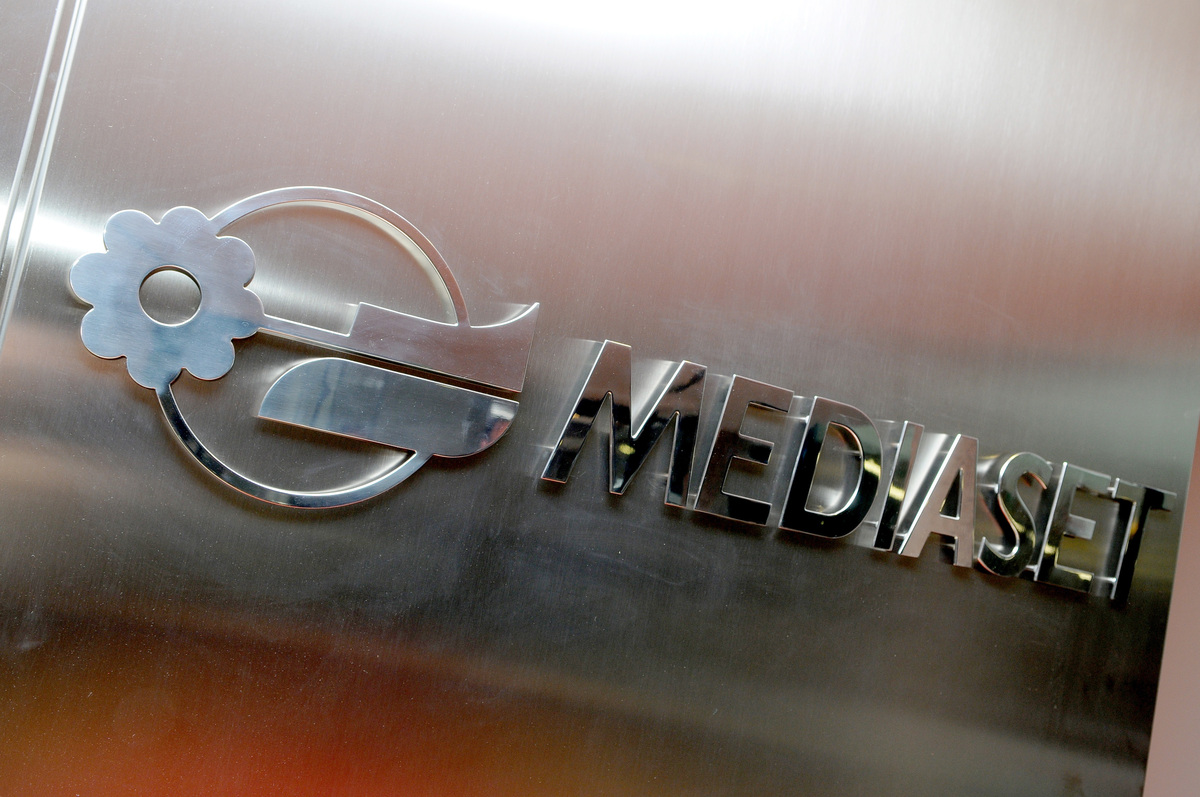


















































/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/11/trade-republic-conto-canone-zero-offre-2-percento-liquidita.jpg)
























































































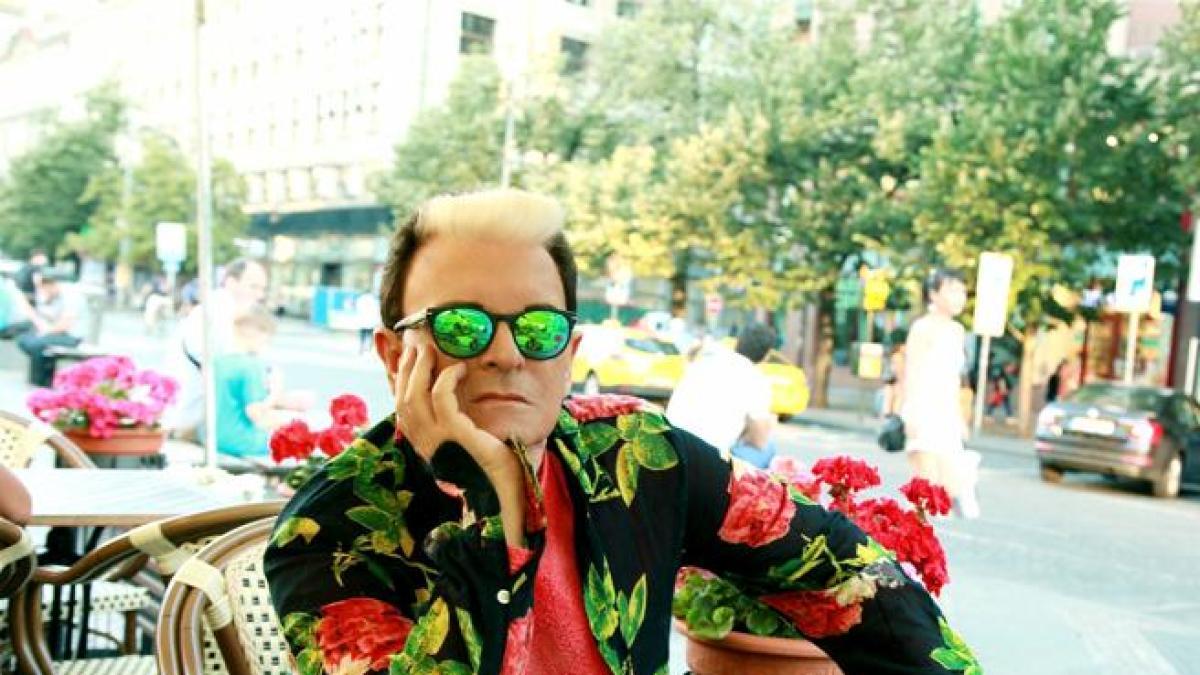

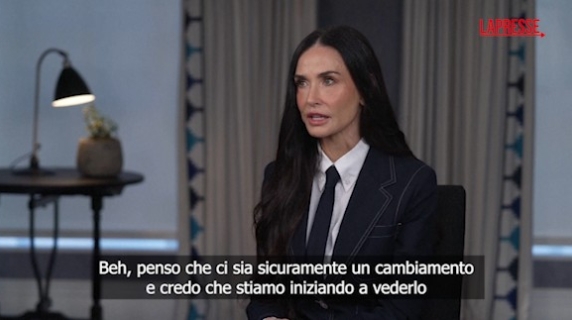




















-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)























































