La musica di squadra di Joe Armon-Jones


Joe Armon-Jones va ascoltato. È il suggerimento più adeguato a chi fa fatica a visualizzare un blend di jazz, dub, influenze afro e note avvolgenti prese in prestito dall’rnb psichedelico. Su questo gioco di emozioni e tappeti sonori inaspettati, si è costruito una carriera da solista, produttore e compositore che non ha tardato a decollare. Per farlo, il tastierista degli Ezra Collective, nu-jazz ensemble che non dovrebbe più aver bisogno di presentazioni, si è circondato da persone di cui si fida, con cui negli anni ha tessuto legami profondi. «La musica è il punto di partenza. Man mano che lavoro sull’editing, aggiungo campionamenti, texture e strati sonori, e il progetto comincia a prendere forma. È come leggere un libro: all’inizio non hai un’immagine chiara del mondo in cui ti stai immergendo, ma pagina dopo pagina la tua mente lo costruisce. Così accade con la musica. Col tempo, l’estetica e il mondo a cui appartiene l’album diventano sempre più nitidi. Nel caso di All The Quiet, ho avuto un momento rivelatore: un’atmosfera futuristica, post-apocalittica, con un castello o un luogo simbolico attorno a cui ruota tutta la storia. Si è cristallizzato naturalmente, passo dopo passo».
Effettivamente, immaginarsi una cittadella in un futuro distopico, che rappresenta l’ultimo studio musicale rimasto sulla terra, dove l’arte del far musica sta scomparendo, non è cosa da poco. Qui, paladini del suono accorrono in soccorso, combattendo contro la conformazione, la rivoluzione digitale e la perdita di valore dell’atto creativo. La cittadella di Joe è una roccaforte, simbolo di resistenza creativa e culturale che abita All the quiet Part I, una resilienza contemporanea, concepita per esaltare i superpoteri della musica. Qua e là, le voci suadenti di Goya Gumbani, Asheber, ci risvegliano da un limbo di melodie che non hanno paura di lasciare spazio all’improvvisazione per riportarci con i piedi per terra. Quanto alla Part II, i toni si fanno più seri, le collaborazioni si rinnovano, questa volta con Hak Baker, Greentea Peng & Wu-Lu o Yazmin Lacey. Sotto assedio, la Cittadella è minacciata da forze governative. I ritmi si stringono, le melodie si incupiscono, riflettendo la lotta per la sopravvivenza dell’arte, in un mondo che rischia di metterla da parte. Uscito nel 2025, questo doppio album è una metafora che rispecchia le minacce tecnologiche e le fatiche dell’industria musicale per restare al passo con i tempi, continuando a realizzare prodotti di qualità.

Forgiare universi
Cadere sotto il fascino della sua chioma ramata, spesso arruffata, e di uno sguardo limpido, genuino, è un rischio da non sottovalutare. «Sono sempre stato attratto dalle copertine capaci di creare un mondo, come quelle dei Parliament-Funkadelic, ricche di dettagli e amore, o di Scientist e Prince Jammy. Nei miei lavori si legge anche una forte componente fantascientifica, alla Dune o Isaac Asimov. Tutto ciò confluisce nel mio modo di interpretare l’immaginario visivo e l’universo che gravita attorno alla musica». Altri amici, Ralph Berryman e Divya Scialo, trascrivono il tutto in illustrazioni grafiche e dipinti che non si dimenticano». La conversazione si fa concitata, Joe confessa che a volte si sente in disaccordo la tendenza contemporanee, perché la musica di qualità, quella “fatta a mano” si sta rarefacendo: «Alcuni aspetti fondamentali del fare musica, quegli stessi elementi che un tempo erano imprescindibili, sono stati messi da parte. Un esempio è lo studio dello strumento: oggi molti non sentono più il bisogno di raggiungere un certo livello di abilità come si faceva negli anni Settanta, Ottanta o Novanta, anche perché la tecnologia può sopperire a molte mancanze. Ci sono dischi che amo in cui si percepisce una tensione naturale, quel “tirare e mollare” che dà alla musica un’anima».
Classe 1993, originario di un paesino sperso nell’Oxfordshire, Joe è il primo di cinque fratelli cresciuto a pane e musica da una madre cantante e da un padre pianista jazz. Tra la prole, c’è chi opta per il violoncello, chi per il flauto; lui finisce per dedicarsi alle tastiere. «Dove vivevo non c’erano musicisti, a parte me e la mia famiglia. Volevo suonare con altre persone. Trasferirmi a Londra è stato fondamentale per incontrare le persone con cui poi ho formato band e costruito connessioni reali». A diciannove anni, nella capitale, frequenta il Trinity College of Music. Ai tempi frequenta le serate University of Dub, una sorta di “sound clash” che organizzavano ogni mese: «è stata la mia prima esperienza di sound system dal vivo. Da lì ho iniziato a scavare, a fare attenzione alla musica che si suonava intorno a me».
Nato in Giamaica come collettivo di dj, tecnici e musicisti attorno a potenti impianti audio, il sound system è diventato un fenomeno culturale globale, capace di trasformare ogni spazio in un evento musicale esplosivo. Per Joe, jazz accademico e sound system conviviali erano due entità separate «poi ho iniziato a cercare di unire, di far incontrare i due mondi. Spesso, quando suono dal vivo con la mia band, porto un sound system e noleggio un sound system locale, diventa un lavoro di squadra». Ci ricorda che il jazz americano ha avuto un enorme impatto sulla nascita del reggae in Giamaica. A sua volta, il reggae ha influenzato lo sviluppo dell’hip hop negli Stati Uniti: uno scambio continuo. Alcuni musicisti e dj giamaicani emigrati nel Bronx portarono l’idea di togliere la parte vocale dai brani e utilizzare le versioni strumentali come base per creare qualcosa di nuovo, un approccio che diede origine all’hip hop, così come altri sperimentavano campionando i “funk breaks”. «Trovo affascinante osservare come le correnti musicali si siano influenzate reciprocamente, viaggiando avanti e indietro attraverso l’Atlantico».

La scommessa dello studio
In passato scriveva da solo, al pianoforte o alla tastiera. Adesso che dispone di uno spazio suo, annesso a casa, il processo si è fatto collaborativo: «Negli ultimi due anni mi sono dedicato di più al mix, alla produzione e all’ingegneria del suono. Questo studio è un modo per riunire tutta la squadra. Quando ho tempo, invito gente a casa, passiamo tempo insieme e ascoltiamo musica, come ai tempi del college quando ci si ritrovava nei dormitori per condividere nuove tracce». Di conseguenza, anche i live sono meno rigidi rispetto a un tempo: non c’è una scaletta fissa né un programma prestabilito di ciò che accadrà in scena. «Quando lasci spazio all’improvvisazione e l’ispirazione arriva, possono nascere momenti straordinari, ma può essere un’arma a doppio taglio. Se sono circondato da musicisti amici, che rispetto, riusciamo ad instaurare un dialogo, a giocare sulle rispettive intuizioni e creare qualcosa di nuovo ogni sera. Tutto ciò richiede fiducia».
È fondamentale che tutti sul palco si divertano e possano esprimersi liberamente. Quando succede, il pubblico lo percepisce, è in quel momento che l’esperienza diventa viva, irripetibile. «Lo stile di vita in tournée è faticoso, poco salutare; cerco di farlo finché mi diverte. È come se ti chiudessi in una stanza con qualcuno per dieci mesi senza mai uscire: per quanto quella persona possa essere fantastica, prima o poi inizieresti a irritarti. Prima che succeda, preferisco tornare a casa, ricaricare le energie e ripartire da lì».
L’avrete intuito, il suo posto preferito in assoluto è lo studio: «è il meglio di entrambi i mondi: facciamo musica, sperimentiamo, ci rilassiamo ascoltando dischi. E penso che questo sia un altro punto importante: una volta il lavoro in studio era molto più collettivo. Quando lavori da solo, la musica tende a diventare più introspettiva. Penso ad artisti come Jai Paul: il suo album, è il suono di una persona isolata nella propria stanza. Non ha nulla dell’energia di un lavoro collettivo, eppure è uno dei dischi migliori mai realizzati. Non ci sono regole: ma puoi sentire la differenza tra un album creato da un gruppo e uno nato in solitudine. Lo percepisci in tutti i lavori di Dave Grusin, ad esempio: non è mai il frutto di un’unica mente, dietro ci sono tecnici, produttori, un’intera squadra. È quest’aspetto comunitario della musica che mi tocca, lo stesso spirito che si respira nei sound system: non esisterebbero senza le persone che li montano, che trasportano le casse nel locale, che fanno il soundcheck, che gestiscono il microfono. Ognuno ha un ruolo, ed è questo a rendere il tutto speciale».

Joe e l’Italia
Joe non ha ancora prodotto nessun artista italiano, eppure le affinità con il Belpaese non mancano: «L’Italia è uno dei paesi che ancora oggi tiene viva la fiaccola delle sound system culture, costruendoci attorno una scena attiva e un’infrastruttura. Paolo Baldini è un produttore che ha remixato e pubblicato molti brani di Barry Brown. Ho usato il suo album come riferimento per molto tempo. È rarissimo trovare qualcuno che remixi i nastri degli anni Settanta con tanto rispetto per il suono originale, senza modernizzarlo in modo fastidioso».
La playlist di Joe Armon-Jones per Linkiesta Etc
Una selezione curata di sonorità morbide, trascinanti che ti fanno sentire a casa e allo stesso tempo lasciano spazio all’improvvisazione. Traccia dopo traccia, Joe ci prende per mano e ci guida alla (ri)scoperta dei grandi maestri con cui è cresciuto, quelli che ascoltavano i suoi genitori, da Dave Grusin a Shuggie Otis, passando per Daryl Hall & Jones Oates e Bob James. Se da bambino non gli dava troppa importanza, è negli ultimi tempi che è tornato ad apprezzarli a pieno, fino ad ispirarsene. Un tuffo auditivo che ci proietta nelle atmosfere avvolgenti a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, da ascoltare con rispetto. Verso la fine, si scova qualche chicca più recente, come l’imperdibile Thousand Knives di Ryuichi Sakamoto e Kazumi Watanabe o Take It della promettente KeiyaA.
L'articolo La musica di squadra di Joe Armon-Jones proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0


.JPG)






























![Mondiale Rally. LIVE! Ecco la Ypsilon Rally2 HF Integrale [VIDEO]](https://img.stcrm.it/images/47903459/1200x/lancia-ypsilon-hf-integrale-2.jpg)

















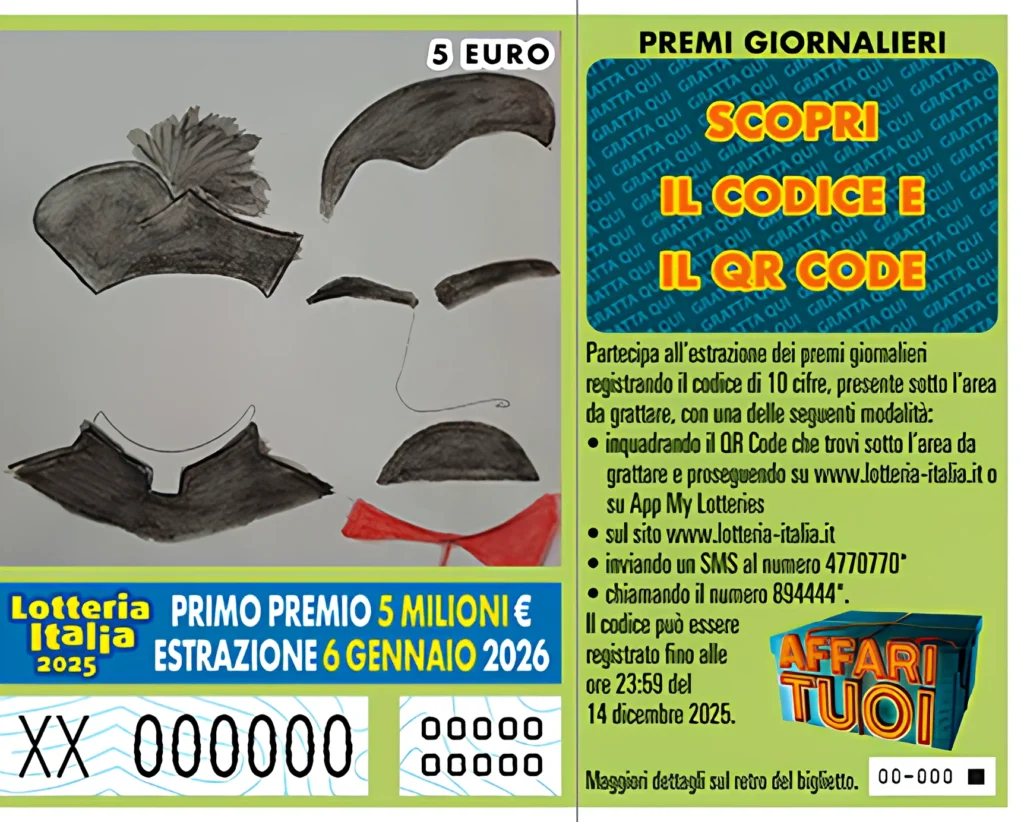































/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/11/trade-republic-conto-canone-zero-offre-2-percento-liquidita.jpg)










































-1763460323776.jpg--notte_di_fiamme_.jpg?1763460324357#)
-1763460821538.jpg--80enne_travolto_.jpg?1763460821629#)
-1763461248553.jpg--bimba_di_due_anni.jpg?1763461248680#)
-1738753258000.jpg--due_incidenti_sul_lavoro_nell_alessandrino__elettricista_schiacciato_da_un_quadro_e_operaio_ustionato.jpg?1738753258046#)





























































-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)






















































