L’energia è la lente per leggere l’intera storia del Novecento italiano


C’è un filo invisibile che attraversa l’Italia del Novecento e arriva fino ai nostri giorni: è l’energia, linfa vitale della nostra economia. È la luce che torna nelle case dopo la guerra, il bagliore dei pozzi dell’Agip, il lampo delle insegne al neon del boom economico, il buio improvviso dei blackout e delle crisi petrolifere, fino alla luminosità più tenue e incerta della transizione verde.
Questa è la trama di “Un secolo di energia in Italia”, un podcast di “Equilibri Magazine” tratto da “Super!”, il libro con cui Alessandro Lanza — economista, docente e per anni analista delle politiche energetiche italiane — intreccia la storia dell’energia con economia, politica e società (Luiss University Press, 2025).
Il podcast è un racconto, quasi un romanzo di formazione collettivo, in cui il protagonista è un Paese intero che si accende, si spegne, si reinventa. I testi sono a cura di Veronica Ronchi e Andrea Bellati, la voce e l’adattamento audio di Davide Gorla.
Questo viaggio sonoro copre settant’anni cruciali, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino al 2020. Nonostante questo limite temporale, il racconto affonda le radici in un secolo intero. Dopotutto, se dovessimo riassumere il XX secolo in due parole, citando Hobsbawm, lo caratterizzeremmo come il “secolo del petrolio”.
Si viene trascinati nel vivo della discussione cronologica che si focalizza sulla domanda e l’offerta di energia, sulle politiche energetiche governative e sulle opportunità mancate. Vi stupirà, per esempio, scoprire come persino un ammiraglio americano di alto rango, interpellato su cosa servisse per vincere la Seconda guerra mondiale, rispondesse seccamente: “Oil, bullets and beans” (Petrolio, pallottole e fagioli), evidenziando il ruolo cruciale dei carburanti che avrebbe poi aumentato il suo peso nella storia.
Il punto di partenza: l’energia come chiave di lettura della storia
“Un secolo di energia in Italia” apre con una premessa sorprendente: l’energia non è solo una questione tecnica o industriale – è una lente per leggere l’intera storia del Novecento. È il motore che fa muovere l’economia, ma anche la materia prima del potere, della diplomazia, della guerra e perfino della cultura.
Dalle battute iniziali emerge un’Italia che si misura con la modernità attraverso il petrolio, il gas, l’elettricità e — più recentemente — il carbonio e il sole. Seguendo il “filo rosso” dell’energia, il podcast attraversa i grandi snodi della nostra storia contemporanea: dalla ricostruzione postbellica alla nascita dell’Eni, dalla nazionalizzazione dell’Enel alla crisi del 1973, dalle privatizzazioni degli anni Novanta fino agli accordi di Parigi e alla Cop28. È, in fondo, un viaggio nella coscienza energetica del Paese, tra successi, illusioni e scelte mancate.
L’età della speranza (1945–1962)
Tutto comincia nel dopoguerra, in un Paese devastato ma vitale. L’Italia del 1945 è povera di tutto, tranne che di ingegno. L’economia a pezzi, ma la classe dirigente vede nuove prospettive per costruire un’identità industriale e nazionale.
In questa cornice prende forma la figura di Enrico Mattei, imprenditore, politico, visionario. Sotto la sua guida, l’Agip — nata nel 1926 e in odore di dismissione— diventa il simbolo di una sfida epica: liberare l’Italia dalla dipendenza energetica e sfidare le “Sette Sorelle”, le grandi compagnie petrolifere angloamericane.
Si racconta con precisione e passione il modo in cui Mattei trasformò l’energia in un progetto politico e morale. Non si trattava solo di trivellare pozzi, ma di affermare la dignità del Paese. Dall’accordo con l’Iran del 1957 alle trattative con l’Unione Sovietica, la sua azione era un intreccio di pragmatismo e coraggio. La sua morte, nel 1962, in un misterioso incidente aereo che ancora oggi porta con sé ombre e sospetti, segna la fine di un uomo e l’inizio del mito: Mattei come Prometeo moderno, che portò il fuoco all’Italia e ne pagò il prezzo.
L’età dello sviluppo (1962–1973)
Nel boom economico l’energia è ovunque: nelle case che si riempiono di frigoriferi e lavatrici, nelle fabbriche che producono automobili e sogni, nei treni che corrono verso il Nord industriale. Nel 1962 nasce l’Enel, con la nazionalizzazione delle imprese elettriche.
Questa scelta — oggi spesso dimenticata — fu una delle più rivoluzionarie della storia repubblicana: non solo un atto economico, ma un’idea di democrazia industriale, che portò la luce dove prima regnava il buio. In queste parole si respira l’ottimismo del tempo: tutto sembra possibile, e l’energia è sinonimo di progresso. È un’epoca che corre veloce, forse troppo.
L’età della crisi (1973–1989)
Poi, all’improvviso, il buio. Ottobre 1973: la guerra del Kippur, l’embargo OPEC, il prezzo del petrolio che quadruplica. L’Italia, che importa quasi tutta la sua energia, entra nella crisi più profonda dal dopoguerra. Vengono dipinti con tratti vividi quei momenti: le domeniche senza auto, le luci spente nei negozi, le famiglie riunite davanti alla televisione che chiudeva alle 23.
Era un esperimento di sobrietà forzata, ma anche un risveglio collettivo: per la prima volta gli italiani capivano che l’energia non era infinita, e che il benessere aveva un prezzo. Il testo dedica spazio anche al nucleare italiano — dalle centrali di Caorso e Trino alla tragedia di Černobyl’ e al referendum del 1987 che decretò la fine del programma. Dietro la tecnica si intravede la psicologia di un Paese diviso tra paura e progresso, modernità e diffidenza. La lezione di quegli anni? Che l’energia è sempre politica, e che ogni lampadina accesa porta con sé una scelta collettiva.
Privatizzazioni e liberalizzazioni (1990–2000)
Gli anni Novanta segnano un’altra svolta. Mentre l’Italia cambia volto con Tangentopoli, Maastricht e la globalizzazione, il settore energetico si apre al mercato. Ecco le grandi privatizzazioni: Eni ed Enel diventano società per azioni, lo Stato riduce la propria presenza, arrivano nuovi attori e nuove regole.
Da un lato l’efficienza e l’apertura internazionale, dall’altro la perdita di un legame identitario con due simboli del Novecento italiano. L’energia smette di essere patrimonio pubblico e diventa bene di mercato. È il segno dei tempi: la globalizzazione entra nelle bollette, e l’Italia deve imparare a competere in un mondo dove la risorsa chiave non è più solo il petrolio, ma l’informazione e la finanza.
Non più solo Italia (2000–oggi)
Nel nuovo millennio la scena si allarga: il cambiamento climatico entra nel linguaggio politico e quotidiano. Dagli accordi di Kyoto a quelli di Parigi, da Glasgow a Dubai, l’energia è diventata terreno di cooperazione e conflitto globale. L’Italia partecipa con alterna convinzione alla corsa verso la decarbonizzazione. Dalla crescita delle rinnovabili al ritorno del gas, dalla dipendenza dalle importazioni alla crisi del 2022, il nostro Paese continua a muoversi tra prudenza e innovazione. Ma c’è un filo di speranza: la consapevolezza che la vera transizione non è solo tecnologica, ma culturale. Cambiare il modo in cui produciamo energia significa cambiare il modo in cui viviamo, consumiamo, pensiamo il futuro.
Il podcast
“Un secolo di energia in Italia” è un ponte tra passato e futuro, tra i fumi dell’industria e le pale eoliche che disegnano i paesaggi del presente. Il suo merito è di rendere accessibile un tema relegato agli esperti, mostrando che dietro ogni interruttore, ogni pompa di benzina, ogni politica climatica, c’è una storia di uomini, idee e scelte morali.
Emergono le voci dimenticate: quella dei minatori lucani che sognavano il petrolio italiano, dei tecnici di Caorso che credevano nel nucleare civile, delle famiglie che negli anni Settanta accendevano la televisione alle 20 perché “l’austerity chiudeva tutto prima”.
In un panorama mediatico dove l’energia è spesso ridotta a cifre, grafici e polemiche politiche, “Un secolo di energia in Italia” le restituisce una dimensione narrativa e culturale. Centrale è sicuramente la possibilità di riscoprire che la storia energetica dell’Italia è anche una storia di ambizioni e paure, di progresso e fragilità, e che le scelte di ieri continuano a plasmare il nostro presente.
“Un secolo di energia in Italia” non è un podcast tecnico né la semplice trasposizione di un libro. È un percorso per l’ascoltatore interessato a comprendere le dinamiche alla base del nostro agire economico. È la prova che anche i temi più complessi – la geopolitica del petrolio, la liberalizzazione dei mercati, la crisi climatica – possono diventare storie vive, emozionanti e comprensibili.
Questo viaggio si chiude con una riflessione: l’energia non è soltanto ciò che ci fa muovere, ma ciò che ci definisce. In un tempo in cui l’energia è di nuovo al centro della scena – tra transizione verde, guerre e innovazioni – comprendere la sua evoluzione significa capire il nostro sistema Paese. E che la vera forza, oggi come ieri, è quella di accendere la conoscenza.
L'articolo L’energia è la lente per leggere l’intera storia del Novecento italiano proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0
































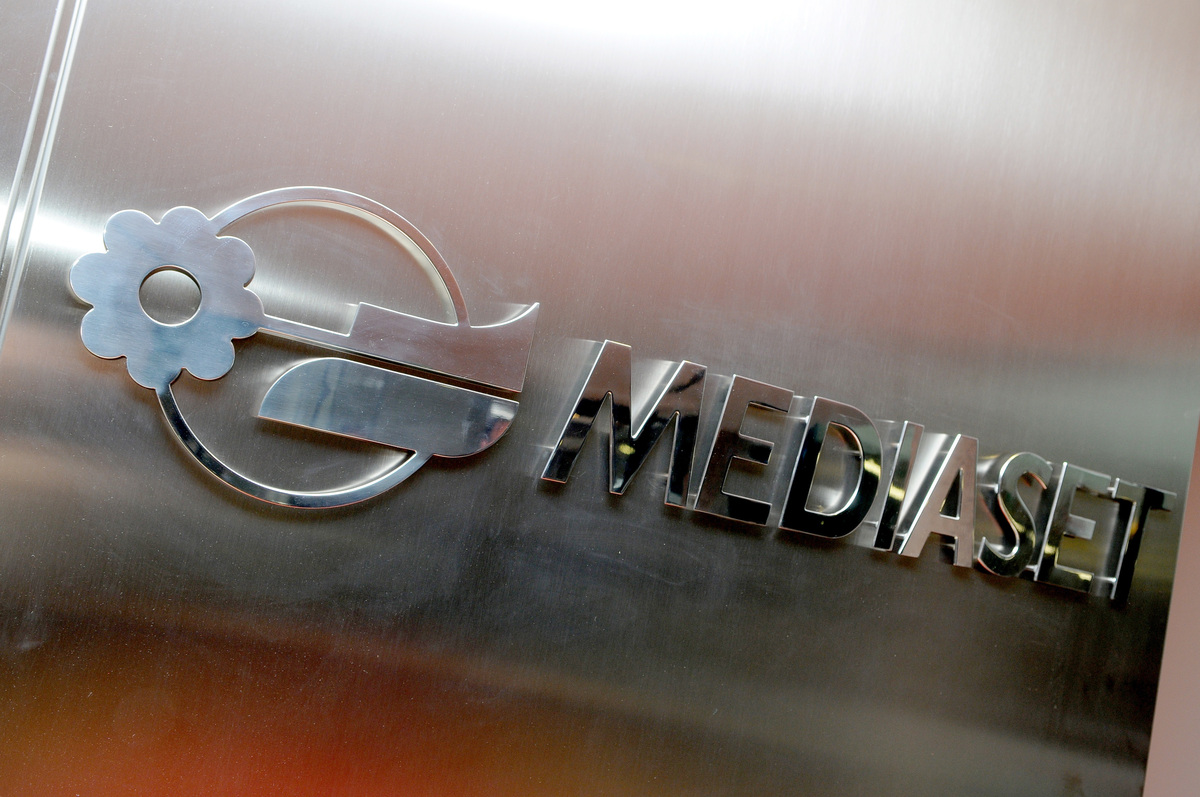


















































/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/11/trade-republic-conto-canone-zero-offre-2-percento-liquidita.jpg)
























































































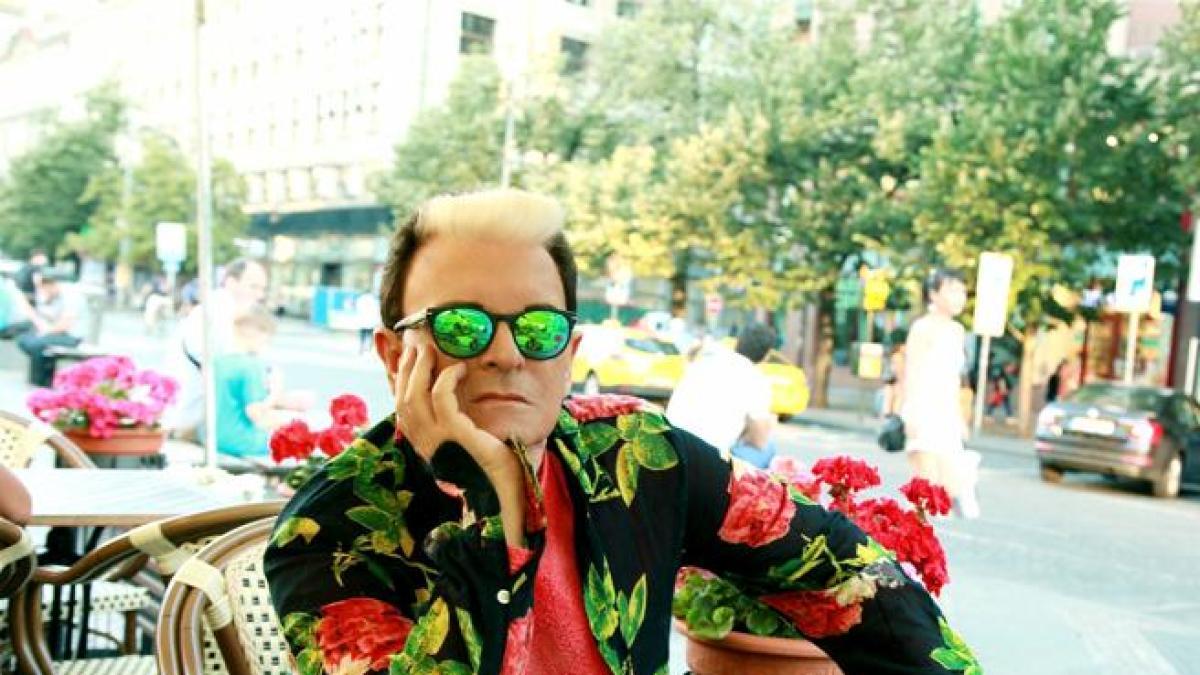

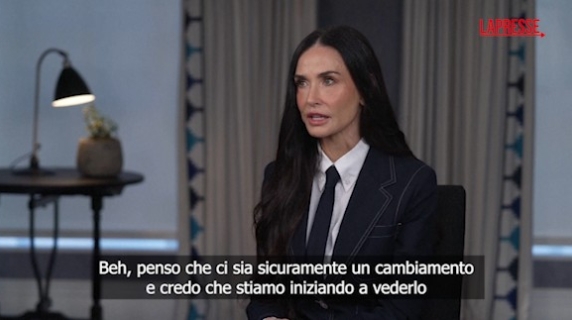




















-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)























































