Il mondo agricolo è entrato in zona rossa


Il mondo agricolo dei nostri giorni assomiglia sempre più a una mappa sismica: fratture visibili, scosse continue, epicentri che si spostano da un continente all’altro. Nessuna area del pianeta può dirsi davvero stabile. L’Europa fatica tra scelte politiche controverse e redditività in caduta; le Americhe convivono con la distanza siderale tra superpotenze esportatrici e territori travolti dagli eventi climatici; l’Asia cresce veloce ma costruisce equilibri sempre più fragili. È un paesaggio globale che cambia a scatti, spesso senza preavviso. E il risultato, oggi, è sotto gli occhi di tutti: il futuro del cibo è diventato uno dei campi di battaglia del mondo che verrà.
Europa, un continente che fatica a tenere il passo
In Europa la stabilità agricola si indebolisce per ragioni diverse ma strettamente intrecciate. Il caso francese lo rende evidente. La decisione del governo di riaprire alla possibilità dell’accordo commerciale Ue–Mercosur – l’intesa che ridurrebbe le barriere all’ingresso di prodotti agricoli provenienti da Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay — ha riacceso un malessere profondo nelle campagne. Come segnala Le Monde, molti produttori vi hanno letto un messaggio preciso: mentre loro sostengono costi crescenti e standard sempre più rigorosi, l’Europa valuta l’ingresso di merci sudamericane molto più competitive sul piano dei prezzi.
Le analisi del Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea chiariscono la sensibilità del tema. Un accordo Ue–Mercosur nelle forme ipotizzate potrebbe aumentare le importazioni di carne bovina europea nell’ordine del 25–35 per cento, a seconda dello scenario. Non si tratta di un dettaglio tecnico. Significa che volumi consistenti di carne prodotta con regole meno onerose arriverebbero sul mercato europeo a prezzi con cui gli allevatori francesi – e molti altri nel continente – difficilmente potrebbero competere. Non stupisce che la “sovranità alimentare” sia diventata uno dei temi più controversi nei tavoli politici di Bruxelles.
In Spagna la criticità ha un’altra radice: il clima. Il rilancio dei premi dedicati ai migliori oli extravergine non è solo una celebrazione dell’eccellenza nazionale, ma un tentativo di dare ossigeno a una filiera che esce da due anni durissimi. La siccità prolungata che ha colpito la Penisola Iberica – documentata dall’AEMET (Agenzia Meteorologica Statale spagnola) nei suoi rapporti sullo stato climatico – ha inciso in modo diretto sulle rese dell’olivicoltura. Secondo il Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) e le principali organizzazioni del settore, la campagna 2022–2023 ha registrato una riduzione produttiva stimata intorno al 40-50 per cento, con livelli rimasti sotto la media anche nella stagione successiva. Quando una filiera perde quasi metà del proprio raccolto, l’impatto non riguarda solo la disponibilità di olio: si assottigliano i margini delle aziende, aumenta la volatilità dei prezzi e si riduce la capacità di programmare investimenti. Nel frattempo, Paesi come Tunisia e Turchia consolidano la loro presenza sui mercati internazionali, aggiungendo ulteriore pressione competitiva al Mediterraneo europeo.
Il Regno Unito mostra invece cosa accade quando viene meno una rete di protezione economica. Secondo il primo Farmdex Report riportato dal Guardian, circa un agricoltore su tre ha chiuso l’ultimo anno senza profitti, e il 61 per cento segnala un impatto negativo sulla propria salute mentale. I dati del Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFR) indicano che tra il 2021 e il 2022 i costi principali per gli agricoltori sono aumentati in modo drammatico: l’energia ha registrato un +48 per cento e i fertilizzanti un +78 per cento. Con la fine dei pagamenti diretti della Politica Agricola Comune e un nuovo schema ambientale – l’Environmental Land Management (ELM) – ancora in fase di rodaggio, anche le aziende più strutturate si ritrovano ad assorbire costi in aumento senza la garanzia di un sostegno adeguato.
Messi insieme, questi segnali compongono un quadro coerente. L’agricoltura europea non è in difficoltà per una sola ragione, ma per l’effetto combinato di pressioni politiche, climatiche ed economiche che agiscono simultaneamente. I dati confermano la tendenza: secondo Eurostat, il numero di aziende agricole nell’Unione è diminuito di circa il 6 per cento negli ultimi anni, mentre le proiezioni dell’OECD–FAO Agricultural Outlook indicano una progressiva erosione della redditività reale per ettaro, legata all’aumento dei costi di produzione, alla pressione climatica e alla stagnazione dei prezzi agricoli. Accanto alla pressione sui conti, pesa una frattura demografica sempre più evidente. Secondo COPA–COGECA l’età media degli agricoltori europei è di 57 anni, e solo il 12 per cento ha meno di 40 anni. È un dato che va oltre il contingente e segnala un futuro che rischia di non avere chi lo costruirà. L’Europa resta un polo produttivo avanzato, ma la sua base agricola si restringe, invecchia e potrebbe non avere più ricambio. Senza giovani – e senza accesso alla terra, redditi sostenibili e politiche che rendano l’agricoltura una scelta possibile – anche le filiere più forti perderanno continuità. È una crepa silenziosa, forse la più difficile da riparare.
Americhe, una potenza agricola sotto pressione
Nelle Americhe invece si concentra una delle maggiori capacità produttive del pianeta, ma è anche qui che si manifestano alcuni dei punti di rottura più evidenti del sistema agricolo globale. Dal Sud America agli Stati Uniti fino ai Caraibi, tre fattori si sovrappongono: clima estremo, tensioni commerciali e instabilità macroeconomica.
In Sud America il quadro è duplice. Il Brasile rimane un campione mondiale: primo esportatore di soia e tra i leader per mais, zucchero, agrumi e carne bovina. Nel 2025 le spedizioni di soia dovrebbero superare i 100 milioni di tonnellate, sostenute da un raccolto vicino ai 170 milioni e dalla domanda cinese. Ma la crescita ha un costo ambientale rilevante. I dati dell’istituto nazionale di ricerca spaziale e le analisi del Joint Research Centre mostrano che l’espansione agricola e zootecnica – in particolare soia e allevamento bovino – è uno dei principali motori della deforestazione amazzonica, un processo che, come ricorda la World Bank, riduce la capacità del territorio di affrontare siccità, incendi ed erosione dei suoli. È un modello produttivo che garantisce volumi elevati, ma che espone il Paese a rischi climatici sempre più frequenti.
L’Argentina segue una traiettoria diversa. La siccità del 2022–2023, indicata dalla Borsa di Buenos Aires come una delle peggiori degli ultimi decenni, ha falcidiato i raccolti: la soia è crollata del 50 per cento, scendendo a 21 milioni di tonnellate (Buenos Aires Times), mentre per il mais la produzione è stata inferiore del 30 per cento rispetto alle previsioni iniziali con perdite economiche fino a circa 20 miliardi di dollari, tra minori rese e mancati introiti dall’export (Reuters). A questo poi, si aggiunge un contesto economico complesso: la Commissione economica per l’America Latina e i Caraibi (ECLAC) registra inflazione molto alta, difficoltà di accesso al credito e scarsità di valuta per importare fertilizzanti e macchinari. È un Paese che potrebbe produrre di più, ma che è frenato da problemi strutturali che vanno oltre l’agricoltura.
Negli Stati Uniti, invece, il nodo principale è la combinazione fra clima e geopolitica. La NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ha registrato, nel 2023, ventotto eventi meteorologici estremi con danni superiori al miliardo di dollari ciascuno; oltre 21 miliardi riguardano direttamente raccolti e pascoli. Al peso del clima si aggiunge la guerra commerciale con la Cina. L’inchiesta di Al Jazeera mostra come il Midwest abbia perso il suo principale mercato estero: prima dei dazi incrociati Pechino acquistava più di 30 milioni di tonnellate di soia statunitense ogni anno, oggi gli acquisti sono scesi sotto i 10 milioni mentre il Brasile copre quote superiori all’80 per cento. Per molte aziende agricole la conseguenza è immediata: contratti annullati, redditi più instabili e una dipendenza crescente dagli aiuti federali.
Nel Centro America e nei Caraibi, gli uragani continuano a determinare il destino di intere stagioni agricole. Melissa, tempesta di categoria 5, ha colpito non solo la Giamaica ma anche Haiti, la Repubblica Dominicana e parte di Cuba. La FAO e la CDEMA (Caribbean Disaster Emergency Management Agency) stimano danni estesi a coltivazioni, strade rurali e sistemi idrici; in alcune aree giamaicane si raggiunge fino al settanta per cento delle colture distrutte. Secondo il network World Weather Attribution, l’intensità della tempesta è stata amplificata dal riscaldamento degli oceani. Per questi Paesi, ogni uragano non rappresenta un evento eccezionale ma una sfida ricorrente che mina produzione e sicurezza alimentare.
Considerate insieme, queste dinamiche mostrano un continente che continua a garantire volumi elevati, ma che deve fare i conti con fattori esterni sempre più difficili da gestire. Il potenziale produttivo resta enorme, ma la stabilità dei sistemi agricoli risulta meno solida di quanto suggeriscano i numeri dell’export. Le Americhe sono ancora un pilastro del mercato globale, ma sono anche uno dei luoghi in cui gli shock climatici ed economici producono gli effetti più immediati.
Asia e Oceania, terre che cambiano più in fretta di chi le coltiva
In Asia il cambiamento agricolo non procede per scosse isolate, ma per trasformazioni continue che alterano la terra, l’acqua e la presenza stessa degli agricoltori. È il continente dove più chiaramente si vede cosa significa coltivare in un ambiente che cambia più velocemente della capacità di adattamento.
Il Giappone è il caso più netto di erosione rurale. Secondo i dati del MAFP, il Ministero dell’Agricoltura, delle Foreste e della Pesca, riportati da Nippon la superficie coltivata si è ridotta di oltre il 30 per cento dagli anni Sessanta e gli agricoltori principali sono scesi da 2,4 milioni nel 2000 a circa 1,1 milioni nel 2024. L’età media sfiora i 70 anni. A questa dinamica demografica si aggiunge la pressione climatica: le ondate di caldo del 2023 e 2024 hanno danneggiato frutta e ortaggi, con ustioni sui pomodori, rese irregolari e cicli vegetativi alterati in più prefetture. Il risultato è un’agricoltura che non crolla, ma si assottiglia anno dopo anno.
Nel Sudest asiatico la pressione più evidente riguarda l’acqua. Nel delta del Mekong, il “granaio di riso” del Vietnam, l’innalzamento del mare si combina con la subsidenza dovuta all’eccessiva estrazione di falda. Le Monde descrive una regione in cui il terreno si abbassa di diversi millimetri l’anno, in alcune aree a un ritmo superiore allo stesso innalzamento del mare. Le infiltrazioni saline risalgono i canali e la stagione delle piene è sempre più irregolare, costringendo gli agricoltori a diversificare: riso nella stagione delle piogge, prodotti ittici o frutta tropicale in quella secca. Il delta fornisce oltre la metà del riso consumato nel Paese, ma tra subsidenza, salinità e pressione demografica vaste aree rischiano di perdere la propria vocazione agricola entro pochi decenni.
Anche nel resto della regione lo stress idrico è un dato strutturale. La FAO stima che il 90 per cento dell’acqua dolce dell’Asia-Pacifico sia assorbito dall’agricoltura e che oltre l’80 per cento dei Paesi conviva già con livelli da moderati a severi di scarsità idrica. In Indonesia, Thailandia e Filippine, gli episodi di caldo e le precipitazioni estreme colpiscono soprattutto i piccoli agricoltori, che coltivano appezzamenti inferiori ai due ettari ma garantiscono una parte essenziale dell’alimentazione locale (IFAD).
Non mancano successi, ma anche questi rivelano fragilità. Il South China Morning Post racconta il boom del durian vietnamita dopo l’apertura del mercato cinese nel 2022: alcuni produttori guadagnano fino a 30.000 dollari per ettaro, e la richiesta di Pechino ha spinto molti agricoltori degli Altipiani Centrali a riconvertire piantagioni di caffè e pepe in durian. L’export ha superato i 3,3 miliardi di dollari nel 2024 e raggiunto 2,7 miliardi nei primi nove mesi del 2025 (VietnamNet). Quando nel 2025 Pechino ha irrigidito i controlli sui residui chimici, parte dei carichi è rimasta bloccata alle dogane e i produttori più indebitati hanno subito perdite immediate. È il limite dei modelli monocolturali orientati all’export: basta un controllo in più per mettere a rischio un intero distretto agricolo.
L’Oceania chiude il quadro con un’altra forma di incertezza. L’Australia alterna siccità prolungate e stagioni di piogge violente legate ai cicli di El Niño e La Niña. Il State of the Climate Report del CSIRO, l’agenzia scientifica nazionale, registra un riscaldamento superiore alla media globale e una riduzione costante dell’umidità dei suoli nelle regioni agricole. Le rese di grano e orzo oscillano in modo sempre più imprevedibile. Anche la Nuova Zelanda ha subito negli ultimi anni fenomeni estremi, come il ciclone Gabrielle del 2023, che ha danneggiato migliaia di aziende agricole e infrastrutture rurali essenziali.
Messe insieme, queste dinamiche delineano un continente in trasformazione profonda. Il Giappone perde agricoltori e superfici coltivate, il Vietnam rischia parte delle sue terre più fertili, il Sudest asiatico nel complesso affronta una crisi idrica che cambia la geografia agricola e l’Oceania vive stagioni sempre più instabili. Nel mezzo ci sono milioni di piccoli produttori che tengono in piedi interi sistemi alimentari, ma con margini di adattamento sempre più ridotti.
Dopo aver attraversato Europa, Americhe, Asia e persino il Pacifico, la sensazione è la stessa: l’agricoltura non è più un settore che segue il ritmo delle stagioni, ma uno che deve inseguire trasformazioni continue. Cambia la geografia, cambiano i raccolti, cambiano le persone. In alcuni luoghi la terra si svuota, in altri si trasforma, in altri ancora è il mercato a spostare l’ago della bilancia da un giorno all’altro.
Non esiste una soluzione unica, ma una certezza sì: il modo in cui i Paesi sapranno proteggere il loro sistema agricolo – l’acqua, i suoli, i piccoli produttori, le conoscenze – determinerà non solo cosa mangeremo, ma chi potrà continuare a coltivare. E se il mondo che arriva sarà più stabile o più fragile di quello che abbiamo lasciato alle spalle.
L'articolo Il mondo agricolo è entrato in zona rossa proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0


.JPG)






























![Mondiale Rally. LIVE! Ecco la Ypsilon Rally2 HF Integrale [VIDEO]](https://img.stcrm.it/images/47903459/1200x/lancia-ypsilon-hf-integrale-2.jpg)

























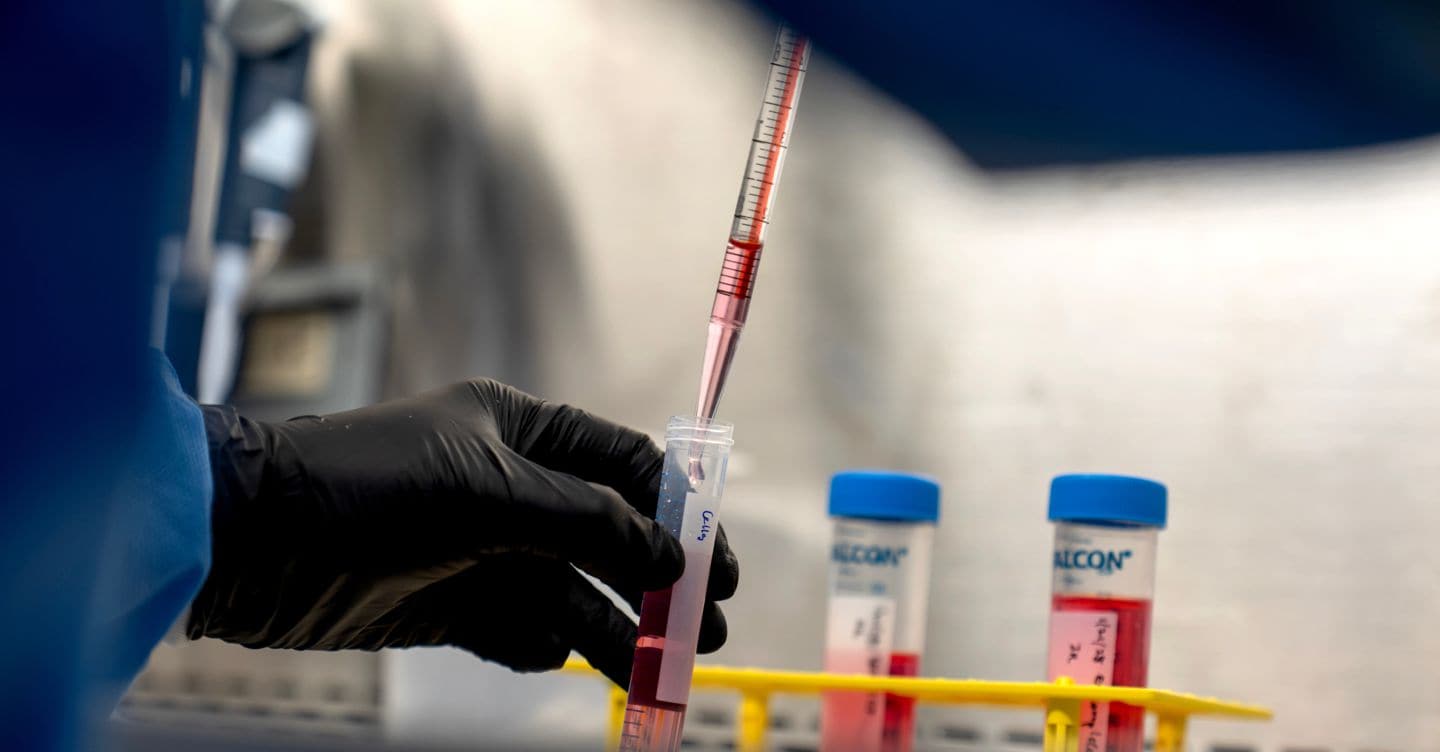























/https://www.finanza.com/app/uploads/2025/11/trade-republic-conto-canone-zero-offre-2-percento-liquidita.jpg)










































-1763460323776.jpg--notte_di_fiamme_.jpg?1763460324357#)
-1763460821538.jpg--80enne_travolto_.jpg?1763460821629#)
-1763461248553.jpg--bimba_di_due_anni.jpg?1763461248680#)
-1738753258000.jpg--due_incidenti_sul_lavoro_nell_alessandrino__elettricista_schiacciato_da_un_quadro_e_operaio_ustionato.jpg?1738753258046#)





























































-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)





















































