L’indipendenza della sinistra dall’Anm, e la separazione delle carriere tra politici e magistrati


La riforma costituzionale in materia di ordinamento giudiziario, il cui titolo pubblicistico di “separazione delle carriere dei magistrati” suona insieme parziale ed eccessivo, è in sé molto meno straordinaria di quanto l’accreditino i favorevoli nel bene e i contrari nel male.
Non è la cura miracolosa delle affezioni panpenalistiche del sistema giudiziario, per cui destra e sinistra hanno avuto in questi decenni uguali responsabilità, condividendo il concetto della legislazione penale come prosecuzione della lotta politica con altri mezzi, e l’idolatria del reato e della pena come principi supremi di giustizia e quindi come strumenti privilegiati di governo. Il diritto penale come igiene del mondo.
Questa riforma non è neppure un’effrazione eversiva del principio della separazione dei poteri, ma semmai un corollario, peraltro incompleto e ambiguo, del principio del giusto processo e dell’uguaglianza di difensore e inquirente davanti a un giudice terzo, stabiliti ormai trentasette anni fa con la riforma del codice di procedura penale e il passaggio dal sistema inquisitorio a quello accusatorio.
Certo, si può discutere di come avrebbe potuto essere e non è stata. Rispetto alla precedente proposta dell’Unione delle Camere Penali, la legge Meloni-Nordio ha qualcosa di più, qualcosa di meno e un evidente difetto di chiarezza.
In più c’è un’Alta Corte, comune per giudici e pm, chiamata a decidere sui procedimenti disciplinari. In meno c’è lo stralcio del tema, di straordinaria rilevanza, dell’obbligatorietà dell’azione penale e la mancata costituzionalizzazione del principio dei concorsi separati tra inquirenti e giudicanti, che è rinviato alle norme sull’ordinamento giudiziario, «le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti».
In base al combinato disposto degli articoli 102 e 104 della Costituzione, come modificati dalla legge di riforma, sarebbe teoricamente compatibile coi nuovi principi anche la disciplina Cartabia attualmente in vigore, che prevede un unico concorso e passerelle tra una carriera e l’altra limitatissime, ferma restando la separazione per pm e giudici, operata per via costituzionale. Più che della separazione delle carriere dei magistrati, che sono solo “distinte”, questa legge dispone una totale separatezza delle magistrature inquirente e giudicante e dei rispettivi organi di autogoverno.
È un elemento di ambiguità, che si aggiunge a quello, ancor più significativo, della modalità di sorteggio della componente togata dei due nuovi Csm, rinviate anch’esse alla legge ordinaria.
In assenza di principi cogenti, il legislatore potrebbe optare per un sorteggio puro, oppure per uno ristretto ai magistrati con una certa anzianità di servizio o che abbiano ricoperto incarichi direttivi, oppure anche per un sorteggio di secondo grado, su una platea selezionata per via elettiva, come è previsto per i membri laici o in base alle autocandidature dei potenziali aventi diritto.
La spiegazione malevola, ma realistica per tutte queste ambiguità, è che la maggioranza di governo si sia voluta tenere le mani libere per negoziare in seguito con la magistratura associata, in base a mutati rapporti di forza, e a possibili nuove alleanze con le destre giudiziarie, quanta e quale dose di “correntocrazia” ammettere nei nuovi Csm.
Proprio il sorteggio per la componente togata dei Csm e dell’Alta Corte disciplinare, che è l’istituto più rivoluzionario introdotto dalla riforma e il più simbolicamente rappresentativo del regime change anticorrentizio della magistratura, è anche quello che presenta i profili più problematici.
Questa soluzione, proposta dal ministro Alfonso Bonafede ai tempi del Governo Conte I, perfettamente coerente con “l’uno vale uno” dell’ideologia grillina e per anni avversata dalla gran parte dei suoi attuali sostenitori, ha il limite di risolvere il problema della degenerazione correntizia eludendo il problema, altrettanto grave, della responsabilità dei membri dell’organo di autogoverno e, a cascata, di quanti sono da essi assegnati o promossi a determinati incarichi.
D’altra parte, se l’interesse allo scardinamento delle correnti deve considerarsi prevalente su tutto, tirando il filo della “sorteggiocrazia” non si dovrebbe sostenere che anche gli incarichi direttivi degli uffici giudiziari dovrebbero essere assegnati dalla sorte, per impedire le degenerazioni correntizie o di altra e peggiore natura dei nuovi Csm selezionati dal caso?
Tutto ciò detto, le discussioni su come questa riforma potesse essere fatta o corretta oggi non hanno più alcun senso e occorre decidere se questa legge vada approvata o bocciata nel referendum confermativo in base a una valutazione onestamente relativistica. Ammessi e concessi dubbi e riserve sulla cultura della maggioranza, con questa legge si farà un passo indietro o avanti verso l’obiettivo, ancora lontanissimo, di un diritto penale liberale?
Il Presidente emerito della Corte Costituzionale Augusto Barbera – una lunga carriera prima nel Pci e poi nel Pds, prima di arrivare alla Consulta – si è incaricato di spiegare perché per la sinistra dire no è un errore e una contraddizione e pure un tradimento della sua storia primo-repubblicana. Non sono però solo ragioni giuridiche e dottrinarie che avrebbero dovuto consigliare alla sinistra una maggiore lucidità e prudenza.
Se la sinistra tutta non avesse scelto di sposare la piattaforma resistenziale dell’Anm e di continuare a seguire i cattivi maestri dell’azione penale purificatrice – da Piercamillo Davigo a Roberto Scarpinato e Nicola Gratteri – oggi si risparmierebbe l’illusione di una spallata referendaria contro il governo, che neppure un esito sfavorevole della consultazione renderà minoritario nel Paese, e soprattutto eviterebbe il pericolo di partire per sfasciare e arrivare sfasciata all’appuntamento con il voto, come è già successo con i referendum della Cgil.
Soprattutto, se la sinistra e il Partito democratico guardassero con lucidità alla storia del giustizialismo italiano e dei suoi successi scoprirebbero che i suoi beneficiari politici sono stati tutti e solo a destra, da Silvio Berlusconi in poi, e che il populismo penale si presta assai meno al virtue signaling progressista che al repressivismo reazionario, come hanno dimostrato in questa legislatura proprio il governo Meloni e il ministro Carlo Nordio col loro garantismo censuario e il loro razzismo di classe.
Invece, anche in questa occasione, la sinistra è rimasta esattamente dove sventuratamente si era messa trent’anni fa ai tempi di Mani Pulite, ad applaudire gli eroi della rivoluzione togata, a difenderne le pretese e le immunità corporative e a invocare la sopraintendenza giudiziaria della Repubblica.
Quindi il problema non è solo quello di dividere le carriere dei magistrati o – come diceva Massimo Bordin – di dividere quelle tra i magistrati e i giornalisti, ma anche, ancora più urgentemente, di separare la sinistra dall’Anm e le carriere dei politici da quelle dei magistrati, cosa che l’opposizione dovrebbe fare anche per difendersi dalla nuova santa alleanza che si annuncia tra la magistratura di destra e la politica di destra e che solo una cecità auto-imposta impedisce alla sinistra di vedere.
Ma ora siamo al referendum, ed è troppo tardi per ripensarci: e qualunque sia l’esito, potrebbe essere sfavorevole a un salutare ripensamento, per un programma davvero progressista in tema di giustizia.
L'articolo L’indipendenza della sinistra dall’Anm, e la separazione delle carriere tra politici e magistrati proviene da Linkiesta.it.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0

































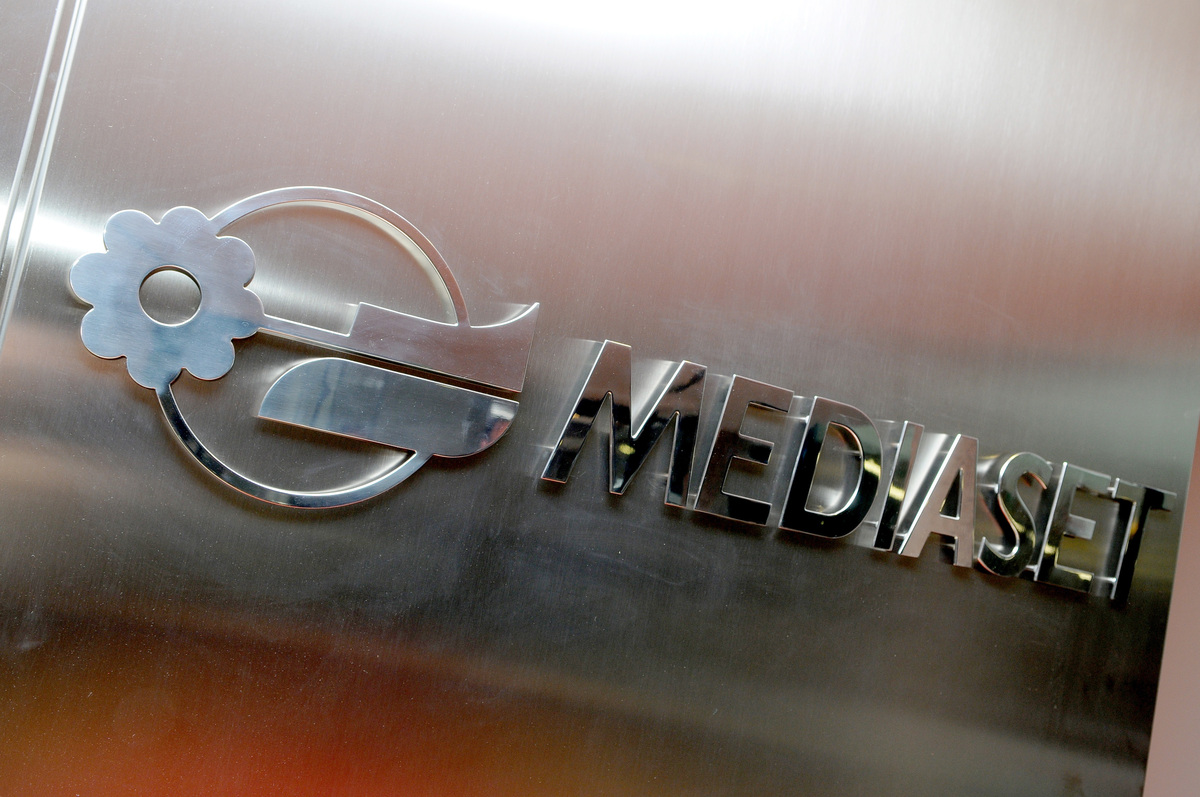























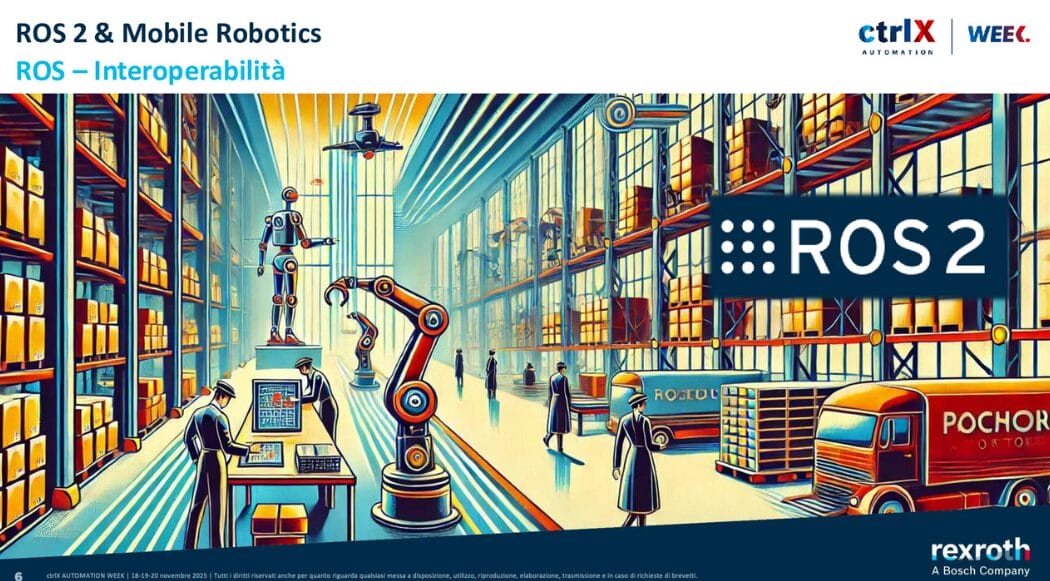











































































































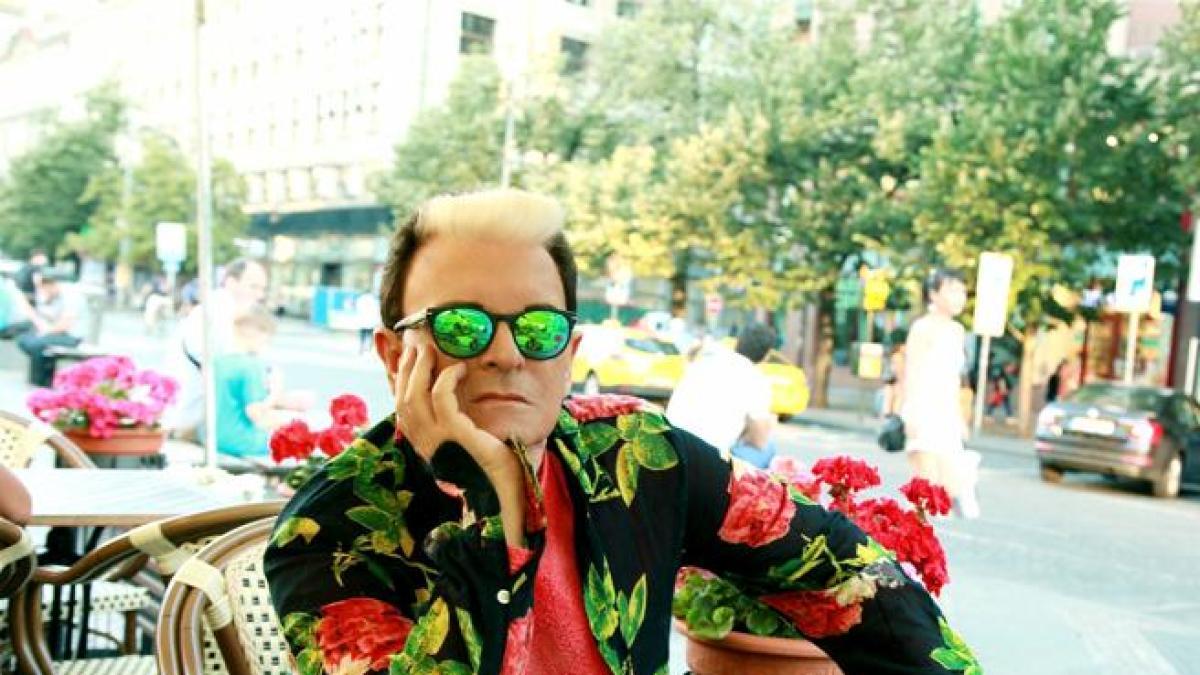

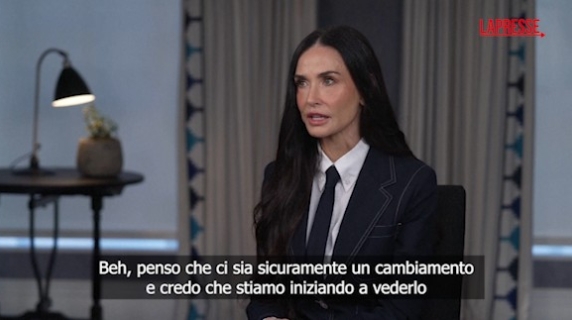




















-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)

























































