L’umano al bivio tra tecnica e libertà


Nel 1944 Georges Bernanos scriveva profeticamente che il vero pericolo non risiede nella moltiplicazione delle macchine, ma nel numero crescente di uomini che, fin dall’infanzia, non desiderano altro che ciò che le macchine possono dare. Una frase che illumina i rischi dei processi di digitalizzazione contemporanei: l’essere umano si fa sempre più macchina e la macchina si fa sempre più sapiens, e i due piani sono sempre meno distinguibili. È questo il cuore di Macchine celibi. Meccanizzare l’uomo o umanizzare il mondo? (Chiara Giaccardi, Mauro Magatti, Il Mulino, pp. 180, € 17), saggio che cerca di delineare la direzione di quella sapienza nuova necessaria per vivere le sfide del tempo: con tutta la loro complessità, che non sempre sappiamo comprendere e tantomeno governare.
Il titolo riprende un’opera enigmatica di Marcel Duchamp del 1915, Il grande vetro, che, con un secolo d’anticipo, coglie la condizione nella quale ci troviamo oggi. L’installazione surrealista divide l’opera in due parti: nella parte inferiore, nove uomini – i “celibi” – sono rappresentati da pistoni che si muovono in continuazione senza mai raggiungere lo scopo; nella parte superiore, la sposa rappresenta il desiderio irraggiungibile, continuamente frustrato.
La società contemporanea è esattamente questo: da una parte l’accelerazione continua che ci fa rincorrere un’esigenza sistemica di efficienza senza limite né compimento; dall’altra un desiderio individualizzato sfruttato da un tecnocapitalismo che incoraggia il rilascio delle pulsioni come energia di cui alimentarsi. Sono rischiose sia la demonizzazione sia la sacralizzazione acritica della rivoluzione digitale. Entrambe queste posizioni polarizzate sono dettate da un’emotività che impedisce di affrontare adeguatamente le sfide della digitalizzazione. La via più sensata, indicata da Platone e ripresa da Jacques Derrida e Bernard Stiegler, è considerare la tecnica come un “farmaco”: ha componente curativa e tossica, effetti di rimedio e veleno inseparabili. La questione non è dunque essere pro o contro la tecnologia, bensì capire potenzialità e tossicità per creare le condizioni per una “farmacologia positiva”, per un dispiegamento generativo della tecnica.
I processi in corso stanno modificando profondamente non solo il nostro agire, ma il profilo stesso della condizione umana. La digitalizzazione è il punto più avanzato del processo iniziato con la modernità. Dopo aver razionalizzato fabbriche, città, Stati e, infine, l’intero globo, ora abbiamo una tecnologia pervasiva reticolare che razionalizza ogni attività umana, sanità, educazione, relazioni, svago: nella società delle piattaforme tutto passa attraverso il codice digitale. Gli sviluppi dell’intelligenza artificiale generativa hanno poi portato alla perdita del monopolio sul linguaggio da parte dell’umano, mentre il corpo umano si integra sempre più nel sistema tecnico. La distanza tra uomo e macchina si riduce costantemente.
Oggi la razionalizzazione digitale risolleva con urgenza la questione della libertà. Siamo alla fine di una parabola cominciata nel Dopoguerra con la società dei consumi e proseguita con il Sessantotto e il mito dell’autorealizzazione. Ma oggi la crisi ambientale e quella sociale ci mostrano con chiarezza che non possiamo più pensarci “a prescindere”. Anche perché, come individui, siamo molto più vulnerabili alle pressioni della megamacchina digitale e alle sue richieste di performance, velocità, ottimizzazione che alla fine rischiano di schiacciarci.
C’è poi la questione geopolitica. Negli ultimi quarant’anni la modernità si è estesa alle aree non occidentali, in primis la Cina. La globalizzazione ha integrato il pianeta intero. Pensavamo che tecnologia ed economia avrebbero creato un mondo di pace, ma la questione geopolitica si ripropone in termini nuovi. Il confronto tra Occidente e Oriente si gioca sul dominio della tecnologia digitale e dell’intelligenza artificiale, attraverso conoscenza scientifica, produzione di chip e disponibilità di materie prime.
Meccanizzare l’umano o umanizzare il mondo? La domanda è reale, non retorica. Si tratta di compiere una scelta di civiltà. La logica dell’efficientizzazione e del profitto punta allo sfruttamento della vita in tutte le sue forme, compresa quella umana. Come in altri momenti storici fu necessario lottare per la dignità del lavoro, così nel XXI secolo abbiamo una grande questione legata a dignità e libertà. Il digitale può essere amico della libertà, ma può diventarne il peggiore nemico.
Come sosteneva Martin Heidegger, la tecnica non è questione solo tecnica: è questione culturale, politica e soprattutto spirituale. Abbiamo davanti decenni in cui bisognerà lottare controcorrente per ricreare le condizioni per una vera libertà e democrazia. Occorre prendersi cura del pensiero, non solo di “far funzionare” i sistemi, e noi stessi. Se, come scriveva Paul Valéry, la crisi di civiltà è prima di tutto crisi spirituale, va immaginata oggi una nuova “politica dello spirito”, indispensabile per custodire l’umano nell’era delle macchine sempre più sapiens. Macchine celibi cerca di portare un contributo in questa direzione.
* Docente di Sociologia e Antropologia dei media all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dirige la rivista Comunicazioni Sociali – Journal of media, performing arts and cultural studies
Abbonati al mensile e leggi il numero completo
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0

































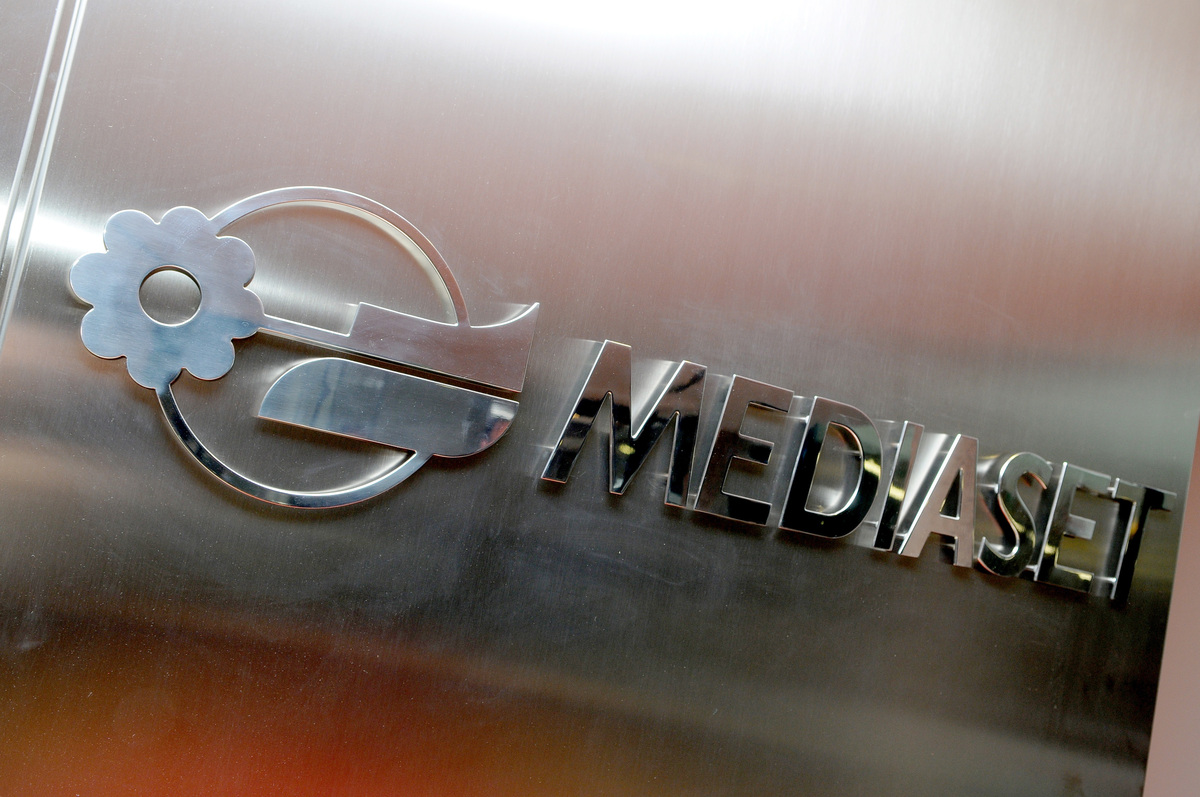























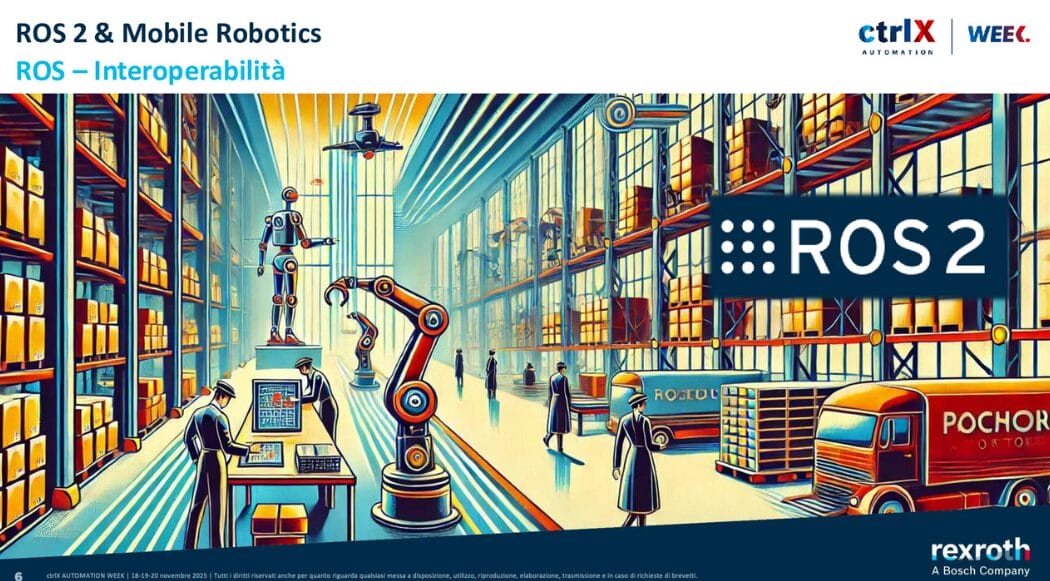











































































































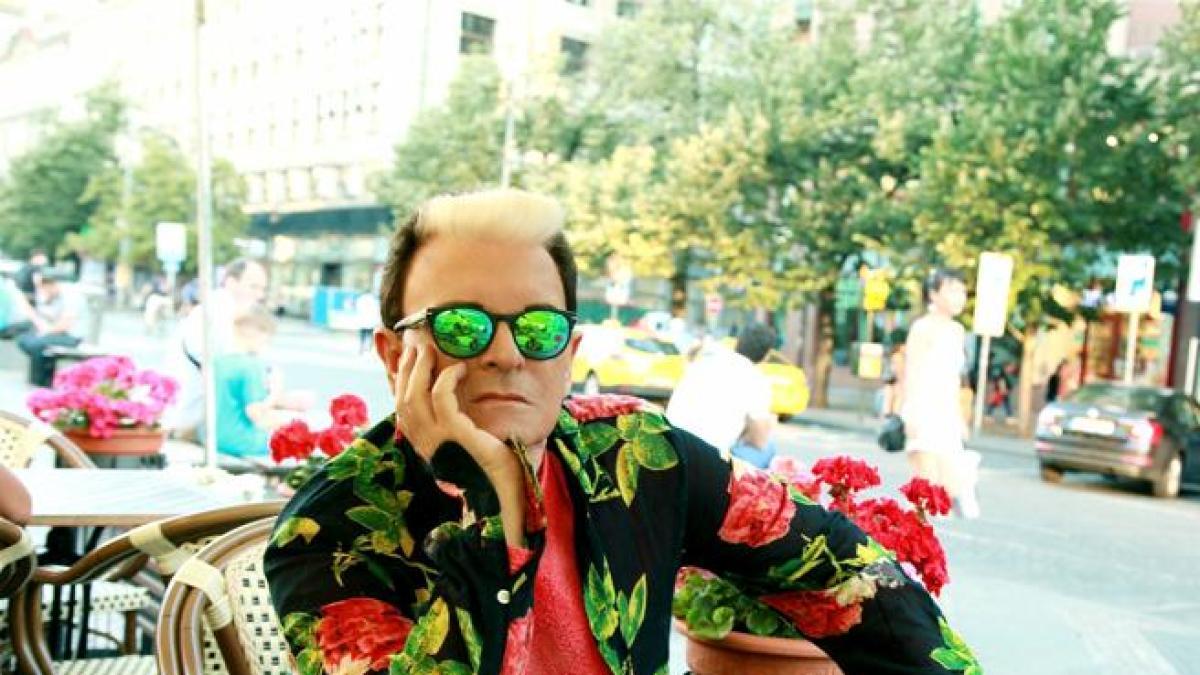

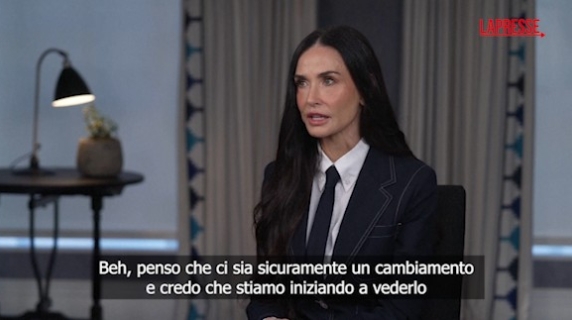




















-1754133631392.png--valerio_minato_svela_il_volto_in_movimento_del_monviso_sotto_le_stelle.png?1754133631616#)





















































